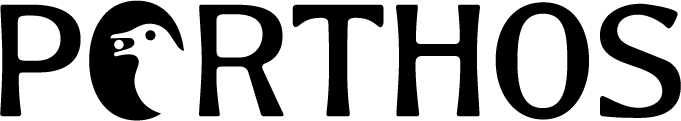09 Set Il ricordo di Giampaolo
testi di Sandro Sangiorgi a cura di Simona Abate
Domenica 29 giugno 2025 l’associazione Amelia Ciclopica che organizza il festival “Giganti in Collina” ha dedicato una conferenza alla figura di Giampaolo Gravina, studioso di Filosofia, cronista e divulgatore enologico, scrittore, innamorato di Sonia e della vita, scomparso il 6 febbraio scorso.
Ho avuto il privilegio di poter intervenire, e di questo ringrazio in particolare Giacomo Petrarca e l’azienda vinicola Zanchi per l’affettuosa ospitalità.
Ciò che potrete leggere racchiude sia il senso di quelle ore condivise con persone speciali sia le successive conversazioni sull’evento vissute con Simona Abate. Lei ha partecipato alla stesura dei testi e ha messo a punto una testimonianza accurata, così da non perdere nulla, neanche ciò che non è uscito durante l’evento.
Se ne vanno così quelli che scelgono di non stare al centro. Lasciano un vuoto che si avverte nei margini, nei sottintesi, nelle frasi interrotte. È accaduto anche con Giampaolo, che diffidava del centro per principio: non cercava la luce riflessa, ma l’ombra che dà profondità. Ci arrivava come il sangue ritorna al cuore, tra una stretta e un rilascio.
Il mio pensiero per lui giunge tardi, non per trascuratezza, ma in virtù della necessaria lentezza, utile a recuperare parole prossime ai sentimenti, chiusi da subito a ogni comunicazione a causa del trauma subito. E tale è stato per me perdere Giampaolo.
La nostra amicizia non è di natura intima, la definirei una reciprocità nata sul lavoro, in grado comunque di creare una forte vicinanza. Apprezzo le sue idee, che mostrano la trama invisibile della realtà e lasciano a ognuno lo spazio per arrivare da sé a coglierne il senso. Riconosce la mia capacità di aprire passaggi, di scavare in terreni duri, poco accoglienti. Lo vedo, e gliene sarò grato fino alla fine, impegnato nei momenti decisivi della mia carriera, mentre partecipa a serate didattiche guidate da me e a presentazioni di libri pubblicati da Porthos. L’invenzione della gioia attraverso un commovente intervento su Radio3 Suite durante una domenica pomeriggio dell’aprile 2011, ospiti di un altro compianto amico, Guido Zaccagnini. Poi alla presentazione de Gli ignoranti, il graphic-novel di Étienne Davodeau, nella quale Giampaolo si rivela protagonista di un evento speciale organizzato dall’Istituto per la cultura francese il 10 novembre 2015. E poi Il vino capovolto a Olevano Romano nell’ambito della manifestazione VinoIntorno il 17 giugno 2017.
Abbiamo condiviso convegni e degustazioni pubbliche. Il suo pensiero ha un’architettura capace di contenere anche le mie parole. Ricordo una volta a Taurasi: lui scrisse degli appunti che, senza saperlo, io avevo anticipato a voce al pubblico presente. Li confrontammo e fu una sorpresa clamorosa, una soddisfazione che ancora oggi mi porto dentro. Giampaolo, pudico, non parlava d’amore: lo lasciava trapelare nei gesti, nel modo in cui abitava il mondo.
Due anni fa, a Porthos, durante la degustazione verticale di un vino laziale a cui teneva molto, il Rosso di Podere Orto, sottolineò la consapevolezza agricola di chi resta, di chi vive nella terra e non si limita a prenderne il frutto.
Quella stessa visione la ribadì in un convegno nel 2024 dove, scoraggiando le domande su solforosa e temperature di fermentazione, invitava a riflettere sull’importanza del luogo in cui il vino nasce, un destino determinato dalla vigna e da chi la coltiva, altro che intervento in cantina.
Parlava con la stessa profondità di linguaggio e di vino. In una lettera su Enogea scrisse che «il punteggio non è mai al servizio del giudizio, è piuttosto una scorciatoia critica che contiene residui non solubili di arroganza e paternalismo». Per lui il vino richiede soste lunghe, uno sguardo capace di entrare nel suo lato più nascosto. «Tra le pieghe di quella intimità che il vino reclama». Aggiunge: «Il lavoro della scrittura si fa indispensabile».
Allo studio della Filosofia aveva unito la pratica della ristorazione, aprì un locale nel quartiere romano di San Lorenzo, si chiamava Uno e Bino. Anche lì coltivava uno sguardo libero. Quando lo conobbi era all’inizio del suo innamoramento per il liquido odoroso. Giampaolo capì presto che la crisi del vino era quella di un’agricoltura smarrita alla quale serviva un pensiero più ampio. Ripensandoci, mi torna alla mente una riflessione di Luigi Pareyson, un autore che Giampaolo amava citare: «Per vedere la natura come bella bisogna interpretarla, e interpretare è già amare». Queste parole descrivono la stessa bellezza che vedeva nel vino, non come ornamento ma come forma che prende vita.
Alla presentazione de Il vino capovolto, con un sorriso delicato mi disse: «Tu non li leggi i nostri libri, i libri dei colleghi». Aveva ragione. Gli dissi che temevo fossero più bravi di me, di trovarci già scritte le idee che io sentivo appena nascere. Annuì senza giudizio. Non fuggiva la fragilità: la riconosceva, la proteggeva. Diceva che senza fragilità non c’è pensiero vivo, né vino che valga.
Durante un incontro pubblico sul film Mondovino, esordì: «Vedrete, io e Sandro adesso ci strapperemo i capelli». La sala esplose in una risata (eravamo entrambi calvi).
L’ultima volta che lo vidi, pochi mesi prima che se ne andasse, mi confidò: «Alla fine, Sandro, non ce ne frega niente, lo sai, vero?». In quella frase c’era la libertà di chi non ha mai tradito sé stesso, e proprio per questo poteva respirare, anche davanti a certi assaggi in cui qualcuno, proprio in quell’occasione, pretendeva di decidere per tutti.
Per salutarlo, scelgo i versi di Giorgio Caproni.
L’ultimo viaggio
Quando saremo al termine del viaggio,
al termine del viaggio senza fine,
diremo che la meta era partire.
E rideremo allora, senza più volto,
del tempo che ci è corso accanto,
e della sua inutile fretta.
Post scriptum
Esiste un fondamento che sfugge alla percezione. È più intimo di noi stessi e tuttavia rimane inaccessibile.
Federico Faggin, progettista del primo microprocessore, lo definisce “campo”: realtà immateriale che si manifesta nel corpo, rendendoci veicoli di ciò che non possiamo vedere. Molto prima, Spinoza lo intuì con un concetto affine, il conatus: energia che spinge ogni essere a persistere, a distendersi oltre la materia provvisoria che lo ospita.
In questa trama invisibile esiste un senso dell’intero, che riguarda tanto noi quanto il vino che ci attende nel calice.
Avvicinarsi al vino è entrare in contatto con quella stessa spinta: significa varcare una soglia che ci porta oltre i sensi, dove la materia diventa ponte verso ciò che non misuriamo, ma sentiamo.
Il liquido odoroso non si concede subito. Veronelli lo sapeva: «I vini buoni cominciano sempre col rifiutarsi». Quel rifiuto non è barriera, ma invito a cedere il controllo e a lasciarsi guidare. Solo allora il vino smette di essere colore, odore e sapore e si ricompone in esperienza viva. Nel calice si apre, evolve, si trasforma. La sua imprevedibilità ci fa restare nell’attimo, dissolvendo l’illusione di permanenza. Non è difetto, ma insegnamento: la vita è movimento e ogni passaggio rivela fenditure di verità.
Degustare è disimparare. Il vino non è più oggetto da analizzare, ma soggetto che ci chiama. In questo fluire, il campo diventa esperienza tangibile, nel respiro del vino che vibra e ci attraversa.
Il vino non si esaurisce nei cinque sensi: li convoca e li supera, creando un equilibrio che chiama in causa un senso ulteriore, quello dell’intero.
Maurice Merleau-Ponty scriveva: «Non si può dire che io abbia un corpo, piuttosto io sono il mio corpo».