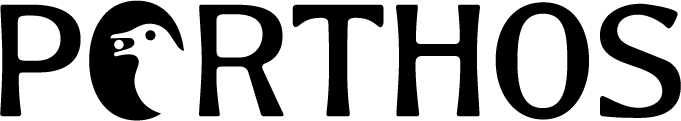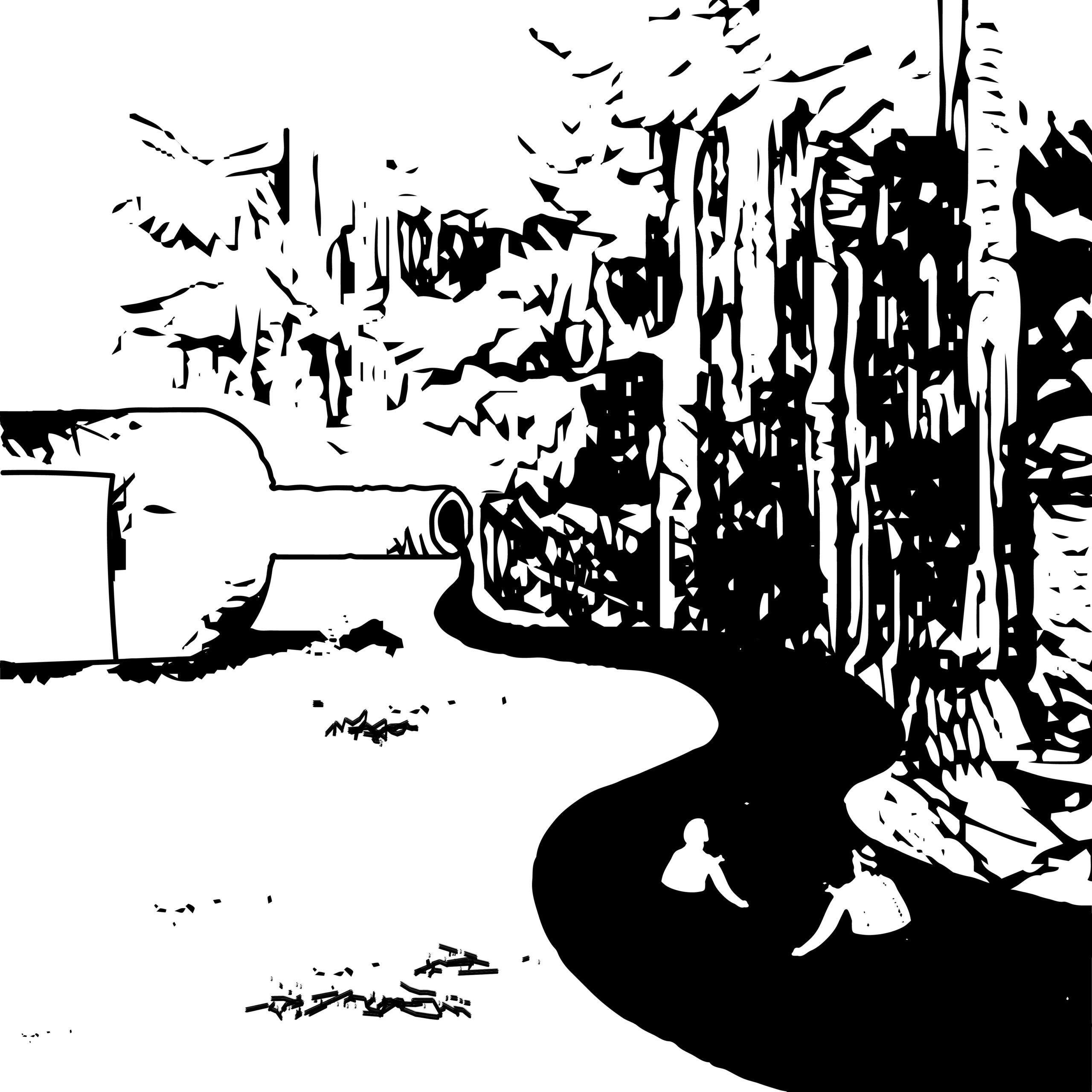
04 Nov Dialogo con Nicola Perullo
a cura di alice mazzali e matteo gallello
illustrazioni di selene baiamonte
L’intervista poggia su due incontri, entrambi avvenuti presso la sede di Porthos. Il primo, un incontro informale, si è svolto l’8 febbraio 2018, con Emanuele Giannone e Boris Tacchia. L’altra parte della conversazione è estratta dalla serata del 20 novembre 2018, la prima di “Dialoghi”, il seminario sul linguaggio del vino tra ragione ed emotività, a cura di Matteo Gallello, Emanuele Giannone e Sandro Sangiorgi. Abbiamo deciso di unire le parti senza soluzione di continuità.
Un grazie particolare a Emanuele Giannone per la partecipazione e a Boris Tacchia per il lavoro sui testi.
Sandro Sangiorgi: A un certo punto della tua vita hai deciso di scrivere questi due libri, Epistenologia I e II: lo hai fatto per una “necessità” o hai avuto la sensazione che ci fosse bisogno delle tue parole nell’universo del vino? Ogni volta che leggo un libro mi domando se realmente sia stato necessario averlo pubblicato. Me lo chiedo innanzitutto con i miei lavori ed è per questo che scrivo poco: ogni volta, pian piano, mi scoraggio. Ci vorresti motivare la nascita dei tuoi volumi?
Nicola Perullo: Parto dalla necessità di una ricerca complessiva, che coinvolge tutta la mia vita. Per me la filosofia non è un mestiere, è un modo di vivere. Sono un professore di filosofia, di Estetica in particolare, e ho seguito questa linea di ricerca per motivi personali. L’interesse per l’Estetica, poi, si è sviluppato nella passione per l’Estetica del gusto e in questo modo sono riuscito a unire la mia passione con lo studio. Da un certo punto, il cibo e il vino non sono stati solo oggetto di indagine e di riflessione ma mezzi per comprendere e per portare avanti anche il mio modo di vedere le cose. Il cibo e il vino sono stati dei prismi. Lo dico perché oggi ci sono molti studiosi per cui la gastronomia è una questione di moda e si occupano di questi temi come potrebbero fare con altri. Nel mio caso, invece, il cibo e il vino hanno seguito l’evoluzione delle mie idee, del mio sentire, del mio pensare. A un certo punto, intorno al 2010, questo percorso ha preso una direzione chiara e ho cominciato a lavorare al libro Il gusto come esperienza. Mi sono avvicinato al vino con te, nel 1993, e l’ho portato avanti per molti anni, sperimentando poi i Master Slow Food e Pollenzo. Il vino è diventato, per me, un amore.
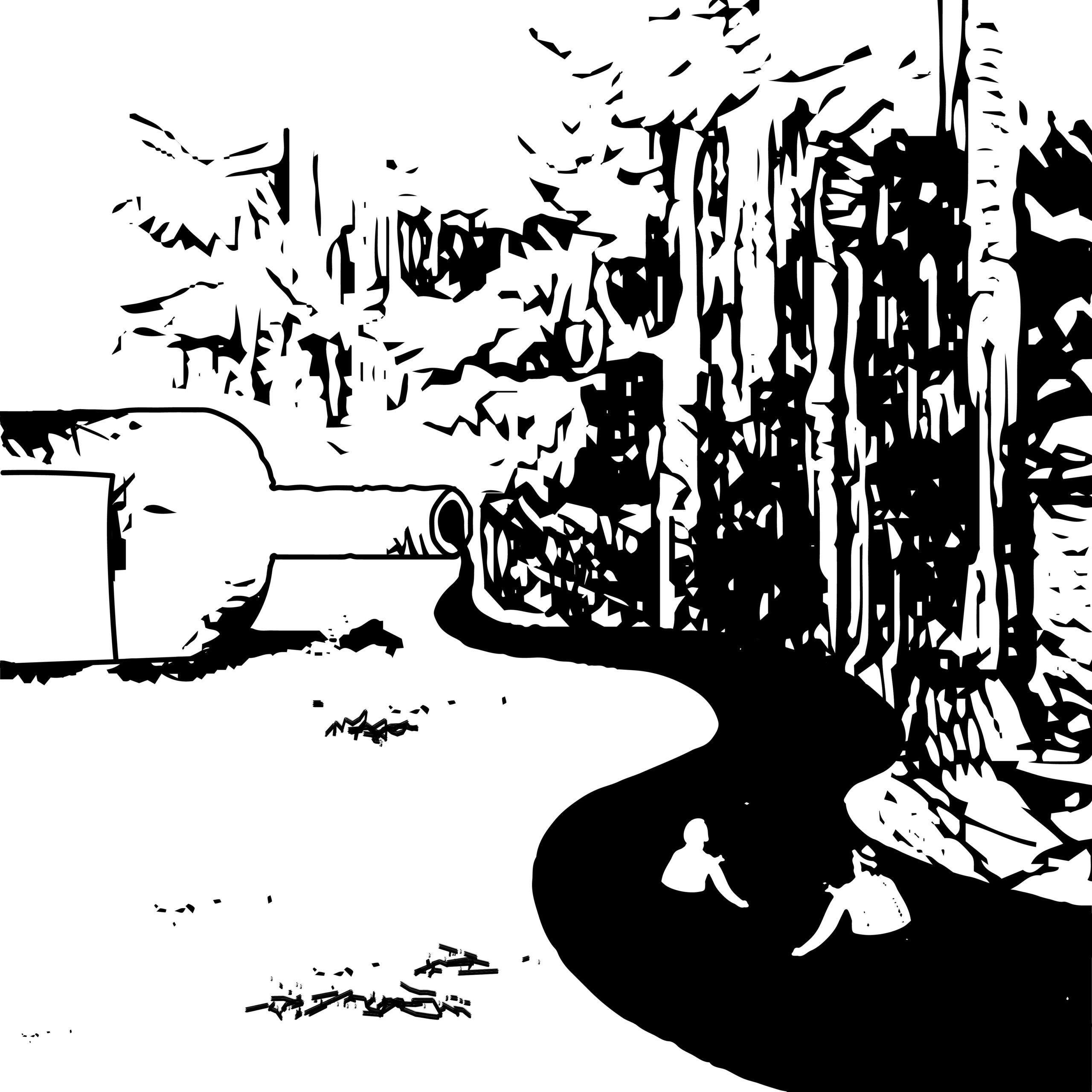
N.: È vero. Quando si è cominciato a parlare di vini naturali in modo più diffuso, cioè all’inizio degli anni duemila, ero tra quelli che mostravano perplessità: sai, io ero tra i tanti che…
S.: Eri tra i tanti che?
N.: Riteneva – sentiva – che i vini naturali erano sbagliati, difettati, avevano problemi. Quando ho iniziato a insegnare a Pollenzo nel 2004-2005 e l’università era appena nata, avevo ancora questa considerazione. Seguivo Porthos da lontano perché in quegli anni non ci siamo frequentati direttamente. In quel periodo ho conosciuto Luca Gargano di Triple A, frequentava Pollenzo in quanto amico di Slow Food. Lo vedevo alle manifestazioni e devo dire che oltre a te, Sandro, è la persona che mi ha più formato e dato stimoli per l’approccio che ho sviluppato più avanti. Ogni tanto mi faceva assaggiare dei vini naturali. Nel 2007, a cena con delle persone, ho bevuto vino naturale, un bel po’ in verità, eppure il mattino dopo avevo lo stomaco in forma. Mi sono chiesto: come mai sto così bene? Ho cominciato ad avvicinarmi a questi vini con una curiosità e un interesse legati alla facilità di beva della sera e al benessere della mattina. Da quel momento, con i miei studenti, ho iniziato un percorso didattico che ha portato a un progressivo mutamento degli atteggiamenti. Tutto questo è necessario per capire come poi si arriva a Epistenologia. Questo percorso accademico è legato a un’evoluzione culminata nel 2012 con la scoperta dei limiti della mia dimensione intellettuale. Ho ritenuto che la sfera razionale non fosse sufficiente per comprendere certe questioni. Tra l’altro subito dopo avere pubblicato Epistenologia I ho conosciuto Alejandro Jodorowsky, il che sembra una coincidenza ma in realtà non lo è…
S.: Non esistono coincidenze.
N.: Sono d’accordo. Quindi, dicevo, sono entrato in un orizzonte di scoperte e di ricerca su me stesso. Tutto questo è sfociato nel tentativo di avvicinarmi al vino in modo differente, con un approccio originale. È quanto mai indispensabile, all’interno dell’università, creare un percorso alternativo a quello “classico” dal momento che lavoro con studenti istruiti allo standard, all’analitico, al “bianco o nero”, all’oggettività della conoscenza. Penso sia importante muoversi in un modello che decostruisce ma propone anche un nuovo metodo esperienziale. Tu mi chiedi se fosse necessario scrivere Epistenologia I e II: io sono convinto che lo fosse e difendo la mia scelta.
S.: Necessario per la comunità?
N.: Sì, per la comunità. In questi anni si è sviluppata una diversa concezione del rapporto maestro-allievo, dell’idea dell’insegnamento e dell’educazione. Ho letto per la prima volta il mio nuovo libro proprio in occasione di questo dialogo. Anche se sono l’autore, ora è diventato interessante come lettore… è un’altra cosa.
S.: Sai, io ho bisogno di almeno quaranta giorni prima di leggermi.
N.: Io l’ho letto proprio ieri, in treno. Cito un paio di volte la Cina e l’Oriente. Il vino in questi luoghi viene dislocato in un contesto che è completamente diverso da quello d’origine. L’idea è di portare il vino su un livello veramente globalizzato, ma non nel senso del mercato.
S.: Quindi parli dell’idea di internazionalizzare il vino.
N.: Il vino è una bevanda universale perché deve essere limitato, anche nell’approccio, a un contesto occidentale americano-anglofono? Nella modernità il vino è stato chiuso in un modello forgiato da Inghilterra, Francia e Stati Uniti, ma questo è molto limitante, non è utile perché se la mettiamo su questo piano…
S.: Il binario è morto.
N.: Se la mettiamo su questo piano, c’è da considerare che il vino viene bevuto da una minoranza e al resto del mondo non importa nulla. E invece se il vino diventa un nuovo connettore…
S.: Non bisogna neanche arrivare a questo punto per giustificare la ricerca di contatto vero.
Emanuele Giannone: Nicola, quello del vino è un ambiente se non dominato, quantomeno fortemente caratterizzato dalla figura dell’esperto. Ci si sente in dovere di imparare a parlare di vino. Nei tuoi scritti ho trovato un’opposizione molto bella tra “essere esperto” e “fare esperienza”. Chi è l’esperto, a cosa serve? Qual è la differenza con il “fare esperienza”?
N.: Esperto, da experitus, vuol dire “colui che ha fatto esperienza”, quindi si riferisce a un’azione del passato. L’esperienza per definizione è qualcosa che si fa, experire vuol dire “stare per”, ha a che fare con il rapporto tra presente e futuro. È un paradosso che l’esperto sia qualcuno che ha accumulato esperienze perché “accumulare esperienze” non garantisce che si sappia fare esperienza. Fare esperienza vuol dire mettersi nella condizione di apertura rispetto a ciò che viene dopo, non rispetto a quanto c’è stato prima. Il che non vuol dire, però, elogiare l’ignoranza, ma stare in una situazione in cui sospendi, metti tra parentesi – come dicevano i fenomenologi – quello che sai. Se non lo fai sei bloccato, non riesci a essere aperto a ciò che ti si sta presentando. Pensi di sapere ogni cosa, quindi di poter presagire come un’esperienza sarà e a quel punto ti precludi l’autenticità della scoperta. A volte la condizione di ignoranza favorisce la possibilità di apertura, penso per esempio alla degustazione alla cieca, che in un certo senso toglie un peso. A volte l’esperienza passata è una zavorra e non è vero che impedisce di fare errori. Si dice “historia magistra vitae”, ma io credo che per certi aspetti sia una stupidaggine, altrimenti non si farebbero mai errori.
E.: Provo a forzare il discorso. Parliamo di esperto come persona avente, in virtù dell’esperienza acquisita, i titoli per pronunciare un giudizio, per certificare la conformità di un oggetto rispetto a una norma, uno standard. L’esperto che giudica, è opposto al dilettante (o amante o esploratore), che scopre. In un caso il valore dell’esperienza è nel giudizio, nell’altro il valore è nella scoperta. Sei d’accordo?
N.: Possono esserci esperti che non capiscono niente di vino, perché manca loro la sensibilità. D’altra parte nemmeno essere ignoranti, chiaramente, garantisce la sensibilità. Il contrario della competenza è per me la compassione. Competenza viene dal lessico giuridico, il giudice competente è colui che ha il suo spazio di giurisdizione. Chi è competente ha quindi il suo spazio, dove esercita il potere di giudicare. La compassione è il sentire con gli altri e quindi anche col vino. È sapere che i giudizi che si danno sono sempre relativi, contestualizzati.
S.: Che hanno una fluidità.
N.: Sì, che hanno una fluidità, che possono cambiare. Mi capita spesso di ricevere feedback da persone che hanno letto il libro e che avvicinandosi a questo percorso si sono sentite poi “liberate”. Epistenologia, che ha ricevuto soltanto la gentilezza di qualche recensione su canali online, ma non ha avuto nessun appoggio dalla filosofia “ufficiale”, né di altro tipo, ha venduto in due anni circa tremila copie, che è un numero altissimo per un libretto di questo tipo. Ed è stato venduto soprattutto grazie al passaparola. Questa per me è la più grande soddisfazione. Per fortuna non devo guadagnarmi da vivere vendendo i miei libri, perché ho un altro lavoro e quindi ho la libertà di scrivere. Molte volte editori importanti mi hanno detto: «ah fantastico, ma perché non fai un libro sul gusto più didascalico, didattico, introduttivo. Ci mettiamo a tavolino, studiamo l’indice e così poi lo scrivi in questo modo». Io non faccio i libri così, posso permettermelo.
S.: Due anni fa è venuta la BUR qui…
N.: Da me Laterza.
S.: È stato impossibile portare avanti il progetto.
N.: Devi lavorare con l’editor…
S.: Non solo per questo, ma anche perché le loro esigenze erano distanti dalle nostre. Sono venuti tutti: è venuta Mondadori, Bompiani, ogni volta tutti erano impressionati dal mio metodo, dalla mia libertà, dal fatto che prendevo per mano le persone. Dicevano di voler diffondere questo approccio attraverso un libro poi però, alla fine, io non mi accontento… Devo per forza fare qualcosa in più, guardare oltre, altrimenti sarei rimasto a L’invenzione della gioia. Quando strutturavo il progetto con loro immettevo degli elementi innovativi, che non venivano mai accettati. Una volta volevano un libro che parlasse in maniera semplice dei vitigni. Io allora ho detto: «Scusate, ma veramente non vi state accorgendo che stiamo tornando finalmente al luogo di origine? Voi invece volete il libro sui vitigni perché per qualcuno è più semplice? Non posso farlo solo perché mi promettete un certo reddito». Tra l’altro io faccio queste cose sempre perché Porthos possa avere una certa visibilità attraverso di me… però quasi mai funziona.
N.: Sul piano strettamente intellettuale per molti anni sono stato, credo, intelligente ma convenzionale. È come se fossi stato un vino. Io sono stato un buon vino convenzionale fino a qualche anno fa, poi sono diventato un vino naturale. Un vino imprevedibile, libero.
S.: La tua agricoltura è cambiata.
N.: Ecco.
E.: Nicola, come dicevamo, tra i tuoi scritti ci sono Epistenologia I e Epistenologia II, il cui sottotitolo è “il gusto non è un senso ma un compito”.
N.: Epistenologia vuol dire due cose. Nella lectio facilior, Epistenologia è conoscenza del vino. L’epistemologia è la teoria della conoscenza, sembra un gioco di parole ma in realtà è sottinteso un significato più tecnico, filosofico. Per me il vino è l’incontro col vino, non esiste il vino in sé. Il vino non è nulla senza l’incontro, inteso in senso più ampio, cioè culturale, sociale, comunitario. L’Epistenologia nasce dalla fusione di ontologia ed epistemologia. C’è chi dice che il vino è vino, cioè che ontologicamente la sua essenza è la stessa, indipendentemente da chi lo incontra. Io faccio parte di quei filosofi rigorosamente costruttivisti perché penso che non esista l’essenza senza l’incontro. Ho inserito la on di onta (quindi “essenti”) nell’epistemologia ed è venuta fuori Epistenologia. Questa è la lectio difficilior. Ci sono questi due nobili e antichi ambiti della filosofia, l’ontologia e l’epistemologia.
S.: Tu dici che non possiamo negare le proprietà che, in una relazione, ha ognuno dei due soggetti. È impossibile negare certe caratteristiche, per esempio una certa acidità nel vino che si sta bevendo. Tuttavia il sentimento è davvero importante. Prima, quando parlavi della figura dell’esperto, ho intuito volessi dire che questo ha una certa responsabilità tanto che, se non mette tra parentesi ciò che sa, non può aprirsi all’esperienza successiva. Per questo dico di assaggiare i vini alla cieca, per poter sperimentare, prima di sapere cosa si sta bevendo. Questo aiuta tantissimo a essere pronti ad accogliere, nonostante il peso del proprio sapere. È una libertà che è indispensabile concedersi.
N.: Facendo un’analisi storica, è possibile capire che la scomposizione del vino in vista-olfatto-gusto, è un sistema moderno. Nel periodo tra il Settecento e l’Ottocento, in Inghilterra – la grande patria degli esperti – le descrizioni dei vini erano lontane dalla separazione. Questo ci fa capire che parlare così di un vino è un fatto storico, una convenzione. Noi potremmo incontrarci dieci volte, usando sempre un certo linguaggio per parlare del vino, e alla fine potremmo renderlo uno standard. Se proviamo a descrivere il vino usando immagini, evocazioni, troviamo lo stesso tipo di schema che ci può unire e dividere. Potremmo creare un linguaggio simile a quello adoperato dalle scuole per sommelier, usando però descrittori ambientali, atmosferici, legati al carattere delle persone. Un po’ quel che facevano Veronelli e Soldati.
S.: E anche Monelli. Sai, nella dialettica del vino esistono moltissime tracce che si possono attraversare. Quello che distingue una narrazione partecipe, credibile, è proprio la spontaneità. Non si tratta però di spontaneità nel senso di soggettività all’ennesima potenza, ma di una partecipazione che ti aiuta a condividere quello che stai vivendo. Ci sono delle persone che, a volte, cominciano a scrivere di geometria del vino, poi di antropomorfismo del vino e così via, sempre in maniera poco spontanea. Dopo un po’ ti accorgi che il vino non fa la differenza, il racconto è così automatico da causare un allontanamento. Riuscire a essere liberi ha un costo, che è innanzitutto personale. Se si vuol essere liberi, infatti, non si può parlare di tutti i vini, bere tutti i vini. E non si può avere una parola buona per ogni vino.
N.: Epistenologia è nato come un progetto inclusivo. Per mia disposizione e per mie convenzioni filosofiche credo che l’idea dei linguaggi tecnici sia qualcosa di nefasto, in tutti i campi. Il vino è qualcosa di cui si parla “al momento”. Se si crea un linguaggio comune, una piattaforma, allora nessuno resta fuori dal discorso e il vino diventa inclusivo. Molti miei ex studenti, oggi, lavorano nel campo della comunicazione del vino dove provano ad applicare questo linguaggio con una logica commerciale, per “avvicinare” le persone. Comunicare non vuol dire scambiare informazioni. Comunicare deriva da comunis, mettere in comune. Comunicare è una situazione in cui si fa qualcosa di comune.
S.: Perché, secondo te, concetti così diversi come “mettere in comune” e “scambiare informazioni” finiscono per essere definiti da una sola parola, “comunicazione”?
N.: Il tema del “meccanismo” ha investito anche il mondo dei vini naturali. Dopo trenta presentazioni di Epistemologia I, nel 2016, quando hanno capito che non stavo al meccanismo per cui bisogna per forza dire, anche sui vini naturali, le stesse cose e cercare di interpretarli sulla base dei soliti schemi, non mi hanno più chiamato. A volte ci sono persone che reputano interessante l’aspetto emozionale nella descrizione del vino, però si aspettano che arrivi “la parte oggettiva”. Come a dire «prima ci si diverte, però poi c’è la parte seria, scientifica». Per me non è così perché la descrizione emozionale del vino è tanto oggettiva quanto quella in cui si parla di mirtillo, gelsomino, acidità o tannino. L’oggettività è qualcosa che si realizza, che si crea. In inglese si dice “facts are made”, i fatti sono fatti. Vuol dire che c’è sempre il tema dell’incontro, della relazione.
Una volta mi ha invitato la FISAR, erano tutti contenti dopo il mio intervento e alla fine il presidente ha detto «quindi, prima bisogna fare i tre livelli della FISAR, si imparano le basi oggettive, e poi ci si può dedicare a questo bellissimo gioco». Per me non è così.
Penso che alle persone normalmente piaccia essere schiave. I tentativi di liberazione da certi schemi portano le persone a chiedersi perché. «La vita è già difficile, ho un sacco di problemi, ho appena fatto il corso da sommelier e poi arrivi tu, che metti in discussione anche questo. Allora non ho certezze?». In generale percepisco la volontà di essere rassicurati e di avere una guida. Michel Serres, nel libro Il mancino zoppo. Dal metodo non esce niente, propone un tentativo di far filosofia che va al di là di certi schemi, non solo come critica decostruttiva. Propone un modo, un approccio, che è più simile a quello del frammento, più vicino alla poetica della circolarità, senza inizio e fine. Per me la filosofia – come dice anche Rocco Ronchi – è educazione, è un esercizio di educazione.
S.: Quello l’avevi detto e mi era piaciuto: educarsi a imparare…
N.: Esattamente. Educarsi è imparare a imparare, è un esercizio riflessivo. Per me la filosofia è educarsi andando fuori di sé, aprendosi e quindi facendo ricerca. È una sensibilizzazione. In questo senso si avvicina alle idee taoiste. I cinesi non hanno una filosofia, non concepiscono la filosofia come teoria. Nel mondo orientale cinese il taoismo e il buddismo sono una pratica di vita, non c’è una distinzione tra la filosofia e la vita. Non esiste l’idea che qualcuno creda in una teoria e nella vita faccia tutt’altro…
S.: Mi sembra molto occidentale questo meccanismo del fare, del praticare e poi predicare.
N.: Occidentale moderno, perché le scuole antiche…
S.: Al tempo non esisteva l’occidente.
N.: Certo.
S.: Quando abbiamo incontrato Rocco Ronchi (le interviste a Rocco Ronchi si trovano su Porthos 25 e 37), ad un certo punto lui ha parlato della filosofia come di una missione, intesa come incarico, come compito da adempiere ogni giorno con rigore e impegno. Riflettendo su questa affermazione, allora, pensavo a quello che hai detto prima, cioè che in fondo il vino è stato un mezzo per osservare l’umanità e raccontarla. Per cui ti lancio una provocazione e ti chiedo, come sarebbe se ci fosse un altro soggetto al posto del vino?
N.: Molte persone, soprattutto musicisti, dopo aver letto i miei libri, hanno trovato delle affinità con la pratica musicale. È capitato anche a qualche scrittore, che ha trovato delle somiglianze con la pratica della scrittura. Da un lato non credo che i miei ragionamenti sul vino siano validi solo per il vino, anche perché, com’è evidente da quanto abbiamo detto, quella del vino è una teoria complessiva. Dall’altro lato penso, però, che il vino abbia qualcosa di interessante da dire, di specifico, proprio perché è una sostanza psicotropa. È un alteratore. Essendo una droga, tecnicamente un alteratore di coscienza, apre le porte della percezione, acuisce la capacità immaginativa e funge da collante conviviale.
Il sottotitolo di Epistenologia I è “Il vino e la creatività del tatto”. Il tatto è inteso nel senso del gusto aptico. Io distinguo tra un gusto ottico e un gusto aptico. Il gusto aptico, per me, è quello che usa vista, naso e bocca come se fossero, appunto, sensi visivi tutti e tre. Questo discorso è legato, tra l’altro, a quello che asserisce l’oggettività della vista, considerata il senso più obiettivo perché senso di distanza. Da qui poi l’idea del degustatore che assaggia, sputa il vino, lo sente soltanto nella testa…
S.: Fermati un momento. In effetti i colori sono diventati sempre più distanti dalle persone…
N.: Esatto.
S.: Mentre invece i colori possono essere molto vicini.
N.: Il colore è diventato una forma. Il fatto di valutare il vino soltanto dal profumo, addirittura nei casi estremi solo dal colore, dimostra che manca l’idea di assimilazione completa. Il gusto aptico, da apton (che vuol dire tatto), è quello che possiede veramente questa dimensione di relazione fisica, di contatto profondo, dove il vino lo si apprezza non soltanto cerebralmente, ma anche nella pancia, come tu hai ben insegnato. Il gusto aptico, quindi, si sviluppa solo considerando il vino come vettore di ebbrezza.
Ecco, una volta mi è arrivata un’email un po’ macabra, dopo qualche mese dall’uscita di Epistenologia I, di una persona che diceva: «mi auguro che lei stia bene di salute tra uno show e l’altro. Mi permetto di allegarle questi documenti». Trovo due tabelle con la lista dei morti per alcolismo nel mondo e in Italia. All’inizio ho pensato non avesse compreso nulla del libro, poi però riflettendoci ho capito che mi poneva un problema intelligente, perché a volte si crede che chi è esperto di vino non si ubriachi, e invece sappiamo benissimo che uno dei tabù del degustatore è il fatto che ha problemi di semi-alcolismo.
S.: In effetti nella mia domanda c’era anche questo elemento sotterraneo di provocazione. Ho sempre desiderato fare l’insegnante, avrei insegnato volentieri alla scuola materna, però alla fine mi sono accorto che il vino aveva qualcosa di unico. Proprio l’altra sera ero con alcune persone che si stanno avvicinando al vino e ho detto: fate attenzione perché il vino è veramente speciale, e lo è anche perché ha l’alcol.
N.: L’ebbrezza è nuotare nel fiume e lasciarsi andare al flusso, restando però in uno stato di veglia critica. Tu sei nel fiume, ti lasci andare alla corrente, ma devi avere comunque la forza di nuotare, devi avere un minimo di consapevolezza. L’ebbro – dal latino ebrius – è chi è preso dal vino; l’ubriaco invece è colui che chiude le porte della percezione. Paradossalmente la situazione dell’ubriachezza è quella in cui il vino e il soggetto si distaccano. Il bevitore ubriaco diventa vittima dell’oggetto, e quindi non c’è più relazione. Se si diventa consapevoli del gusto aptico dell’ebbrezza, del suo valore al di là degli aspetti sensoriali gusto-olfattivi, col vino si possono fare molte cose. In questo senso allora, per rispondere alla tua domanda, penso che il vino non sia un mezzo qualsiasi, forse non è l’unico mezzo, di sicuro è estremamente interessante e bello.
Per esempio, alle fiere, tutti i produttori, qualunque sia il vino, dicono: «il nostro vino esprime il territorio. Il nostro valorizza il territorio. Noi dobbiamo rivalutare il territorio». Direi: che cazzo è il territorio? Fermati un attimo e definisci un territorio. A quel punto allora cominciano i problemi, perché la gente non sa nemmeno di cosa sta parlando. Allora la mia idea, probabilmente estrema, è: il territorio non esiste, il territorio si fa, così come il gusto. l territorio non è una fissità ontologica stabile e questo lo si può riscontrare facilmente sul piano fisico, chimico, climatico, geologico, microclimatico…
S.: Microbiologico.
N.: Anche antropico. Se vai a vedere come si fa il Barolo… Per quale motivo tu continui a chiamare Barolo un vino che è fatto in uno spazio che negli ultimi anni è cambiato moltissimo? Dov’è la continuità? Allora io propongo di non parlare di “espressione” del territorio, perché questa formula rimanda all’idea che un vino sia il rappresentante di qualcosa – il territorio – di fissato e chiaro.
S.: Questa cosa del “già dato” tu proprio non la sopporti, vero?
N.: Dovremmo dire “corrisponde al territorio” e non “esprime il territorio”. Penso proprio alla corrispondenza postale, che implica una domanda e una risposta, quindi una relazione. Quando un produttore fa un vino seguendo la storia e il percorso del luogo, rispetta la corrispondenza tra il vino e il luogo e, in qualche modo, dà vita a un pezzo nuovo di territorio. La terra è dinamica e cambia nello spazio e nel tempo. Sul piano pratico è interessante notare, poi, che tutte le Doc le Docg hanno sempre dei confini spaziali. E il tempo? Il tempo non lo considera nessuno. Il territorio è una delimitazione spaziale che viene dall’agrimensura, dalla proprietà privata del campo, ma tutti sappiamo che il vino si fa col sole, con la pioggia, col vento. Dove sono i confini? Ognuno ha il suo confine in verticale? Il territorio è spazio-tempo, latitudine e longitudine, quindi una serie di aperture e di intrecci…
S.: E di interazioni.
N.: E poi c’è la questione della cristallizzazione. È chiaro che, anche pensando al Barolo di quarant’anni fa, noi riconosciamo quello di oggi ancora come tale, perché si conserva una memoria in questa progressione processuale, in questa storia di relazioni, per cui siamo disposti a chiamare le cose, anche dopo molto tempo, con lo stesso nome. Nel libro faccio l’esempio di due persone. Se tu mi vedi tutti giorni è facile riconoscermi come Nicola, ma io cambio tutti i giorni. Eppure il cambiamento tra oggi e domani è impercettibile. L’altro giorno mi hai rivisto dopo tanti anni. Mi hai visto pelato e mi hai riconosciuto, seppur in una dimensione differente. Potresti aver avuto delle difficoltà all’inizio a riconoscermi, poi però i miei tratti ti hanno aiutato. Lo stesso vale per il vino. Il vino è, nel senso del nome, un percorso di relazione e di reticoli. Lo riconosciamo per somiglianza, ma se tu chiedi a un uomo di novant’anni di Barolo se il vino che beve oggi è lo stesso che beveva quarant’anni fa, dirà che è molto diverso da allora. Quindi perché lo chiamiamo Barolo? Riconosciamo dei tratti entro certi limiti, lì poi si aprono le negoziazioni e i dialoghi. Ecco in che senso il territorio corrisponde al vino e il vino corrisponde al territorio: in questa sorta di relazione. Il discorso, dietro il tema del territorio e del vino naturale, è anche politico. Tutto questo, a volte, è affrontato in modo conservatore. Lo trovo brutto… per me il vino naturale è anarchia.
S.: E quindi liberazione.
N.: È anarchia nel senso etimologico, cioè senza archè.
S.: Esatto.
N.: E quindi è il contrario dell’identità stabile fissa e definita.
S.: Infatti, quando incontro i produttori che ogni tanto mi invitano per assaggiare insieme i vini, la domanda ricorrente è: come facciamo a dare un’identità al nostro territorio? Io gli dico: «Ragazzi, non scherzate; se fate così, se pensate di poter fare così, voi commettete un errore gravissimo d’identità territoriale, perché rischiate di non tenere conto della diversità dei vostri luoghi».
N.: Sono loro l’identità, la stanno creando già in questo momento.
S.: Quindi non la devono andare cercare in un’espressione.
N.: Ecco perché nel libro dico che, se il territorio viene interpretato in questo modo, allora ha ragione il professor Moio. Se intendi il territorio come una cartolina è giusto usare i lieviti selezionati: perché a quel punto tu crei una specie di standardizzazione nel luogo stesso…

S.: Infatti, dove stiamo andando? Questa è una delle questioni più importanti. Quando faccio lezione non mi ripeto mai, perché il mio perenne tormento chiede che io mi rinnovi di continuo. Tutto mi influenza: la lettura, il dialogo, l’incontro con le persone. Un vino naturale è un’espressione non finita. Potresti chiedermi: allora è incompiuta? Il punto è proprio che nell’universalità c’è il non finito. E io lo sai che non ho strumenti filosofici…
N.: Sai, sto pensando al Dalai Lama: non è vegetariano in questo momento e alcuni buddisti sono stupiti. Gli hanno chiesto come mai non lo sia e lui ha risposto: «Lo sono stato per tanti anni, poi un giorno mi sentivo male, non stavo bene di salute; sono andato dal dottore e mi ha detto che dipendeva dal fatto che non mangiavo carne e allora ho ricominciato a farlo». Una riposta che sembra banale, ma che è l’essenza dello Zen. Vuol dire: «non ho precetti, non ho idee fisse». E anche nel linguaggio sul vino, io non ho precetti e idee fisse. A volte chiedo ai miei studenti di disegnare col vino, faccio raccontare il liquido attraverso metafore perché voglio spostare e dislocare, voglio portare il vino su un altro piano. Se poi domani tutti cominciano a parlare attraverso metafore e disegni, allora forse vale la pena riportare il discorso sull’acidità e i tannini. Voglio dire che è importante trovare un modo per dislocare, spostarsi e vedere sempre l’aspetto costruttivo e di prospettiva. A quel tipo di linguaggio non bisogna opporre un’altra verità, ma una consapevolezza della relazione e dell’incontro. È essenziale riuscire a osservare e a descrivere senza oggettivare. Questo secondo me è il punto centrale della questione. È quello che gli antropologi chiamano “conoscenza partecipata”. Nelle ricerche etnografiche, anticamente, si pensava che per comprendere una comunità indigena fosse sufficiente guardare come le persone si comportavano e poi fare il report. Poi si sono accorti che era essenziale vivere con loro e comportarsi come loro per un po’, spogliarsi della propria identità per mettersi ad ascoltare e comprendere. Non si può rimanere su un’ontologia che vuole stabilire identità o differenze. È come con gli animali: se tu vivi con un cane e sei in relazione quotidiana con lui sviluppi un’affettività. Viviamo di relazioni non soltanto tra umani, ma con animali, vegetali, minerali, con tutto. Ed è in questa relazione che si vivificano le sostanze, che tutti gli esseri viventi acquistano un’anima, una simpatia. Questa è la domanda ontologica che costituisce la differenza tra uomo e animale, tra uomo e vino. Vivi col Barolo e col Barbaresco e costruisci questa relazionalità. Anziché studiare la cosa, viverla vuol dire proprio questo! È il tema di Epistenologia: vivere col vino, parlare col vino, anziché del vino.