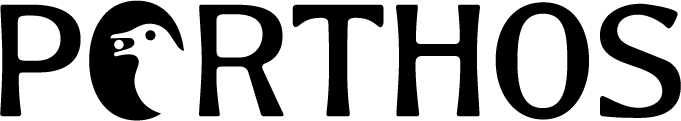24 Feb Miniature di Febbraio 2012
Cerco di dire ciò che sento,
Senza pensare a cosa sento.
Cerco di accostare le parole all’idea
E di non aver bisogno di un corridoio
Del pensiero per le parole.
Cerco di spogliarmi di ciò che ho imparato,
Cerco di dimenticare il modo di ricordare che mi hanno insegnato,
E raschiare la tinta con cui mi han dipinto i sensi,
Disimballare le mie vere emozioni.
Fernando Pessoa, traduzione di Luigi Panarese
“Porthos racconta…”
Colgo l’occasione per sottolineare un elemento di base della nostra attività didattica, la selezione dei vini. Non si tratta solo di scegliere bottiglie celebrate, rare e costose. Un aspetto che distingue da sempre i corsi e gli eventi di “Porthos racconta…” è la ricerca di esemplari utili alla formazione dei partecipanti, con particolare attenzione verso confronti, intrecci e paralleli tra denominazioni, terroir, annate e interpretazioni produttive.
Per noi è appassionante scavare tra i listini di importatori, enoteche e distributori per trovare il vino che esprima uno o più concetti che ci stanno a cuore. Non lo consideriamo un lavoro, ma un privilegio, anche in considerazione del piacere che ci restituite durante le lezioni.
Potete seguire la nostra attività guardando qui.
I vini naturali e la deriva verso una cronica imperfezione
Continua il lavoro di preparazione di Porthos 37. La nostra intenzione di portarlo alle manifestazioni dedicate ai vini naturali si è scontrata con la massa di informazioni da verificare, oltre che con la mole di schede e appunti da riesaminare, in modo da comporre il quadro completo delle cantine e approfondire le descrizioni organolettiche meritevoli di essere pubblicate. Contiamo di averlo pronto per fine aprile.
Questo tempo è utile per avere le idee meno confuse sul fertilissimo movimento delle aziende naturali.
Tra le impressioni che emergono più nette, ce n’è una che voglio condividere con i lettori di www.porthos.it. Molti produttori si stanno pericolosamente abituando a imperfezioni tecniche, più o meno gravi, considerandole peccati veniali o, ancora peggio, aspetti caratteristici dei propri vini – e sovente anche di quelli dei colleghi. Sentivo che sarebbe accaduto, tuttavia ho evitato accuratamente di crederci: dal mostruoso equivoco delle cantine convenzionali che firmavano appelli per sottolineare l’indispensabilità della chimica e della biotecnologia per definire vino il fermentato del mosto d’uva, stiamo passando al paradosso mostruoso di chi considera la competenza tecnica un ostacolo alla realizzazione del liquido odoroso, quasi che meno si sa e meglio si riesce. Non può consolarci che gli enofili francesi, a differenza di ciò che diffusamente si crede, si lamentino dei propri vini naturali, anche con maggiore intensità di noi. Esiste un problema di percezione e riconoscimento della qualità, aspetto da non confondere mai con la genuinità. Quest’ultima è parte fondante di un vino buono, tuttavia l’espressione «al vino non è stato fatto nulla», che giustifica puzze e instabilità, rivela quanto si sia lontani dall’etica di forma e sostanza. Il vino è una bevanda di piacere, dunque è contenuto e contenitore, carne e respiro, sangue e nervi, accoglienza e complessità, sogno e riflessione. Oltre che imparare a vinificare, maturare e affinare il frutto del proprio lavoro agricolo, diventa ineludibile educarsi alla degustazione, in modo da coltivare un senso di bellezza che elevi e non appiattisca tanto sforzo. Sembra incredibile, ma se i vini convenzionali hanno negato e stanno negando la restituzione del luogo, molti vini naturali la nascondono o la confondono tra le maglie di infezioni endemiche, grossolane riduzioni e un’inconcepibile mancanza di custodia.
Bruno Giacosa e Lucio Canestrari (e la SO2)
Ho avuto l’occasione di confrontare alcuni Barbaresco Santo Stefano di Bruno Giacosa e alcuni Verdicchio Gaiospino di Lucio Canestrari dell’azienda Coroncino con i rispettivi parigrado delle medesime annate: ’96, ’98 e ’99. Al di là delle sostanziose differenze tra i millesimi, più sensibili nei Barbaresco, e di quelle fisiognomiche, sebbene anche il vino marchigiano sappia fondere autorevolezza e sensualità, a colpire la mia immaginazione è stata la comune spiccata dialettica con l’ossigeno. Tale rara peculiarità appartiene ai vini che in bottiglia si trasformano e attraversano tutte le fasi vivendole integralmente; questi esemplari rendono fulgido ogni momento nel quale si donano. Con essi non ha senso parlare di zenit, di declino, di punto di non ritorno: hanno il potere di mostrare il proprio talento che asseconda il naturale fluire del tempo. Se i tappi hanno fatto il loro dovere – particolare per nulla scontato, purtroppo… – il Santo Stefano di Bruno Giacosa e il Gaiospino di Fattoria Coroncino si aprono senza indugi e continuano a modificarsi nel bicchiere, narrando chi l’impronta autunnale chi il timbro esotico. E quando il liquido finisce si ha la sensazione di non aver afferrato tutto, forse perché il concetto della totalità è impossibile da prevedere. Il loro assottigliarsi è sempre partecipe, non lasciano indietro nessuna componente: il giorno che moriranno, potrebbero scomparire in un lampo, in un soffio, in uno scampolo di Bach.
Con un amico abbiamo fatto delle rudimentali misurazioni dell’anidride solforosa, nulla di ufficiale, anche perché avremmo dovuto sacrificare bottiglie preziose e non ce la siamo sentita. Ebbene, abbiamo notato che rispetto ai parigrado, alcuni dei quali decisamente più immobilizzati dal tempo e quindi all’apparenza più longevi, la protezione della SO2 è meno ossessiva. Stabili ma non ibernati. Vivi e consapevoli che non saranno eterni, felici di essere sostituiti da altri egualmente interessanti.
Da febbraio 1997 a febbraio 2012
Sabato 4 febbraio 2012, ore 8: mi sembra di sognare. Esco per comprare il latte, sono circondato da un silenzio straordinario; mai la mia strada era parsa così muta. Né a Ferragosto, né a Pasquetta e neanche al mattino del Capodanno. Gli unici rumori sono i delicati passi di Luna sulla neve – vorrebbe nascondere un biscotto… – e il suono di un messaggio ricevuto sul telefono portatile: «Buon Natale! firmato: Gabriele». Entro nel negozio e Andrea Scorrano, proprietario di Pomarius con la sua famiglia, sta già ridendo. Gabriele è il Bonci di Pizzarium, per lui Natale è solo quando nevica. Tra una battuta e l’altra sulla follia di Gabriele, commentiamo l’eccezionalità della nevicata, ma soprattutto delle temperature che la stanno conservando. Inevitabile che il discorso vada sul loro lavoro di commercianti di ortaggi e frutta: «Adesso che succederà? È appena terminato lo sciopero dei trasporti, questa proprio non ci voleva… Vedrai i prezzi! ecc., ecc.». Andrea mi investe con tante considerazioni sulle abitudini dei cittadini consumatori, sul ruolo dei media e degli esperti, sull’influenza dell’industria e dei corsi di cucina, tanto che ho voluto raccogliere il frutto della sua esperienza in un’intervista, a cura di Gabriele Rocchetti e Matteo Gallello, che trovate qui.
Per quanto mi riguarda, quella mattina e nei giorni successivi ho ripensato molto al febbraio del 1997. Non sono sicuro che sia stato uno dei più caldi della storia, tuttavia non dimenticherò mai le lunghe giornate di luce e calore che portarono una primavera così anticipata da provocare delle gelate alla fine di marzo, per molti contadini altrettanto indimenticabili e fatali. Sebbene si parlasse del riscaldamento globale da almeno quindici anni, quel 1997 è considerato dagli enofili come la prima brutale manifestazione del cambiamento climatico. Vissuta subito come una stagione eccezionalmente positiva, quell’annata ha mostrato presto i suoi limiti e oggi sono pochissimi i vini superstiti, capaci di resistere a una precocissima e ingloriosa decadenza e meritevoli di essere seguiti e affinati.
Cosa rappresenta allora il febbraio 2012? Senza scomodare l’approccio olistico e le teorie poco allineate del professor Adriano Mazzarella (vedi Porthos 32 o vai qui) a sentire molti agricoltori la scorta d’acqua assicurata dalla neve sciolta lentamente è solo una piccola consolazione rispetto ad altri numerosi danni ricevuti. Ma si sa, i contadini sovente preferiscono mettere le mani avanti…
Ricordi
Ho conosciuto Marco De Bartoli a Latina, quando lavoravo nel ristorante di famiglia. Passava di lì per andare Napoli a prendere la nave per tornare a casa. Qualcuno gli aveva detto che in quella strana città c’era un ragazzo che amava il Marsala. Erano i primissimi anni ottanta e il vino più rappresentativo della Sicilia non se la passava tanto bene. Era inevitabile che diventassimo amici, a lui non sembrava vero che qualcuno amasse l’ossidazione e a me colpiva la cultura di quest’uomo che usciva dritto da un racconto di Vittorini, tanto era incazzato con il provincialismo della sua terra e dell’Italia tutta. Ho avuto la fortuna di godermi le sue tante prove, le interpretazioni alla ricerca di un Marsala più accessibile ai palati meno esperti, la conquista di Pantelleria e i tanti dolori che seguirono. Alla letteratura di Sciascia appartiene, invece, un altro ricordo. Ero in giro sull’Etna quando capitai presso un’azienda dove si teneva un convegno organizzato dall’Istituto regionale della vite e del vino, del quale De Bartoli era appena stato nominato presidente. Ebbene, Marco era sotto il tiro di un paio d’industriali che, con parole forti, già gli criticavano le prime scelte ispirate da una concezione agricola della viticoltura. Con la sua voce intensa li contrastò con un indimenticabile: «Mi chiamo Marco De Bartoli». I due siciliani in mia compagnia mi fecero notare che in Sicilia un’espressione del genere suona come un ammonimento, non è semplicemente ricordare il proprio nome e cognome, significa sottolineare di avere le spalle pronte ad accollarsi le proprie responsabilità, senza nascondersi. Ecco, se penso a Marco De Bartoli, rammentando anche tutte le volte che se la prendeva con me, vedo una persona incapace d’ipocrisie e sotterfugi. Per questo motivo, rimpiango di non aver saputo cogliere l’occasione di parlare con lui, soprattutto perché mi aveva offerto il giusto tempo e la dovuta calma. Marco De Bartoli è morto il 18 marzo 2011.
Pietro Marchesani (e Wisława Szymborska)
Pietro Marchesani è stato il traduttore italiano di Wisława Szymborska e di altri notevoli autori polacchi, come Zbigniew Herbert e Czesław Miłosz, oltre che direttore della facoltà di Polonistica all’Università di Genova. Avevo incontrato il professor Marchesani proprio quando aveva accompagnato la signora Szymborska a Roma, evento del quale trovate una breve cronaca qui.
In quell’occasione, mentre si creava una lunga fila di persone pronte a farsi autografare un volume dall’autrice premio Nobel nel 1996, mi ero avvicinato a Marchesani che stava illustrando a pochi intimi alcune cose del processo di traduzione. Era noto agli estimatori della poesia della Szymborska quanto lei considerasse un privilegio essere resa in italiano da Marchesani, vista la capacità del professore veronese di traslare il ritmo e la sonorità di composizioni tanto immediate quanto articolate. Mi colpì la disponibilità del professore di farci partecipi della propria competenza; accettò che gli scrivessi le mie osservazioni e curiosità, alle quali rispose sempre, aiutandomi a capire meglio quanto il suono delle parole possa dare qualità alla scrittura. Pietro Marchesani è morto il 29 novembre 2011, Wisława Szymborska lo ha seguito poche settimane dopo, il 1° febbraio di quest’anno.
[…]
Ogni inizio infatti
è solo un seguito
e il libro degli eventi
è sempre aperto a metà.
da “Amore a prima vista” di Wisława Szymborska, traduzione di Pietro Marchesani