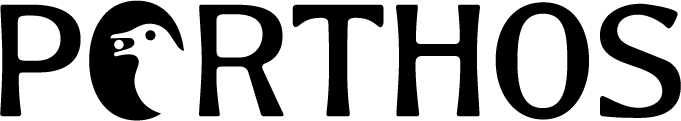27 Ago Estinzioni
Mi passano tra le mani il Verdicchio e il Fiano che duellano per chi dei due è “il migliore bianco italiano”; i romantici vini del Carso; il Barolo re dei vini, il Barbaresco vino da re; il Taurasi per intenditori e l’imprevedibile Mascalese dell’Etna. Tipologie didattiche perché esemplari, richiesti perché delineano profili e aprono i cuori.
Non mi sfiora nemmeno il pensiero che tali vini possano essere trascurati o abbandonati. Ma anche questi blasonati hanno attraversato problematiche molto gravi, basti pensare alla quasi totale scomparsa del Fiano irpino durante il periodo della fillossera. Alla sola idea mi tremano le gambe.

Intanto, passo venti giorni in un pezzo di terra all’interno del golfo di Squillace, una riserva di calore, paesaggi brulli che si alternano a boschi fitti. Dal mare è indispensabile salire per i 400 metri della collina, non ci si può sbagliare, la strada è semplice e breve con picchi di pendenza considerevole, la distanza è di soli sette chilometri. Le curve, lungo la salita, segnano il peso e la temperatura dell’aria.
La vegetazione è cangiante, i fichi d’India scompaiono e lasciano il passo agli uliveti, alle sugherete e poi ai castagni. Nelle gole che spezzano le colline passano le fiumare, mai completamente secche negli ultimi cinque anni. Paesaggi variegati e viste impressionanti: rilievi aspri che si inchinano di fronte alla profondità dello Jonio.
Qualche anno fa, durante la prima lettura di “Vino al Vino”, mi sorprese sapere che Mario Soldati, nel terzo viaggio del 1975, durante l’incontro con Pasquale Caruso nella cantina della sua villa a Sant’Elia, citava il Soverato e in particolare il Gasperina come vini provenienti da luoghi privilegiati.
Esordisce Caruso: «Una volta, cinquant’anni fa, a Catanzaro, del Cirò non si parlava mai. Il Cirò fu introdotto dopo la Seconda Guerra Mondiale: Gasperina e Soverato sono due villaggi, e due vini, sulle colline del golfo di Squillace».
Scrive Soldati: «Assaggio un bicchiere dopo l’altro di questi vini minori e li trovo di una classe nettamente superiore ai vini di Cirò. Vini di alta collina, e così buoni, forse, anche perché conservati in questa bellissima cantina, a 700 metri di altitudine. Mi annoto un Fego del ’58. E soprattutto un Gasperina del ’68: 14,50; rosso cupo; profumatissimo, rassomiglia a un Taurasi e quasi a un Barbaresco. Inesauribile, insondabile varietà dei vini italiani!1».
L’intervento del catanzarese Pasquale Caruso, allora produttore e commerciante di vini, evidenzia che era uso, al tempo, consumare le specialità nella loro zona di produzione. Quindi in virtù dell’abbondanza e la buona qualità dei vini dell’entroterra a sud del capoluogo calabrese, «del Cirò non si parlava mai», sebbene fosse già la prima e maggiore denominazione della regione.
Il punto è che oggi la fascia costiera compresa tra Gasperina e Soverato, a dispetto del pregio al quale accenna Soldati, è quasi completamente priva di vigneto. Rimane qualche fazzoletto di terra nelle zone di minore predilezione facilmente lavorabili, scelte perché non si può impiegare troppo tempo a condurre la vigna. Fino agli anni settanta sui pendii scoscesi a ridosso dei boschi, inframezzati da altre piantagioni erano coltivati terrazzamenti che, dicono i vecchi, davano un vino buonissimo. Basti pensare che nell’immediato dopoguerra si era creata una sorta di benevola competizione sulla qualità dei vini montepaonesi e gasperinesi.
C’era ricerca, pur sempre empirica e non mancavano mai motivazione e impulso. Oggi tra le mille anime dell’arroccato Montepaone, il paese nel quale sono cresciuto e che si trova proprio a metà strada tra Gasperina e Soverato, si è perso il sapere. Si sono dileguate la già fragile conoscenza ampelografica e l’eredità della pratica agronomica.
La generazione dei miei nonni ha passato la mano a quella dei miei genitori per i quali coltivare la vigna è ormai solo un passatempo. A questo punto meglio comprare le uve dalla Sicilia, se non il mosto, l’attrezzatura per vinificare c’è già, è il caso di non farla arrugginire. Quindi arrivano da queste parti Nero d’Avola e Grillo ben solfitati e di bell’aspetto pronti per essere vinificati da soli o utili a tagliare gli ormai deboli liquidi locali, tanto se non parte la fermentazione il consorzio agrario consiglia lieviti ad hoc.
Cosa c’è oggi nelle nostre vigne? Varietà scadenti che presero piede nei primi trent’anni del Novecento. Le chiamano uve “d’o’ Cummentu”, del Convento, oppure in modo sin troppo generico “uva francisi”. Mio nonno, classe 1923, racconta che un frate in quel periodo arrivò da queste parti con alcune barbatelle di viti sconosciute agli autoctoni. Vennero accolte e impiantate in tutto il vigneto circostante perché precoci e molto produttive, anche se col tempo ci si rese conto che il vino era fiacco. E ironizza: «Non diventava nemmeno aceto!».
Ma la soddisfazione di vedere il frutto abbondante e la facilità di allevamento facevano dimenticare le lacune di quel vino, tanto si beveva tutto. Se in un primo momento alcuni si opposero, la maggioranza dei contadini iniziò volentieri la conversione, estromettendo dalle vigne il greco nero, il gaglioppo e la malvasia nera.
Da questa fase già declinante non ci si solleverà più. Negli ultimi trent’anni la tendenza è il quasi totale abbandono della lavorazione agricola non solo nella coltivazione della vite e del grano, ma anche nella cura dell’ulivo e dei boschi, così preziosi per armonizzare le varie colture. Persino gli allevamenti ovino, caprino e suino, così indispensabili all’economia locale, si stanno perdendo.
I passaggi mi appaiono chiari e sono comuni a molte zone italiane: dalla coltivazione “eroica” di uve antiche in luoghi difficili e di qualità, alla sostituzione di queste varietà con altre maggiormente produttive piantate in luoghi più semplici da coltivare e meno vocati, alla ormai irreversibile fase dell’abbandono.
Si assiste all’estinzione di una zona vinicola dal valore inequivocabile. E con lei se ne va un altro pezzo della storia antica del vino di Calabria. Tra venti anni nella migliore delle ipotesi, i pochi sessantenni di oggi, già con esigui e per buona parte sbagliati criteri produttivi, rinunceranno a condurre il vigneto e le altre colture. Non sembra nemmeno avere spazio la domanda: «Chi coltiverà le nostre vigne?».
1 Mario Soldati, Vino al vino. Alla ricerca dei vini genuini, Mondadori, Milano , 2009, p. 500