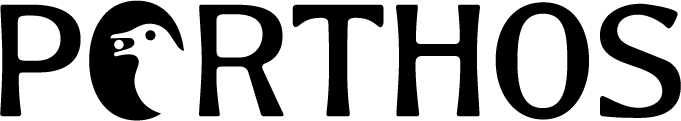21 Ago Licinsì, intervista a Pierluigi Marini
Intervista a Pierluigi Marini, creatore e fondatore di “Licinsì una scelta artigiana”, piccola distribuzione dedicata alla ristorazione, sempre in costante, naturale e lenta evoluzione alla ricerca di cibi e vini “d’origine”, artigianali e unici.
Inizia il suo percorso nel mondo del vino lavorando come Sales Manager e assistente alla produzione in un’azienda biodinamica. Nel 2014 fonda Licinsì, con l’intento di dare forma a una visione più autentica di sé stesso. Decide di utilizzare il commercio come strumento di azione sociale, rifiutando le logiche illusorie di un mercato che conosce bene e ha vissuto in prima persona.
Per farlo, sceglie di proporre quelli che chiama “Vini d’Origine”: espressioni autentiche, nate dall’interazione armoniosa tra vitigno, ambiente, uomo e cultura, valorizzate ogni anno dall’unicità dell’annata.
S: Caro Pierluigi, alla fine non mi hai aggiornato sull’andamento dell’annata 2022 di Ravarini, in particolare sull’A, il suo ancestrale.
P: La 2022 è stata molto simile alla 2021. Entrambe hanno avuto un residuo zuccherino elevato e una volatile molto alta.
S: Però il 2021 mi è sembrato più coeso, mentre il 2022 lo trovo più dispersivo.
P: Hai ragione, il 2021 si sta integrando meglio. La 2022 non è ancora in vendita proprio perché ha parametri ancora più spinti. Stiamo aspettando per darle tempo di affinarsi. Ma ti assicuro che la volatile e lo zucchero si bilanciano bene in entrambe.
S: A proposito di volatile, un enologo trentino mi disse che con il tempo si “balsamizza”: non si riduce, ma si armonizza nel vino. E la pulizia delle botti può aiutare a tenerla sotto controllo, ad esempio con l’ozono.
P: Verissimo. Ma nel nostro caso la volatile non deriva da problemi di igiene o botti, che tra l’altro non usiamo. È piuttosto un rischio che ci assumiamo volontariamente imbottigliando in fermentazione. In quelle condizioni è difficile fare misurazioni precise… ma curiamo sempre di più i dettagli per arrivare allo spumante che vogliamo: vero, senza aggiunte o sottrazioni, accettandone anche l’imprevedibilità.
S: Fra l’altro, sei anche direttore commerciale di Ravarini, giusto?
P: Sì. Con Gigi c’è stata da subito una grande sintonia e fiducia reciproca. Le nostre competenze sono complementari: io seguo tutta la parte strategica e commerciale. In passato gli ho dato una mano anche sulla parte enologica, ad esempio nella gestione della solforosa e nella selezione delle vigne. L’A è uno spumante che ci permette di ottimizzare il lavoro e aumentare leggermente la produzione, pur rimanendo su numeri piccolissimi. Ma soprattutto è una sfida: tentare di produrre forse l’unico spumante in Franciacorta davvero privo di qualsiasi intervento.
S: In effetti, un vino del genere è raro da trovare, specie in Franciacorta…
P: Praticamente impossibile. Qui lo standard è correggere. Sorrido se penso che sembra avere l’autotune: se si hanno uve mature aggiungere acidità, se sono acerbe togliere astringenza. La raccolta è spesso anticipata, e si lavora con cinque o sei additivi e coadiuvanti enologici per arrivare al risultato.
Ravarini non corregge nulla. I suoi spumanti hanno carattere, si distinguono per complessità e ricchezza aromatica, in contrasto con molti altri che, puntando esclusivamente sull’acidità per facilitare la beva, finiscono per assomigliare più a bibite.
S: Tra le aziende che distribuisci, ce n’è qualcuna che oggi fatica più delle altre?
P: Nessuna in particolare, ma è vero che le zone meno conosciute soffrono di più. La Franciacorta, essendo un brand forte, regge bene. Il problema, spesso, è che non si beve il vino che ci parla, ma quello di cui si parla.
S: Hai notato cambiamenti nei gusti?
P: Sì. Cala la richiesta di rossi, crescono bianchi e vini giovani, leggeri, poco alcolici. È un riflesso delle abitudini alimentari e di consumo. I vini più strutturati spaventano, ma credo sia una tendenza passeggera… e anche un po’ di superficialità nella degustazione.
S: Questa trasformazione nei gusti del pubblico mi riporta agli anni ottanta e ai primi novanta, quando i rossi più strutturati e complessi passarono di moda a favore dei bianchi. In quegli anni, in Piemonte si registrarono quattro annate straordinarie — 1985, 1988, 1989 e 1990 – eppure i rossi di quelle vendemmie vennero venduti a prezzi molto bassi. Paradossalmente, nel 1995 i produttori di Langa aumentarono i listini con l’uscita dei rossi del 1991, nonostante si trattasse di un’annata nettamente inferiore alle precedenti.
Dal tuo punto di vista di distributore, stiamo vivendo oggi una crisi nel consumo e nell’acquisto del vino?
P: Il consumo cala, anche nel mondo del vino naturale. Ma più che una crisi del prodotto, è una crisi del settore: ristoratori e operatori faticano a evolversi, studiare, capire. Se non si conosce un vino, non lo si sa raccontare. E quindi non si riesce a valorizzarlo.
S: Parlando del tuo percorso, provieni dal mondo industriale. Quando hai scelto di intraprendere la strada dell’artigianalità?
P: A 28 anni ero direttore commerciale di un’azienda importante, con famiglia e una carriera solida. Ma mi mancava qualcosa, nonostante tutto fosse “a posto”. Non volevo perdermi in un ruolo che non sentivo più mio. Una notte, in un bungalow in Corsica, tra una sigaretta e un bicchiere di whisky, ho messo su carta le mie idee. Ho deciso di fare i conti con me stesso e creare un progetto che avesse senso per me e fosse utile socialmente. Così ho mollato tutto e mi sono avvicinato all’agricoltura con l’idea – forse poetica – di ricominciare.
S: E così è nata Licinsì?
P: Sì. Licinsì in dialetto bresciano indica la piccola licenza che il Comune concedeva a chi vendeva l’eccedenza dell’orto o della stalla, trasformando una stanza della casa in un punto di vendita e socialità per un periodo di 15- 20 giorni. Qui si potevano consumare salumi e formaggi, giocare a carte e alla morra. Era un concetto simile alle Osmize del Carso. L’idea era di valorizzare le artigianalità del mio territorio e di offrire ai piccoli produttori un supporto reale, non solo commerciale.
Nei primi anni ho anche lavorato in vigna e in cantina, per conoscere meglio ciò che volevo raccontare. Questo mi ha insegnato il valore del lavoro artigiano e del giusto compenso.
S: Che ruolo ha avuto la Franciacorta nella tua scelta di cambiare vita?
P: Nel momento in cui ho deciso di intraprendere un nuovo percorso, è emerso con forza il mio legame con la Franciacorta, il territorio in cui sono cresciuto. Avevo la sensazione che me lo stessero sottraendo, trasformandolo in un semplice marchio vinicolo. Eppure, la zona è sempre stata molto più di questo: un mosaico di piccole produzioni, salumifici artigianali, agricoltura, comunità locali. Ho sentito una responsabilità: restituire valore al territorio anche da prospettive diverse.
S: Prima di lanciare il tuo progetto, hai lavorato da 1701, la prima cantina biodinamica della Franciacorta. Che esperienza è stata?
P: Anche se breve, mi ha introdotto al mondo della biodinamica e del vino naturale. È stato un momento di crescita professionale e personale, in cui ho maturato una convinzione profonda: per me, il vino autentico può nascere solo da un lavoro artigianale, mai da un approccio industriale.
S: Cosa ti distingue dagli altri distributori?
P: In estrema sintesi, ciò che mi distingue sono lo scopo e il metodo. Lo dico spesso, anche ai miei clienti: se fosse possibile, tutte le pseudo-distribuzioni artigianali e naturali – compresa la mia – dovrebbero chiudere domani mattina. Perché? Perché solo così i produttori tornerebbero a proporre direttamente i loro vini ai ristoratori, e questi ultimi ricomincerebbero a cercare, a scoprire, a interrogarsi. Ne nascerebbe un fermento nuovo, autentico.
Provocazioni a parte, per me nella vendita serve trasparenza, perché è la prima azione sociale attraverso la quale manifestarci. Poi, c’è il metodo di selezione. Prima di iniziare a lavorare con una regione ho bisogno di conoscerla a fondo. Faccio questo mestiere da dieci anni e seguo dieci aziende vitivinicole: una per ogni anno, una per ogni territorio.
È il mio ritmo, ed è una scelta precisa. Ogni anno vado a turno in vendemmia, perché non mi fido ciecamente nemmeno dei produttori. Voglio toccare con mano: assaggiare l’uva al giusto grado di maturazione, sentire i mosti, osservare le fermentazioni, vivere la cantina.
Devo studiare quel territorio, starci per un po’, mangiare nei ristoranti, parlare con le persone, ascoltare, osservare. Poi torno a casa con una visione chiara, che metto ancora una volta alla prova: nel bicchiere, insieme ad altre persone, con esperienze e culture diverse. Solo a quel punto posso iniziare a raccontare e proporre quei vini. Senza questo lavoro profondo, la distribuzione non ha nulla di artigianale. Chi vuole i miei vini, deve prima assaggiarli. E capirli. Servono tempo e fatica. Fare davvero selezione significa essere presenti, significa vivere questo mondo. E ciò comporta, inevitabilmente, dedicare meno giorni alla vendita intesa come compilazione di un ordine.
Al contrario, molti distributori scelgono una via più veloce e industriale: agenti, reti commerciali, marketing. Funziona, certo. Ma è un altro mestiere.
S: E sull’aspetto più freddo, quello economico e del prezzo, come ti approcci o quanto conta?
P: È un argomento che avete trattato approfonditamente sul Paper dedicato. Se mi pongo nella posizione del consumatore trovo ridicolo e talvolta mi fa incazzare che oramai i vini di alcuni produttori che incarnano valori di socialità, sostenibilità, piccolo artigianato, bla, bla, bla… possano permetterseli solo gli industriali o i ricchi!
Da distributore invece non mi interesso del prezzo in sé ma creo le condizioni perché ci si educhi a vicenda tra produttori, intermediari, operatori. L’unico che può dare un valore economico è il produttore, il quale deve conoscere e rispettare le figure del mercato a cui rivolgersi. Credo di essere l’unico distributore a fare un prezzo di listino e con finalità educative. Il prezzo sorgente, ovvero il prezzo del produttore, ovviamente con delle condizioni di acquisto minime da operatori non da appassionati della domenica.
S: Prima di concludere, vorrei tornare sul tema della crisi del vino. Mi interessa molto il tuo punto di vista. C’è un consiglio che vorresti dare alla tua categoria?
P: Prima di tutto, direi che serve chiarezza: è fondamentale dichiarare apertamente qual è il proprio scopo e, di conseguenza, chiederci quanto siamo disposti a sacrificarci per rimanere coerenti con le nostre scelte. Un piccolo artigiano, in realtà, non conosce né crisi né abbondanze: la sua quotidianità è fatta di fatica, complessità e incertezza. Quello che invece vedo è poca collaborazione tra i distributori e scarsa volontà di crescita culturale. Si parla dei vini in modo superficiale, da collezione di figurine. Si vuole essere i guru del momento e si dà pochissimo spazio a momenti guidati e condivisi, nei quali anche grazie al vino scopriamo noi stessi. È proprio questa mancanza di approfondimento a generare la crisi, un problema culturale, prima ancora che economico.
Inoltre un cortocircuito nasce dai “miti” a cui il consumatore medio si affida – o, peggio, di cui sembra aver bisogno. Come diciamo noi: “spiegami il giro del fumo”. In pratica, da capitali e prodotti industriali, perfettamente allineati a logiche di profitto, nascono distribuzioni “mitiche” che si definiscono naturali o artigianali. Queste poi affidano ad agenti poco preparati il compito di vendere poesia ed emozioni a provvigione; tali mediatori, a loro volta, si rivolgono a ristoratori o professionisti poco formati, rassicurati però dal fatto che il brand li
tutelerà. Il messaggio che arriva al cliente finale è vuoto, sterile, consumistico, privo di contenuto. Tale approccio può funzionare nell’industria, dove tutto è basato sulla performance. Ma non nell’artigianato. Io, in tutto questo, non ci vedo né poesia, né emozione, né professionalità, né sostenibilità. Nessun fermento. Nessuna rivoluzione. Solo una dinamica commerciale aggressiva, che sfrutta l’ingenuità e l’ignoranza di chi si trova all’ultimo anello della catena.
Il valore non sta nella confezione o nel prodotto in sé, ma in come quel prodotto viene condiviso. Il valore, quello vero, non ha prezzo: si trova nel modo in cui ognuno riesce ad arricchire gli altri attraverso il proprio lavoro.
Anche solo con un assaggio di vino.
Serve educazione, per tutti: distributori, produttori, ristoratori, clienti.
S: Direi che possiamo fermarci qui. Ti ringrazio per la chiarezza con cui hai affrontato ogni tema e per aver esposto le tue idee senza esitazioni, offrendo anche spunti molto concreti.
P: Sono io a ringraziare te, prima di tutto per le scelte che hai compiuto nella tua vita, e per lo spazio che mi avete concesso. Mi permetto di chiudere parafrasando un intervento di Roland Barthes, peraltro presente sia sulla rivista Porthos, il numero 4, sia su L’invenzione della gioia. Il filosofo e semiologo prova a definire un evoluto sforzo culturale cercando di spiegare che cosa è la Sapientia: «[…] Nessun potere, un po’ di sapere, un po’ di saggezza e quanto più sapore possibile».