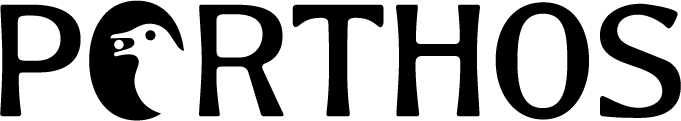06 Set Il Granchio
“Ci incontriamo in cucina, o in soggiorno, la mattina. Niente di più. Non dormiamo insieme da quindici anni”.
La barba folta sale e pepe stava già cominciando ad ungersi col sugo di granchio. Un bavaglino da grandi, di carta morbida, gli era stato legato intorno al collo e al torace – lì con un po’ di difficoltà vista la mole – dalla gentile proprietaria, una piccola donna cinese di grande classe e eleganza. Sembrava lo sparato di un orchestrale accanto alla giacca scura, a coprire la cravatta elegante e la camicia a righine blu. Gli occhi gli avevano brillato mentre ingurgitava le capesante e i ravioli al vapore. Era un baluginare derivato dal palato sicuramente, ma anche dalla grande voglia di farsi bastare il cibo per la mente e per il corpo. Di cibo ne sapeva tanto, sapeva lavorarci sopra con arguzia.
Il granchio era grande, rosso, sembrava laccato. Una delle chele già sminuzzata con le apposite pinze, era finita nella bocca golosa di quella barba nera e bianca.
“Qualche anno fa ero dimagrito quindici chili. Lo avevo fatto per lei. Mi tormentava dicendomi che facevo schifo con quella pancia, che russavo, che ero inguardabile. Che aveva smesso di fare sesso con me perché non gli piacevo più”.
Quelle piccole mani un po’ tozze ma delicate come quelle di un bambino paffuto manovravano le pinze come fosse stato il loro mestiere principale, schiacciando delicatamente per l’intera lunghezza la chela, per estrarre poi con le dita unte la polpa saporita.
“Alla fine la gente non mi riconosceva quasi. Dicevano: “Ma stai male? Perché sei dimagrito così?”. Io all’inizio pensavo… speravo in un premio (ho lavorato tanto, mi sono impegnato, ho smesso di viaggiare per lavoro, ho rinunciato alla cosa che amo di più – dopo lei – il cibo, qualcosa mi arriverà: una carezza, un bacio, forse una notte d’amore…), ma non arrivava niente”.
Il cameriere col grembiule nero che una fettuccia larga sulla colonna vertebrale rendeva molto “cinese”, si avvicinò gentile: “Va tutto bene? Lei, signora, vuole partecipare alla “grande bouffe” del signore? Le porto altre pinze? Un altro bavaglino?”. Il cameriere, elegante e con un leggero accento straniero che non guastava sul viso affilato e intelligente, doveva avere lavorato tutto il giorno e sentito un gran caldo, perché si portava dietro un pungente odore di sudore…
Ora, lasciata la quarta chela per ultima, le manine si industriavano con l’uncino a scavare e frugare nel carapace del granchio. Lo spolpavano con arguzia e metodo, una mollica di polpa dietro l’altra.
“Una mattina mi guardo allo specchio e non mi riconosco. Chi è quell’uomo troppo magro, insignificante, con quella barba incolta sull’ovale diventato oblungo? Sta male?”. Lei non mi degnava di uno sguardo, di una parola, non mi aveva nemmeno detto “bene, vedi che ce la fai a trattenerti dalle abbuffate?”. Niente di niente. Il mio letto restava vuoto, tutte le notti, una notte dopo l’altra. Mi potevo divertire a russare con tutti i toni e le modulazioni che volevo, tanto lei non mi sentiva, chiusa nella sua stanza dall’altra parte della casa, col televisore acceso e la macchina da cucire sempre in movimento. Ero solo. Più solo di così, mai stato. Non riconoscevo più nemmeno il mio riflesso nello specchio. Uscii e andai nel primo ristorante, mangiai quasi tutto il menu proposto. Con gusto. Soddisfazione. Senza pensare al risultato delle analisi che mi avevano riportato il fegato di un bambino, perfetto, pulito”.
Prese il riso bianco che il cameriere aveva portato a condimento del granchio alla cinese. Lo mise a cucchiaiate nel piatto e cominciò a condirlo con il sugo del crostaceo, e con la polpa ricavata dall’ultima chela. Voltò e rivoltò con le bacchette e poi con la forchetta il riso nella salsa, ottenendo un magnifico composto rosa, aggiunse due gocce della salsa nera che apparteneva all’altra portata, mescolò ancora un poco nel piatto. Poi cominciò a gustarsi, forchettata dopo forchettata, il piccolo impasto, con le mani unte, sorseggiando di tanto in tanto il tè al gelsomino.
Lo sparato non era neppure così malridotto. Era stato sobrio nel cibarsi del granchio, l’aveva delicatamente distrutto, piccolo morso dopo piccolo morso, usando ben poco i denti, a pensarci bene, ma molto la lingua.
“La domenica vado in ufficio a lavorare. Accendo la tv e me la guardo. Non vado al cinema da anni. Un tempo lei ci veniva con me, ma ora non abbiamo niente da condividere. Ieri mi ha detto che se ne va”.
“Quest’ultima portata è stata una delizia”, disse quasi a se stesso, soddisfatto.
“Lei è una donna fredda, io ho bisogno di coccole, carezze, di sentire l’altra persona, di abbracciarla. Lei non ha mai avuto slanci, nemmeno con Giorgio, nostro figlio. Io vorrei avere una relazione con una donna, ma devo amarla veramente per poterci andare a letto. In questo sono un po’ come una donna. Ed è proprio così che mi voleva lei. Quando mi ha conosciuto mi ha detto che lei, donna del cancro, aveva bisogno di grande intimità, di comprensione, che mi sposava perché io pensavo “femminile”, ed ero il primo uomo che le sembrava così”. Si fermò, prese un’altra forchettata di riso, rise tra sé come avesse fatto un pensiero divertente, e aggiunse: “Ma magari a lei le donne non piacciono”.
Il carapace del granchio era praticamente intatto: poteva sembrare ancora pieno del corpo del crostaceo, invece non c’era nemmeno più un millesimo di carne in quella corazza.
Lui si strappò via dal collo il tovagliolo/sparato, lo accartocciò e si strofinò le mani con le salviette umidificate che gli avevano portato. Era soddisfatto. Di sé. Del granchio. Della storia che aveva raccontato. Si era mangiato la moglie, l’aveva spolpata brano a brano con metodo e anche con amore, non era sublimazione, no, era cannibalismo, senza neanche più dolore.