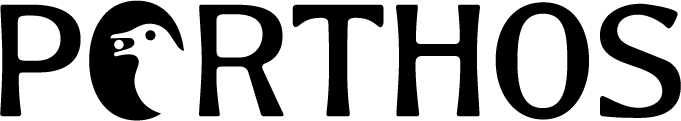30 Lug Per Gigi Balestra
Le interviste di Porthos si somigliano quasi tutte. Hanno in comune la mia abitudine a buttarla sempre sul personale. È vero, i primi obiettivi dell’incontro con un produttore sono apprendere dettagli tecnici e scientifici e confrontarsi sulle pratiche. Ma, a un certo punto, ho bisogno di soffermarmi sulla vita di persone che nel vino mettono più di quanto trapeli dalle loro bottiglie.

foto di Giampi Giacobbo
«Ecco l’unico vero vignaiolo della zona!». Così Umberto Stefani a fine novembre 2004 mi ha presentato Giovanni “Gigi” Balestra, fondatore e proprietario dell’azienda “Il Pendio” a Monticelli Brusati, in Franciacorta. Magari non sarà stato l’unico viticoltore-proprietario della zona, ha però incarnato una categoria che nel territorio bresciano è, ancora oggi, piuttosto originale. A pochi minuti dalla prima stretta di mano, ho subito pensato che l’intervista sarebbe stata necessaria, doverosa, l’ideale opportunità per restituire ai lettori e alle lettrici di Porthos un’eredità morale e di lavoro. Quella mattina di autunno ho incontrato un uomo che ha saputo farsi una carriera da agricoltore dopo averla a lungo sognata in una vita di esperienze dure e tragiche.
Da almeno una generazione, i Balestra si dedicavano alla produzione e al commercio di vino, ma non quello che Gigi avrebbe voluto realizzare. Con l’aiuto di sua moglie Norma, scovò l’endroit dei suoi desideri – c’era il “legno” delle viti più bello della zona, ci disse – e cominciò a vivere la “sua” dimensione di lavoratore del vigneto. La cantina arrivò poco dopo, e anche lì Gigi marcò la distanza dall’esperienza di famiglia, mettendo in pratica la visione “naturalistica” della vinificazione e dell’affinamento, in netto anticipo sui tempi che sarebbero maturati più tardi.
L’ho conosciuto quando la malattia era diventata ormai irrecuperabile.
I movimenti lenti non gli impedivano di seguire tutto con attenzione morbosa, tanto che era quasi impossibile lavorargli accanto. Erano i primi tempi del paziente Michele Loda come aiutante a tutto campo. Gigi parlava di meno e per questo aveva una lucidità impressionante, ogni frase pesava come un macigno o aveva la leggerezza di una nuvola, c’era sempre un significato intimo, scarnificato da qualsiasi orpello o compiacenza. Sono bastate quattro o cinque volte perché riuscissimo a compenetrare le rispettive esperienze e a diventare amici. Da allora non siamo stati assidui, al telefono come di persona, tuttavia la densità di ogni contatto era tale da bastarci fino all’occasione successiva. Come l’ultima, quando gli ho fatto visita presso la clinica che l’ha ospitato nella fase terminale della malattia. Era tornato un bambino, accudito completamente da Norma. Non era importante che si rendesse conto che io fossi lì, l’ho stretto forte e gli ho baciato a lungo la testa che odorava di borotalco. E mentre l’abbracciavo pensavo ai suoi sogni realizzati e a quelli che troveranno forma e sostanza in una prossima vita, quando finalmente potrà godersi quella «gita in carrozza» che non aveva potuto permettersi.
Scrivo di lui a qualche settimana dalla morte, dopo aver tentato di stare sulla notizia e senza riuscirci, come sempre. Così ho finito per scrivere a Gigi, ascoltando flamenco antichi e moderni e ritrovando la serenità pura che, talvolta, solo il grande dolore riesce a dare. Ecco, mettere in ordine i pensieri mi ha fatto tornare in mente un frammento dedicato alla sofferenza familiare. Viene dal numero 165 dalla rivista Buddismo e Società ed è tratto da una lettera aperta di una praticante: «Quando si soffre, la prima cosa da fare è aprire la vita, altrimenti la sofferenza coincide con l’intera esistenza. In una vita spaziosa, invece il dolore, se c’è, riempie solo una porzione».
Questo è l’augurio che cercavo, per lui e per tutti.