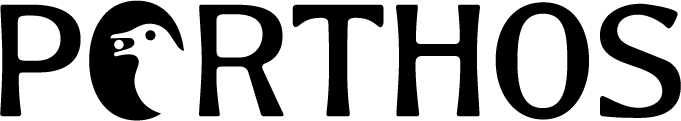01 Ago Pollenzo
N: Io aggiungo solo un punto: non banalizziamo il concetto di alimento. Da un lato sono d’accordo, perché nel mondo del vino naturale c’è questa idea del vino usato facilmente per sbronzarsi alla buona. Durante il periodo modernista, quando Sandro m’insegnava ad amare il vino, c’erano molti che dicevano: se è buono ne basta poco. E da lì si è partiti alla produzione di vini per iperconcentrazione. Da lì l’elogio della semplicità come bevibilità ha anche una funzione di contrappunto interessante. Adesso è diventata una nuova religione: se un vino fa più di 12 gradi è grasso e non è buono perché deve essere tutto acidità. Purtroppo le persone vogliono passare da una verità all’altra. Il punto è, come dice Sandro, che il vino è compagno della tavola. Non si può bere solo a livello degustativo senza avere influenze esterne. Bisogna puntare a un’ebbrezza vigile. Sentire e capire l’effetto che fa, ti permette di dire basta e scoprire qual è il punto limite.
Domanda dal pubblico: Vorrei tornare sull’argomento del vino naturale come alimento e sul fatto che giustifichi anche una bevuta più eccessiva. C’è una parte di pubblico legata al vino naturale che la pensa così. La maggior parte apprezza il vino naturale perché ha rispetto della terra, dell’essere umano e dell’ambiente. Siamo in un momento storico diverso rispetto a venti, trent’anni fa: è maturato un concetto ecologico che dovrebbe essere il focus del vino naturale. C’è anche l’idea di competitività rispetto al vino, se negli anni novanta vinceva il vino più costoso, ora quello più strano.
S: Non c’è molto da aggiungere. Vent’anni fa gli agricoltori erano i primi grandi nemici degli ecologisti, adesso le cose fortunatamente stanno cambiando (l’agricoltore dovrebbe essere il primo ambientalista perché ha la responsabilità di un posto); il vino naturale è custodia di una vita e, proprio partendo da questo concetto, va resa autonoma: il vigneto, se è stato piantato in un luogo vocato, deve avere una sua autonomia sanitaria, in modo che l’infezione faccia parte del gioco e non distrugga tutto.
M: Non riesco a essere vicino alle altre cose che hai detto se accetto il discorso “il vino si produce in una manciata di areali”. Credo che ogni terroir esprima il suo vino, che alcuni di questi vini raggiungano apprezzamenti che travalicano il luogo, e va bene, ma vanno distinti i due campi: credo ci siano le grandi zone – e si può desumere dal fatto che molte persone amano i vini che appartengono ad un certo terroir – e questo ne decreta la grandezza al di là del locale, ma in una dimensione ecologica, ogni vino di un territorio è grande, perché lo esprime, lo tira fuori.
S: Io sostengo che la prima caratteristica di un vino buono è la restituzione del luogo, qualsiasi esso sia. Sai perché i luoghi buoni sono una minoranza? Proprio per le ragioni sanitarie. La viticoltura a un certo punto è stata estesa in maniera allucinante perché c’erano gli incentivi agli impianti e così si è diffusa in maniera isterica. Riflettiamo sul Barolo: nel 1979 in circolazione si stimava ci fossero 11 milioni di bottiglie. La zona ne produceva realisticamente 4 milioni e mezzo al massimo, quindi vuol dire che 7 milioni di bottiglie erano robaccia. Arriva la DOCG, crolla il muro e quindi si comincia a ragionare seriamente. Il Barolo esce dal pericolo. Nel 2011 sono state prodotte 11 milioni di bottiglie. Possibile che i nostri avi si siano dimenticati dei posti buoni? No, dove c’era il pescheto da 150 anni hanno messo un vigneto, e così via. C’erano dei fondovalle, colline girate, colline prese e strapazzate per mettere il nebbiolo… capisci che voglio dire? È lì il problema della stretta minoranza. Non c’è nessuno più di me amante della piccola poesia (come direbbe Eco sui Peanuts), quindi non dico che il vino di papà che esprimeva il terroir non può essere buono, però…
P: Volevo tornare un attimo sul valore dei vini rispetto ai luoghi. Bisogna vedere come nella storia sono cambiati gli areali, non solo recentemente, anche negli ultimi 150 anni. È vero: ultimamente c’è stato un grande ampliamento, ma vedendo la storia possiamo scoprire progetti inversi, cioè riscopriamo areali storici del vino che erano stati dimenticati. Magari potrebbero fornire la base di nuove rivelazioni.
S: Il punto è che un vigneto ha bisogno di una varietà di coltivazioni accanto. L’iper-specializzazione è in realtà una sconfitta dell’uomo e del territorio. Quando Rinaldi è andato per la prima volta nel Carso e ha scoperto che c’erano vigneti in mezzo ai boschi, si è ricordato delle Langhe degli anni cinquanta. Tu immagina Montalcino… dalla zona storica c’è stato un allargamento incredibile. Non voglio omettere che abbiano scoperto dei luoghi che erano stati abbandonati e quindi se ne erano riappropriati, ma sono una minoranza.
P: Mi era piaciuta l’immagine del vino contenitore, questa idea di micromondi. Parlando di mondi che ti appartengono, hai citato due poeti prima, puoi dirmene altri? Che ti conducono alla conoscenza del vino…
S: La poesia è per me lo strumento più vicino al vino perché ha un suono e il suono del vino è paragonabile alla sua tattilità; la poesia può essere istantanea, come può esserlo il vino… Veronelli diceva che il vino buono comincia sempre con il rifiutarsi e questa è una cosa che, secondo me, bisogna imparare. Un vino che cerca di comprarti, di blandirti, ha qualcosa che non va. Quando le persone mi dicono: come facciamo a riconoscere il luogo nei vini? È una questione di esercizio, bisogna assaggiare. Intanto, cominciamo a escludere quelli che il posto non te lo restituiscono mai. In questo senso la poesia è la forma d’arte che mi accompagna di più. Una delle cose che cerco di non fare sono i parallelismi meccanici, perché li trovo fini a se stessi.