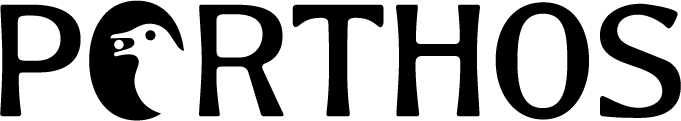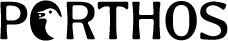25 Set A quasi un anno
Muet apparaît le volcan.
Terre sur quoi l’olivier brille,
Tout s’évanouit en passage.
Violenta si schiude la spalla;
Muto appare il vulcano.
Terra su cui brilla l’ulivo,
Tutto passa e scompare.
René Char, traduzione di Giorgio Caproni, Einaudi 2018, prima edizione Feltrinelli 1962.
A poco più di un anno dalla morte di Beppe Rinaldi e di Stefano Bellotti ci ha lasciato improvvisamente un altro amico, Franco Zanovello.
Ho già scritto che, per chi fa il nostro mestiere, l’amicizia coi produttori è una questione delicata. Inoltre esistono tante forme di relazioni che, per quanto “professionali”, non sono sovrapponibili. A definirle è il primo incontro, proprio come dice Thomas Stearns Eliot: «Ciò che amiamo degli altri è il ricordo di quando e come li conoscemmo».

Sin dall’inizio mi è parso un monito, forse non ci credeva neanche lui a un’affermazione così tranchant, evidentemente temeva che la mia colpevole ingenuità e l’inclinazione a portare tutto sul personale sollecitassero aspettative inappropriate da ambo le parti. Per quanto abbia subito frequentato l’universo della critica e della narrazione enogastronomica, la mia origine non è quella, ho coltivato la passione per il vino mentre lavoravo nel ristorante di famiglia e, guardando il comportamento di mio padre, ho preso a emulare il suo modo affettuoso e amicale nei confronti dei produttori che venivano a presentarsi, restavano a mangiare, a parlare, prima di prendere l’ordine o, addirittura, lasciarci subito le bottiglie. Quando ho cominciato a visitare le aziende e a conoscere molti dei vignaioli raccontati da Veronelli, mi sembrava un sogno che potessero considerarmi un amico, quasi mi dimenticavo di essere per loro un cliente. Nel ruolo di critico non mi sono mai sentito un opinion-maker e credo di non essere stato così influente da decidere, io da solo, il destino commerciale di un’impresa. Ai tempi della Guida di Slow-Food e Gambero Rosso, avevo la responsabilità di designare i vini meritevoli del massimo premio, risultato di una lunga serie di degustazioni nelle regioni di mia competenza; ci pensava poi la commissione congiunta dei curatori, della quale facevo parte, a confermare o rigettare la proposta. Ciò rendeva meno problematico il rapporto con i produttori, sebbene fosse inevitabile da parte loro nutrire delle aspettative e, di conseguenza, trattarmi con tutti i riguardi possibili, al punto da pensare di poter trasformare con facilità conoscenze in amicizie. Mi sono accorto della volatilità di certi legami quando è nato il progetto Porthos e la grandissima parte di loro si è sciolta. È stata una lezione, è stato utile.
Diverse persone criticano il mio tempo di reazione, lamentano la mia assenza mediatica rispetto ad alcuni avvenimenti e la mancanza di tempestività. Nel caso specifico della perdita di amiche e amici dell’universo enogastronomico, nell’immediato non riesco proprio a pubblicare una parola, se posso dedico qualche riga direttamente a familiari e amici. E il mio silenzio si fa più ostinato a mano a mano che crescono i post, le prese di posizione, le onoranze, le manifestazioni di lutto. Maggiore è la consapevolezza di poter dire qualcosa di originale e offrire un utile vissuto personale, più forte è il desiderio di starmene per conto mio, aspettare che intorno si faccia tutto calmo per assimilare ed elaborare il dolore della perdita. Di rado riesco a preparare subito un testo di commemorazione all’altezza, così la sofferenza m’impone una pausa.
Appena accade una tragedia pubblica, i cui contorni sono chiari solo in apparenza, si assiste al sovrapporsi di dichiarazioni che, nell’esprimere sdegno, costernazione, cordoglio, ecc., servono solo a chi le fa, sia per farsi notare in una sorta di autopromozione, sia per esprimere giudizi con una fretta che mi consuma dentro, mi devasta. Rarissimo il caso di qualcuno che, interpellato, risponda: «Per ora non ho nulla da dire, vedremo in futuro, ci sono persone adatte e competenti a fare dichiarazioni valide e dovute, la mia preghiera è di non abbandonare i soggetti coinvolti; mi tengo il dolore e osservo un rispettoso silenzio per le vittime».
Stefano, Beppe e Franco sono accomunati dalla loro determinante importanza nella mia carriera di persona, che poi è un tutt’uno con la professione.
Comincio da Bellotti, incontrato nella sua Tassarolo nell’agosto 1988. Io e Francesca, a poche settimane dal matrimonio, eravamo in giro nel Gaviese per la Guida a cercare persone, storie e vini da raccontare e, nonostante ci fossero alcune aziende storiche, la scena mediatica e commerciale era da anni dominata da La Scolca. La proprietà della famiglia Soldati aveva addirittura modificato la denominazione inventando la dizione “Gavi dei Gavi”, trasformata poi in marchio; fu proprio Stefano a spiegarci come quell’espressione potesse “ingannare” tanto che venne modificata con “Gavi di Gavi”, a testimoniare una più precisa indicazione territoriale. A quel tempo la fisionomia di quei Cortese, condivisa anche da realtà rinomate come La Giustiniana, La Battistina e Broglia, era «dritta e aristocratica», oggi diremmo «fredda, tagliente e distaccata». Bellotti, nella sua Cascina degli Ulivi, tentava di rendere il Gavi più verace e coinvolgente, probabile che stesse già sperimentando delle macerazioni e, in ogni caso, Montemarino e Filagnotti, le due versioni originate da vigneti diversi, erano state accolte con favore da numerosi clienti in giro per l’Italia.

la foto di sinistra è stata fornita da Cascina degli Ulivi, quella di destra da Alessandro Dettori
Quella lunga giornata si concluse in un’asciutta notte estiva, ricordo gli occhi di Stefano, uno sguardo di una freschezza che non avevo ancora conosciuto. Quando ci siamo rincontrati nel 2000, molto era successo nelle nostre vite; a colpirmi subito è stato il mutare dei suoi lineamenti, in un’ideale coincidenza con la maturazione espressiva dei vini: da un’elementare spontaneità erano passati a una ricercatezza densa di contenuti e venata da un tangibile tormento. Il Bellotti che raccomandai ad Angiolino e Stanko, impegnati nel riunire il primo nucleo di “Vini Veri”, era un viticoltore biodinamico abile a immaginare un’agricoltura composita e innovativa, un vinificatore già avvezzo a prendersi dei rischi per far emergere la cifra dei luoghi e l’età delle vigne.
Abbiamo seguito l’evoluzione dei Cortese e dei Dolcetto ed è risultato evidente come dalla vinificazione fossero scaturite partecipazione del sapore e persistenza gustativa. Il mio rapporto con Stefano ha avuto i suoi momenti difficili perché, a un certo punto, non sono riuscito ad afferrare la trasformazione alla quale andava incontro l’uomo, prima ancora del produttore. Negli ultimi anni è stato un privilegio potermi riconnettere a lui: sorridevamo di quanto ci fossimo presi sul serio, constatando però che i nostri contributi non erano andati dispersi. C’eravamo sentiti pochi giorni prima di quel venerdì 14 settembre, stavamo maturando delle serate da condurre insieme: in quasi quarant’anni avevamo attraversato così tante vicende – solitudini, delusioni, sorprendenti vicinanze – da poter dire alla gente quanto fosse ormai irrinunciabile la bellezza sensuale e adulta di un vino naturale.
Era la Convention di Slow-Food del 1993 dedicata ai vini delle Langhe. Si trattava di un modello di manifestazione che coinvolgeva i territori per intero, dalla produzione del vino alla ristorazione passando per tutta una serie di soggetti interessati a far conoscere le proprie specialità. Ne avevamo fatta una nel 1990, sempre nell’albese, due in Toscana, ’91 e ’94, una in Friuli Venezia Giulia nel ’92. Si svolgevano nel tardo autunno, quando gran parte delle vendemmie si erano già compiute. Avevo appena finito di guidare una degustazione, quando un collega dell’associazione mi condusse da Beppe Rinaldi e me lo presentò, io sapevo bene chi fosse, lui meno, fu di poche parole e la cosa si concluse lì. Ebbi poi l’opportunità di bere i suoi vini a casa di Bartolo Mascarello e in una cena coi ragazzi della nouvelle vague langhetta.
Sin dall’inizio mi resi conto che quelle bottiglie si ricollegavano al mio ricordo primigenio di un Nebbiolo invecchiato, un Barolo del 1964 di Bersano bevuto in clandestinità una mattina della primavera 1979: i colori diafani, la penetranza dei profumi, l’essenziale dinamica gustativa. Fu particolarmente importante il secondo assaggio, si trattava di un Barolo Cannubi San Lorenzo 1986, protagonista di un impatto umbratile e monastico (quanto avrebbe riso Citrico di fronte a quest’ultima definizione!). Anche i presenti più resistenti al fascino odoroso furono conquistati da una progressione regale, al naso e in bocca, un’esibizione coordinata dalla quale si liberò un bouquet di camomilla che avrebbe segnato la mia memoria. Ci vuole la fine del 2000 perché io e Beppe si riesca a parlare più a lungo.

foto di Giampi Giacobbo
A un certo punto disse: «Sah, scendiamo a sentire qualcosa?», il mio stomaco gridava… In cantina cominciò la sua esplorazione della riserva personale, non si capiva bene come facesse a riconoscere le annate e le vigne di bottiglie e pintoni (definiamo il “pintone” una Magnum abbondante) all’apparenza privi di indicazioni. Passò dal ’64 al ’79, trovò quello che gli sembrava un ’62, e poi ’69, ’74, ’82, ’89, ’90, ’83… intanto si era procurato un salame che confortò una degustazione in piedi e con un calice a testa. Ho ancora gli appunti e, nel rileggerli, sento che mi è rimasta la sensazione di aver bevuto un solo vino con un sovrapporsi di immagini, come se ci fossero fotografati i paesaggi delle differenti vendemmie e scorressero in un caleidoscopio. E poi il ripetersi di equilibri e armonie che hanno lasciato una tale eco di vibrazioni da poterli sentire ancora nitidi. Era cominciata un’amicizia della quale potrei ricordare decine di giornate trascorse insieme, soprattutto nella casa di via Monforte 2, dove in estate a pranzo, tornando dalla vigna o dalla cantina, Beppe passava per l’orto, prendeva dei pomodori per unirli alla Simmenthal e condirli con una spruzzata del suo aceto di Barolo. Il pomeriggio di domenica 15 luglio 2018 con Ezio Cerruti vado a trovarlo a casa, la moglie Anna ci aspetta e accogliendoci dice che magari possiamo guardare insieme l’ultima partita dei mondiali di calcio. Beppe avrebbe voluto in finale il Belgio… è ancora presto per metterci davanti al televisore, così vado in camera dove lui è disteso con le flebo. Mi mostra un cavatappi, di quelli tradizionali con due leve, un pezzo unico, di una fattura finissima. Non parliamo della malattia, legge una riga da un libro di poesie dell’amico Franco Marcoaldi, chiama Anna per chiederle di prendermene una copia. Poi, all’improvviso, chiede: «T’interessa ancora il vino? – non faccio in tempo a dire una parola che lui continua – Io non ne posso più». In quel momento mi sono venute in mente le ultime volte in cui ci siamo visti e, mentre tutti lo circondavano chiedendogli e parlandogli dei Barolo, dei Dolcetto, delle vigne e delle cantine, della naturalità, del consorzio, Beppe faceva di tutto per sgattaiolare… mi raggiungeva per chiedermi cosa avessi letto di recente, per dirmi del gufo che avrebbe voluto oppure di una mostra da vedere, di un artista suo amico che se n’era andato. Dopo la partita Anna porta tre bottiglie delle nuove uscite per me, lui dà il benestare e, prima di lasciarmi andare, mi dice che uno dei vini è buonissimo; chi ha conosciuto Beppe sa che non si esponeva mai sulla sua produzione, non commentava né descriveva le sensazioni, per non parlare della vinificazione, al massimo dava ragguagli sulla qualità dei peschi piantati tra i filari. A una cosa teneva, dirmi di Marta e Carlotta… che nella vigna e in cantina praticamente non gli avevano più fatto toccare nulla.
Caro Franco,
per onorarti, scelgo il mezzo della lettera, mi sembra il più adatto sia alla natura della nostra amicizia sia alla prossimità della tua scomparsa.
A beneficio di chi legge dedico qualche riga alla tua carriera di produttore. Hai lavorato quasi sempre nei Colli Euganei e, a un certo punto, ti sei concesso un’esperienza siciliana. Chi, come me, ti ha conosciuto al principio degli anni novanta e ha seguito l’evolversi della tua vita, ha colto in questa esperienza extra patavina una conquista di libertà. Andiamo con ordine.
Ho avuto l’opportunità di incontrarti nell’inverno del 1993, quando tu e il tuo socio Lucio Gomiero avevate l’azienda Vignalta dedita a bianchi e rossi piuttosto ambiziosi. In particolare meritano un ricordo il Sirio, una vinificazione secca di quasi tutto Moscato bianco, e il Gemola, taglio di Merlot per il 70% e Cabernet Franc, in linea con gli assortimenti (encépagement) tipici della riva destra della Dordogna bordolese. Se il primo si segnalava per una fragranza odorosa sempre moderata dalla ricchezza degli estratti, così da non risultare mai stucchevole o banalmente superficiale, le migliori versioni del secondo avevano il fascino dei rossi veneti vecchio stile, appena vegetali, anche con la maturità, con quella stoffa che si assottigliava in modo mozartiano, tutta insieme, senza lasciarti mai.

la foto di destra è di ©Valentina Gallimberti Ballarin
Quando ho scoperto il potenziale di superiorità del vino naturale, ricorderai sicuramente, ti dissi che la tua “enoteca segreta” – mi viene in mente la private library del dottor Frankenstein – aveva in nuce la svolta che andava accolta anche dalla tua parte più razionale. Mi sento fortunato ad averti assistito moralmente, soprattutto per aver visto in tuo figlio Marco una figura capace di elaborare un credibile passaggio di consegne.
Franco mio… quel giorno di febbraio del 1993 arriviamo a Vignalta appena dopo pranzo, sono con Lucio e il collega Roberto Checchetto, tu ci guardi come se volessi farci sentire in colpa di non averti portato con noi a mangiare. Come primo incontro non c’è male… i tuoi occhi dicono che deve essere una brutta giornata. Il breve scambio che abbiamo non sortisce grande successo per modificarla, anzi… ho la sensazione di avere di fronte una persona che ha tante fortune ma non è felice. Anche qui faccio appello alla tua memoria, ricorderai che tempo dopo sorridesti un po’ amaro, dicendomi che in quel periodo non avevi ancora afferrato il tuo privilegio, una fase che si sarebbe dilungata ancora, almeno fino a quando, sono tue le parole, «non fossi riuscito a dare finalmente fiducia a quella parte fragile e compassionevole che da un pezzo urlava senza sosta». La gioia che hai saggiato è stata di una tale consistenza da poter riconoscere in te un altro uomo. Molti di noi, amiche e amici, hanno goduto della generosità con la quale hai affrontato le numerose imprese succedutesi fino all’ultimo giorno. La tua voce è ancora con me, quel sorriso appena accennato, sempre presente dopo il primo contatto, percettibile anche al telefono, non importa che tu fossi dall’altro lato del globo. I tuoi occhi azzurri hanno coltivato l’ottimismo proprio dell’arte, hai consentito che filtrasse nel tuo lavoro, così da renderlo vivibile, creativo nonostante le preoccupazioni e le incognite. E intanto sei stato mio amico, vicinissimo, sempre.
Ora è tempo di riporre tutte le giornate nelle quali ho avuto l’occasione di condividere con te uno scampolo, un respiro, un commento sulla miseria umana di fronte al miracolo dell’amore. Ti saluto qui e ti lascio con una poesia di Cristina Campo, mentre il pensiero va a Linda e Marco, i tuoi figli.
Passo d’addio
Si ripiegano i bianchi abiti estivi
e tu discendi sulla meridiana,
dolce Ottobre, e sui nidi.
Trema l’ultimo canto nelle altane
dove sole era l’ombra ed ombra il sole,
tra gli affanni sopiti.
E mentre indugia tiepida la rosa
l’amara bacca già stilla il sapore
dei sorridenti addii.
Voglio estendere il mio pensiero alle famiglie di altre persone del nostro mondo che sono scomparse negli ultimi diciotto mesi. Si tratta di uomini che abbiamo conosciuto e ai quali ci hanno legato scoperte appassionanti. Ne metto qui di seguito i nomi: Bruno Giacosa e Gianfranco Soldera, Ernesto Cattel, Daniele Maestri e Gianni Frasi.