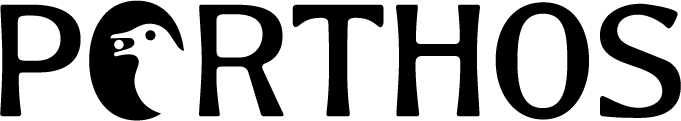01 Nov APFEL STRUDEL
Ancora pioggia. Era già trascorsa una settimana di vacanza senza che il tempo accennasse a migliorare. Per i primi giorni non era stato poi così male. Io mi sentivo una regina con un mantello di lana viola sulle spalle, a strascicare le pantofole da una stanza all’altra, da una finestra all’altra, per scrutare la direzione delle nubi. E poi c’era quel gioco di ascoltare la pioggia sulla lamiera del tetto e indovinare il ritornello nascosto. Annemarie, la padrona di casa, ad intervalli regolari, bussava con discrezione alla porta con unaria colpevole per quellagosto ingrato, e in cambio del perdono ci lasciava qualche fetta di sacher, dei biscotti di nocciole, un boccale di birra o, più semplicemente, il buon odore della sua stube. Ma quella mattina cerano state delle parole forti tra me e Franz, forse a causa dell’umore che si era lasciato influenzare dal cattivo tempo, parole che avevano riaperto delle piccole ferite. Erano esplose all’improvviso, proprio come il vento sgarbato che aveva spalancato di colpo la finestra trascinando al suo seguito il cielo umido. Così avevo deciso di uscire, sola, ad ascoltare il rombo di un altro temporale.
Presi il sentiero tra gli abeti, dietro la casa, un rivo di fango in cui affondavo gli scarponi con rabbia, passo dopo passo. Intanto la pioggia, scivolando come un balsamo dalle spalle fino al collo dei piedi già fradici, mi avvolgeva delle fragranze rubate agli arbusti del bosco, alle bacche, alle resine e al muschio, alle foglie interrate. Proprio in mezzo al viottolo cera un fungo che apriva sfacciato e incurante il suo ombrello rosso. Qualche passerotto malinconico cinguettava svogliato, a tempo di valzer, destreggiandosi a schivare le gocce tra un rovo e laltro.
Alla fine del bosco la strada per arrivare alla Wolitzen Hütte era ancora lunga, tutta scoperta e ripida. A poca distanza le mucche, impassibili sotto la pioggia fredda, mi seguivano col loro occhio idiota mentre salivo faticosamente lungo il fianco della montagna, finchè la nebbia non mi inghiottì.
Ecco, finalmente un suono d’acqua diverso, una fontanella intagliata nel legno, e poi una nuvola azzurra di fumo, le pareti di pietra, le travi scure sotto le quali i tralci lunghi delle fucsie, carichi di fiori grassi, oscillavano come per scrollarsi di dosso le gocce pesanti.
Un odore intenso di latte bruciato, di letame e fieno usciva dalla stalla. La porta era chiusa, c’era silenzio all’interno, ma i vetri appannati balenavano della luce palpitante di una candela rivelando una qualche presenza. Accostai la mia faccia stanca alla piccola finestra con l’intenzione di bussare, ma le mie nocche si bloccarono a mezz’aria. Una scena indimenticabile. Quattro mani vigorose, ma con tocchi delicati come sulla tastiera di un pianoforte, stavano cospargendo di mele e zucchero una sfoglia che sporgeva dalle assi del tavolo con la sontuosità di un tessuto prezioso. Poi, allunisono, cominciarono ad avvilupparla trasformandola in un involto che quelle stesse mani, passando a turno sulla scodella del burro, presero a lisciare, a strofinare, sollevandolo con la stessa soave energia con cui una madre fascia il suo bambino. Si affacciò intatto un ricordo di scuola “ stringendo il fanciullo tra le braccia immortali Demetra lo ungeva d’ambrosia come il figlio di un dio, dolcemente soffiando su di lui ”. Poi deposero il fagotto con cautela su una culla di rame, raccolto a spirale come un gatto addormentato, affidandolo al calore di un vecchio forno.
Una bimbetta bionda, impolverata di farina, con un grembiule pieno di macchie appetitose, mi venne ad aprire e con un sorriso ineffabile mi rapì alla tempesta per consegnarmi all’estasi di quel luogo magico dove regnavano latte, cannella e vaniglia. Mi fece sedere vicino alla stufa. Al lato opposto della panca c’era una nonna che imboccava un putto rotondo dal volto acceso su cui brillavano due occhi chiari, pieni di pianto: la vecchia gli raccontava una favola triste, senza conforto. Anchio avevo voglia di piangere e il suono delle sue parole incomprensibili si depositava come una dolce pressione sul mio cuore agitato. Fu solo quando mi portarono un pezzo ancora caldo di quella torta sublime che spuntò la prima lacrima, e la seconda fu tutta per quel bicchierino di snaps che, finalmente, lasciò libero il fiume in piena. “Du bist die Ruh der Friede mild ” (tu sei la quiete, il dolce riposo). Schubert zampillò per incanto dal mio petto ad annunciare la pace, strappando una risata anche al piccolo bambino. Ora sì che il mio cuore batteva più piano, in beatitudine.