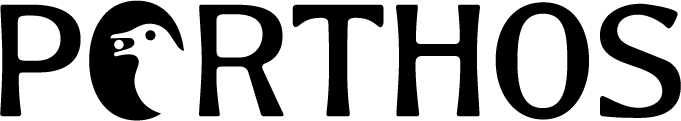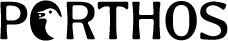07 Apr La rivoluzione dei vini naturali
Dopo un dovuto chiarimento, abbiamo recuperato la parte mancante del pezzo di Maurizio Gily, pubblicato su Porthos 35. Ecco la versione completa, corredata da una breve nota dell’autore.
Lost in transmission… (24 settembre 2010)
Nello scambio di email con le quali si procedette alla revisione dell’editing di questo mio pezzo non mi avvidi che una sua parte, che ritenevo molto importante per la comprensione del mio pensiero, era “saltata”: me ne resi conto solo dopo la pubblicazione. In un improvvido commento di quelli che si fanno a tarda notte, slacciati i freni inibitori, sul blog dell’amico Carlo Macchi, postai il pezzo mancante avanzando il dubbio che Porthos l’avesse censurato. Nell’intenzione il commento era tra il serio il faceto, ma l’ottimo Onepablo lo prese molto seriamente: anzi, per meglio dire, s’incazzò come un diavolo della Tasmania, tanto da mettermi alla gogna nella newsletter di Porthos stigmatizzando la mia “leggerezza” e rivendicando, con ragione, la serietà del lavoro di redazione. Espiato un adeguato periodo di penitenza, Porthos mi offre ora la redenzione con la pubblicazione del frammento mancante. A parte gli scherzi, ne sono sinceramente grato a Onepablo e a Porthos, soprattutto perché mi consentono di completare il mio pensiero sull’argomento, sperando di provocare nuove discussioni, come le molte che sono seguite alla pubblicazione dell’articolo.
La parte mancante:
Il cavallo, e la fatica
Ha scritto Mauro Corona: “Nel mondo moderno abbiamo voluto abolire la fatica. Ma senza la fatica l’uomo impazzisce”. Contrariamente a molti colleghi l’idea che qualche vignaiolo torni a lavorare con il cavallo non mi fa affatto ridere, anzi la trovo un’idea geniale. Un vigneron biodinamico francese mi ha fornito una bella lettura della cosa: “il cavallo sa quando il terreno si può lavorare. Se è troppo asciutto o se è troppo umido non ce la fa a tirare, e si rifiuta”. I trattori e le frese, invece, vanno sempre, anche quando il terreno non è “in tempera”, provocando gravi danni alla struttura e alla vita biologica del suolo. Ma lavorare con il cavallo costa fatica, come usare la zappa invece della barra da diserbo. E poi un animale non è una macchina, non può stare senza custodia. A chi sceglie seriamente la via del “naturale” si impone una riflessione sul ruolo della fatica fisica e sull’organizzazione della sua stessa vita. La cosiddetta “rivoluzione verde” ha quasi cancellato dai campi la fatica (quasi: provate a stare otto ore su un cingolato e la schiena vi dirà che non è poi una gran pacchia). L’enorme crescita del consumo di energia per produrre beni agricoli ha una contropartita che ne è in gran parte anche la causa, cioè la riduzione del dispendio energetico dell’individuo. Ogni essere vivente mira per natura a ridurre al minimo i suoi consumi e l’uomo lo ha fatto consumando le risorse della terra. Dobbiamo tornare indietro? Ecco un bell’argomento di discussione. E’ facile dire che i diserbanti fanno male. E fare la mondina fa bene? Ci si spezza la schiena e ci si riempie di dolori, un tempo si beccava pure la malaria e non si campava a lungo. Sarebbe ipocrita negare che per queste donne i diserbanti sono stati una benedizione celeste. Se il produttore “naturale” vuole essere anche un produttore etico, come logica vorrebbe, non può diventare un padrone che passa in rassegna file di forzati (e il mondo è pieno di gente disperata). Deve occuparsi a fondo di questi argomenti e trovare le sintesi necessarie. L’importante è non rimuovere il problema. Io trovo curioso che nessuno ne parli mai.
_________________________
Studi scientifici suggeriscono che i prodotti dell’agricoltura ottenuti con metodi biologici, o in modo non intensivo, presentino un profilo nutrizionale diverso e migliore di quelli frutto di agricoltura intensiva. Non è quindi solo questione di residui chimici, ma di valore nutrizionale e salutistico. Ad esempio, le proprietà antiossidanti per il nostro organismo di un vino, di un olio, di un uovo variano di fattori multipli, a seconda del territorio di origine e delle modalità di coltivazione e allevamento. Il latte di vacche al pascolo in alpeggio contiene più omega-tre di un latte industriale che vanta in etichetta l’addizione di omega-tre. Se i consumatori avessero maggiore consapevolezza di questi dati, la richiesta di prodotti “naturali” aumenterebbe, ma non ne sono informati. Ho sentito recentemente un’intervista televisiva a Umberto Veronesi, celebre oncologo e alfiere degli OGM (benché non gli si conoscano competenze in campo agrario), sulle proprietà antitumorali dei cibi: ha esaltato alcuni alimenti, ma non ha fatto una sola menzione dell’enorme diversità che c’è tra un uovo e un altro, tra un broccolo e un altro. Eppure, i dati dovrebbe conoscerli meglio di chiunque altro.
Cosa vuol dire “naturale”? Tutto e niente. Per dirla tutta anche il termine biologico è ambiguo, più preciso è quello anglosassone di organic, che sarebbe potuto andar bene anche in italiano.
Per venire al vino: siccome non può esistere una legge universale che stabilisca quali vini sono naturali o “veri”, i produttori che scelgono questo orientamento si sono dati delle regole. Tutti i gruppi che si richiamano all’orientamento naturale seguono protocolli di lavoro dichiarati: se poi tutti facciano quello che scrivono, questo è un altro discorso… il caso delle DOC è un monito costante. In genere, i produttori di vini naturali contano sul rapporto fiduciario con il consumatore, più che affidarsi a un certificatore esterno; anzi, spesso sono tra coloro che contestano il piano dei controlli sulle DOC e sul biologico, avanzando dubbi non infondati sulla serietà e l’accuratezza di questi meccanismi.
In genere, sono considerati con una certa sufficienza dalla scienza ufficiale, ma di rado attaccati frontalmente, con l’eccezione di qualche autorevole accademico che si compiace di brandire la fiaccola della scienza redentrice e di portare la luce tra le tenebre della superstizione (leggi soprattutto biodinamica). La mia formazione e la mia esperienza mi inducono allo scetticismo verso la cosmologia steineriana, tuttavia ho grande rispetto per chi ha compiuto scelte di vino naturale e le attua con rigore. Mi resta, però, qualche dubbio quando esamino i protocolli che si sono dati questi produttori.
Renaissance
«È proibito l’uso di ogni tipo di additivo aromatico (tannini in polvere, trucioli di quercia, ecc.)»; fin qui nulla da eccepire, anzi, è corretto mettere sullo stesso piano i trucioli (che tutti hanno ripudiato e in Italia sono vietati sui vini a DOC) e i tannini. A quelli in polvere, personalmente, aggiungerei quelli liquidi, che sono meno naturali dei chips in quanto frutto di estrazione con solventi, però vanno bene per tutti, DOC e DOCG; i winemaker di punta li usano a palate e i giornalisti non hanno mai protestato.
Altro divieto riguarda «ogni intervento termico volto a mutare il naturale diagramma della temperatura del mosto». Comincio a non capire. Qual è questo diagramma naturale? Dato che questo dipende dalla temperatura esterna, da quella dell’uva alla raccolta, dal tipo di vasca e dalla sua dimensione, un diagramma naturale è un diagramma casuale. La naturalità presuppone per forza di lasciar fare al caso? Chi fa un vino naturale o vero non per hobby ma per campare, questa domanda se la fa ogni giorno. Se raffreddo il mosto, magari usando energia geotermica o acqua di sorgente, il vino sarà per questo meno naturale? E se so che l’uva è matura e domani piove, aspetto lo stesso perché non siamo nella luna giusta per la vendemmia? E se ho un fruttaio per appassimento, non posso accendere un ventilatore quando la stagione è umida? Siamo in balìa degli elementi tutto l’anno: una volta che il prodotto è sotto un tetto, devo per forza preoccuparmi se piove, c’è il sole, se fa caldo o fa freddo? Anche gli animali quando il tempo è avverso cercano un riparo. Non è forse naturale questo?
Triple A
La scelta del nome non poteva essere più infelice: Triple A sta per “agricoltore artigiano artista”, ma, per chi ricorda la dittatura argentina, Triple A era “Alianza Anticomunista Argentina”, cioè un’organizzazione terroristica che fece da precursore ai famigerati squadroni della morte. Un infortunio, immagino. Ma quando si sceglie un nome ci si deve documentare, bastava fare un giro su internet. Così come quando si fissa un protocollo di regole.
Il prologo del manifesto Triple A recita: «La standardizzazione sta generando vini simili in ogni angolo del pianeta, appiattiti nei caratteri organolettici e incapaci di sfidare il tempo. L’utilizzo della chimica nel vigneto e l’utilizzo dei lieviti selezionati in laboratorio sono le due cause principali di questa standardizzazione». Mi pare una semplificazione abbastanza grossolana e priva di fondamenti scientifici. Sono piuttosto alcune tecniche di vinificazione che portano alla standardizzazione e, in genere, tutte le tecniche “spinte” all’estremo: dall’iperriduzione all’uso del legno nuovo, dalle tostature forti e dalle temperature molto basse di fermentazione all’illimpidimento eccessivo dei mosti. Il risultato dell’azione dei lieviti dipende dal substrato molto variabile che essi incontrano. Alcuni, soprattutto sui vini bianchi, possono senza dubbio essere un fattore omologante, ma non più di molte altre cose. A mio modesto avviso, da questo punto di vista la chimica nel vigneto incide ancora meno; i problemi che genera sono altri. Aggiungo che tra le tecniche spinte che producono omologazione ci sono anche alcune pratiche care a molti produttori di vini naturali, come la macerazione prolungata dei bianchi sulle bucce e la gestione poco attenta dei processi microbiologici (anche lo spunto acetico e altri difetti possono essere fattori omologanti). Su quanto Triple A afferma a proposito di moltiplicazione della vite e uso dell’anidride solforosa, vale quanto dirò a proposito di ViniVeri.
Molti gruppi, tra cui Triple A, si schierano contro le chiarifiche e le filtrazioni. Su questo non ho particolari obiezioni, salvo che, se la sedimentazione dei depositi la facciamo fare solo al tempo, bisogna dare tempo al tempo. Non si può imbottigliare un vino non filtrato a pochi mesi dalla vendemmia e pretendere che sia stabile, in qualche modo si “muoverà” in bottiglia. Se questo è voluto, come nel caso dei vini frizzanti con deposito naturale, va tutto bene. Altrimenti si potrà sempre dire che è la dimostrazione che il vino è vivo, ma…
VinNatur
Il gruppo ha natura transnazionale e associa cantine italiane e straniere. La composizione è piuttosto eterogenea, comprende nuovi produttori e vecchie glorie. Il manifesto del gruppo, pubblicato sul sito internet, rifugge da ogni settarismo e non fissa paletti, fino ad apparire ispirato a un’idea piuttosto vaga di cosa voglia dire vino naturale. Non è detto che questo sia un male, se lo si interpreta come atteggiamento laico di chi sta ancora cercando, piuttosto che postulare una serie di verità o di tavole della legge, come fanno altri. Un aspetto che mi pare particolarmente importante, e che si concilia con questa idea di ricerca, è il focus sui temi dello scambio e condivisione delle informazioni, della sperimentazione applicata e della formazione: VinNatur promuove convegni e seminari tecnici con la partecipazione di esperti internazionali.
ViniVeri
È il gruppo che mi è più simpatico, forse per il legame di amicizia che mi legò al suo fondatore Teobaldo Cappellano. Un produttore-filosofo capace di travasare nel gruppo la sua visione dell’agricoltura e della vita: aperta, laica, non dogmatica, fondata in gran parte sul recupero dei saperi dei padri e sulla critica inflessibile, ma sempre “non violenta”, dell’idea industriale di progresso, in particolare se applicata alla terra. Forse una sua citazione può aiutare a meglio capire cosa intendo: «Ecco cosa siamo. Non siamo biologici, anche se la nostra regola impone condizioni di vigna e di cantina ancora più severe di quelle delle varie “certificazioni”. Non siamo biodinamici, anche se molti di noi sono vicini alla filosofia di Steiner. Non lo siamo perché sappiamo che purtroppo le regole possono essere cavalcate dalle mode; non lo siamo perché sappiamo che nulla è più facile che imporre regole per poi violarle. Le grandi ricchezze così nascono. Vivere sull’ingenuità degli altri è facile, lo hanno fatto anche con noi quando ci dicevano che certe compromissioni con la chimica dell’industria portavano a risultati “veloci” e non a un impoverimento della terra e delle nostre menti. Non eravamo più capaci di farci sorprendere dalla Natura, non eravamo più capaci di crescere nel sapere perché questo ci veniva offerto, semplificato a loro uso, in un pacchetto preconfezionato con indicate le dosi e le modalità d’uso».
Dai protocolli di lavoro di ViniVeri ricavo però la stessa impressione che mi suscitano gli altri gruppi: non parliamo la stessa lingua.
Ad esempio: «Vietata la clonazione». Ma come riproducono la vite, per seme? No, piantano barbatelle innestate, o, qualche volta, franche di piede. Si chiama, appunto, clonazione. È il modo con cui si riproducono di norma le piante arboree coltivate. Forse intendevano dire: non usare cloni certificati, quelli con il cartellino azzurro. Ma sul linguaggio dobbiamo capirci.
«Utilizzo esclusivo dei lieviti indigeni presenti nell’uva raccolta». I microbiologi hanno una brutta notizia: di solito, di lieviti sull’uva – almeno del genere saccharomyces, cioè i lieviti vinari propriamente detti – non ce ne sono proprio, o sono troppo pochi per prevalere su altre specie non interessanti se non dannose, che però non resistono all’anidride solforosa. Ne consegue che è abbastanza facile fare vini con solforosa e senza lieviti selezionati; e relativamente facile, con una buona igiene, vinificare senza solforosa e con lieviti selezionati. Ma senza solforosa e senza lieviti selezionati, il rischio di veder schizzare l’acidità volatile (spunto acetico) è molto alto. Torniamo alla domanda di prima: quanto lasciare al caso? I lieviti che innescano le fermentazioni spontanee, di solito, si trovano in cantina e non sulle uve e ciò, in parte, attenua il rischio. E le cantine dove per anni si sono usati lieviti selezionati ne sono ormai tappezzate. Il recupero di una flora indigena in queste situazioni non è facile: ammesso che sia poi davvero così strategica. Soprattutto sui vini rossi, molti studi rilevano che dopo un medio periodo di conservazione le differenze sono trascurabili. Se uno avesse un laboratorio di microbiologia e dei fermentatori per moltiplicare i “suoi” lieviti e i “suoi” batteri (ricordando che in natura non sono quasi mai singoli ceppi ad agire ma quasi sempre consorzi di microrganismi) sarebbe diverso. Ma sarebbe naturale?
«Al bando gli OGM». E se un portinnesto gm (non la parte aerea che porta il frutto ma solo le radici) difendesse la pianta dalle malattie senza modificarne il genotipo, e mi consentisse così di abbattere l’immissione di prodotti chimici nell’ambiente (o minerali: il rame non è per niente innocuo)?
«Al bando i diserbanti». Ma, se invece di usare un diserbo a basso dosaggio a scopo nanizzante su una fila stretta, e con un prodotto a bassa tossicità, faccio due lavorazioni, quanto gasolio in più consumo? Quanta CO2 in più produco?
Con questi esempi non voglio difendere gli ogm, né i diserbanti, ma far notare che il concetto di viticoltura sostenibile o durevole, come dicono i francesi, è più complesso di quello che sembra. Il pensiero biologico si basa sull’assunto che quello che fa la natura è meglio di quello che facciamo noi: il che è vero spesso, ma non sempre.
Siccome la scienza ufficiale ha battuto altre strade, i produttori naturali si trovano a corto di conoscenze su mezzi alternativi ai classici pesticidi (nella mia pedanteria linguistica preferirei non chiamarli così, è una parola che deriva dall’inglese, visto che noi non chiamiamo “pesti” gli insetti nocivi); in natura esistono mezzi potentissimi, ma ci sarebbe bisogno di tanto lavoro di ricerca di base e applicata e, in Italia e in Europa, quasi nessuno lo fa. Voglio però ricordare il centro di sperimentazione per la viticoltura sostenibile che opera a Panzano in Chianti, con pochi mezzi e molto volontariato di Ruggero Mazzilli e dei suoi partner viticoltori. Molto di più si sperimenta in America e in Australia, dove, sotto questo profilo, sono più avanti di noi, alla faccia del Nuovo Mondo nemico del terroir e del Vecchio Mondo suo amico.
Negli ultimi anni si è visto che il latte o il siero di latte combattono efficacemente l’oidio, che le foglie di alcune piante funzionano da diserbante selettivo grazie al principio dell’allelopatia (sofferenza derivante dalla produzione di tossine specifiche da parte di un’altra pianta), e che alcuni preparati microbiologici, a base di funghi e batteri del terreno, migliorano la salute della pianta e la resistenza alle malattie, compresi flagelli devastanti come la flavescenza dorata.
Il viticoltore “convenzionale”, alla mala parata, si fa consigliare dal venditore di prodotti chimici e, in qualche modo, salva il raccolto. Il viticoltore naturale nel bisogno non ha supporto. Gli istituti pubblici di patologia vegetale, nella penuria di finanziamenti statali e regionali, e nonostante gli interessi personali di singoli ricercatori, campano soprattutto grazie ai progetti finanziati dall’industria chimica. La quale è ormai attiva, a sua volta, nello studio delle difese naturali; questo ha consentito di produrre, negli ultimi tempi, molecole di sintesi meno tossiche e di rapido degrado – almeno così viene dichiarato – “copiando” in laboratorio molecole di origine naturale. Ma istituzioni e industria arrivano fino a un certo punto, perché prodotti come il siero di latte e gli aghi di pino non si possono brevettare, monopolizzare e sfruttare per ricavarne profitti: quindi meno se ne sa, meglio è.
In sostanza, i viticoltori naturali avrebbero un grande bisogno di saperne di più e i margini di crescita di queste conoscenze sono enormi. Credo che non tutti ne siano consapevoli a sufficienza. Al contrario, alcuni si rinchiudono in una sorta di autismo: non leggono, non navigano, non si confrontano, non ricorrono ai consulenti… questi ultimi tutti servi delle multinazionali. Pensano che la verità giunga loro in una sorta di sogno sciamanico direttamente dalla madre terra e dagli antenati, o dalle chiacchiere di stregoni itineranti. Siamo stati noi comunicatori a rovinarne qualcuno, suggerendo che forse Dio in persona parlava per bocca loro. Noi scherzavamo, ma loro ci hanno creduto.
In realtà servirebbe proprio un approccio scientifico, sia pure in una prospettiva olistica che non guardi il dito invece della luna (il saggio indica la luna, e lo sciocco, ma anche qualche “scienziato”, vede il dito).
Ciò non toglie che tutti questi viticoltori, con il loro entusiasmo, qualche volta con la loro ingenuità, con le loro diverse declinazioni del naturale, ma soprattutto con l’eccellenza e l’originalità di molti dei loro vini, se non di tutti, siano portatori di una rivoluzione che impone rispetto e umiltà.