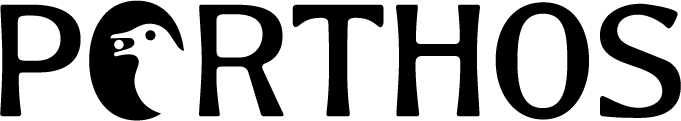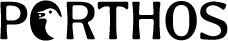10 Mag Ricordo di Franco Allegrini
di Sandro Sangiorgi, foto di Giampi Giacobbo
È impegnativo raccontare la storia di un’amicizia, soprattutto quando l’altro se n’è andato. Sarebbe così facile aiutarsi a vicenda per distinguere le giornate più belle da quelle da dimenticare. La complessità cresce quando ti rendi conto che, per diversi motivi, il legame vive e affronta una progressiva distanza. Ci ho pensato appena ho ricevuto la notizia, all’alba di sabato 23 aprile: com’è possibile che con Franco non ci siamo più visti e anche le telefonate si sono diradate? Credo che il responsabile sia il vino, proprio la bevanda meravigliosa che più di trent’anni fa ci aveva fatto incontrare.
Prima di parlarvi di Franco Allegrini, mi permetto un’utile premessa.
Su porthos.it e sulla rivista ho già affrontato la questione dell’amicizia con i produttori, le produttrici e le loro famiglie, tuttavia voglio rammentarne il senso. Vivo in una posizione delicata: sono un critico enologico, scrivo recensioni su ciò che assaggio e bevo, nella gran parte dei casi da bottiglie coperte. Allo stesso tempo, la mia attività di divulgatore genera conoscenze che, in taluni casi ma non così spesso, diventano vive relazioni entro i confini dei rispettivi mestieri; tra queste alcune possono trasformarsi in amicizie e amori. Davanti a tale intensità di sentimenti vengono meno alcuni doveri deontologici, ciononostante le rare volte che nasce un affetto del genere divento una feroce spina nel fianco dal lato professionale. Quando cresce la vicinanza, aumenta anche l’esigenza di vedere le amiche e gli amici realizzare le loro aspettative, sulle quali posso aver dato un contributo, sempre gratuito.

Con Franco abbiamo condiviso un rapporto privilegiato, sono stati quindici anni caratterizzati da un arricchimento emotivo e intellettuale. Tutto questo è nato dal rapporto personale, un immediato ritrovarsi nelle mille differenze, sostenuto da un’incrollabile fiducia reciproca. Poi siamo andati oltre il vino e, posso dire, mi sono preparato ad affrontare una nuova fase della carriera, ho accompagnato una percezione più empatica nei confronti del liquido, un modo accogliente capace di guardare con la massima ampiezza possibile.
Ricordo, erano i primi anni novanta, quando un collega e conterraneo di Franco – abitavano e producevano entrambi a Fumane – m’invitò a non fidarmi troppo, addirittura mi disse che in Valpolicella era conosciuto come “carognetta”. Appena ebbi il mio primo telefono portatile, la prima cosa che feci è inserire quell’epiteto al posto di Franco Allegrini, glielo mostrai e lui, ridendo, mi fece capire che sapeva di quel soprannome e ne era quasi orgoglioso…
Dicevo del vino, protagonista della vicinanza e della successiva distanza. La prima cosa che facemmo è cominciare a bere i vini degli altri e non solo della sua zona, anzi più lontani erano dalla Valpolicella, maggiore era l’impegno per scardinare le abitudini nelle quali si sentiva imprigionato. Fu gratificante fargli scoprire che alcuni dei suoi prodotti che maturavano in cantina, sui quali aveva delle perplessità, vivevano quella sana sinusoide dell’aprirsi e del chiudersi che li avrebbe portati a essere originali. In particolare l’Amarone dei millesimi tra gli ottanta e la metà dei novanta. Il loro profumo, non di rado “disturbato” all’inizio da qualche interferenza, era dispensato lentamente, giusto il tempo per vedere evolversi la ricercatezza e consolidarla nella corrispondenza con la fase gustativa. La finezza era presente anche nei due Valpolicella, più accattivante il La Grola, più verace il Palazzo della Torre. Poi c’era l’esperimento innovativo, La Poja, un vino ottenuto dal vigneto più alto della collina La Grola, nel quale s’intravedevano gli aspetti di concentrazione e influenza del legno nuovo che, a un certo punto, avrebbero segnato l’intera produzione. Nelle prime versioni, La Poja non era impressionante solo per gli estratti e per la concentrazione odorosa, aveva una vitalità che non era scalfita dalla iper compattezza né dall’uso di botti piccole e nuove. Era un vino affascinante per come usciva dal calice. Infine c’era il Recioto, la scommessa di un’annata adatta a concentrare le uve durante l’appassimento, tanto da creare un mosto che, diventato vino, lasciava in eredità un’amabilità viva e avvincente.
È stato questo il quadro produttivo di un’azienda che ha vissuto un tale successo commerciale da “tirare la volata” – espressione cara a Walter Massa – all’intera Valpolicella, una zona in grado finalmente di svegliarsi dal torpore in cui era immersa da un pezzo.
Approfondire i primi vini di Allegrini, gli esemplari tattili e non forzati, e confrontarli con quelli di Quintarelli e Dal Forno già reputati e costosi, mi permise di credere a un’alternativa alla concentrazione del colore e della corposità, aspetti non più decisivi per delineare la qualità finale. Celai questa osservazione per alcuni anni, sarebbe rispuntata più avanti, prima non ero pronto a sostenerla.

A mano a mano che i prodotti di Allegrini si uniformavano al progetto “La Poja” in un percorso graduale e costante, il vino italiano scopriva un’identità all’apparenza meno provinciale, ispirata a esemplari ambiziosi, in certi casi pieni di storia. A Bordeaux lo Château Margaux del periodo in cui il regisseur era l’innovatore Paul Pontallier, oppure nel Rodano Settentrionale dove il più recente Guigal (1946) stava insidiando il primato allo storico Chapoutier (1808). Un altro riferimento era il vino americano, cileno, australiano, nei quali ricorrevano la gran parte dei vitigni e delle modalità dei produttori sopra citati, nei vini rossi – qui vale la pena usare il termine “vini neri” – e nei vini bianchi. Insieme ad altri cronisti, io vivevo l’emozione e lo stupore per queste concentrazioni inebrianti, schiaccianti sui campioni che nel confronto restituivano una sorta di diluizione, visti i colori più chiari, i profumi da aspettare e i sapori meno pressanti. Si trattava di interpreti che non avevano condiviso un rinnovamento stilistico e produttivo – pensiamo alla draconiana riduzione della resa per pianta. Tale argomento è stato ampiamente esplorato e narrato in diversi numeri della rivista, anche col fruttuoso dialogo con i produttori, tra i quali proprio Franco Allegrini. In particolare nei Porthos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13-14, 16, 17, 18-19, dove c’è una monografia sulla Valpolicella e sull’Amarone, 20, 21, 22, 23, 26, 27 e 30. Si tratta di un argomento e di un passaggio storico del vino italiano e internazionale che meritano uno spazio e un tempo lontani dalla linea di questo pezzo, cionondimeno mi aiutano a fissare alcuni momenti importanti dell’amicizia con Franco. Ero entusiasta della sua svolta, di cui lui mi considerava il mentore, ho contribuito a premiare i vini della sua cantina insieme a quelli interpretati analogamente da aziende di altre regioni, il Piemonte, il Veneto, il Trentino, il Friuli Venezia Giulia, le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo, la Campania, la Sardegna e la Sicilia.
Solo nel 1996 mi accorsi che qualcosa non andava. La partecipazione a degustazioni in regioni differenti sollecitò la sensazione che il modello “concentra e schiaccia” tendeva a uniformare la personalità e l’espressività; prevaleva il “vino bistecca”, impressionante in degustazione e non facile da bere a tavola. In breve cominciai a segnalare il problema, che sarebbe esploso con le annate ’96 e ’97, ai colleghi e a diversi produttori, ma non fu preso in considerazione.
Inoltre tra il 1996 e il 1999 avevo cominciato a frequentare con assiduità i prodotti dei primi interpreti naturali, rappresentati dalla spontaneità e dalla partecipazione gustativa. Persone che negli anni, riscoprendo radici familiari, si erano allontanate da una viticoltura e da un’enologia che progettavano nei minimi dettagli i vini prima di farli, oppure uomini e donne indifferenti a queste innovazioni che, a loro parere, sottraevano ai liquidi la diversità dei luoghi. Dissi a Franco che le bottiglie di Amarone Allegrini della precedente generazione, dall’apparenza meno scintillante, contenevano il segreto di una trasformazione virtuosa in un’evoluzione minuziosa, allo stesso modo dei Valpolicella dalla salina leggiadria. In sostanza non aveva bisogno di inseguire modelli che non appartenevano alla sua cultura e alla consuetudine del territorio. Intanto era nato il progetto Porthos con la rivista e Franco ne era entusiasta. E mentre la nostra amicizia si rafforzava, in virtù di un confronto che per fortuna non prevedeva solo enologia, mi resi conto della sua scelta netta che si sarebbe manifestata di lì a poco. Franco, evidentemente non convinto dagli esemplari che piacevano a me, dei quali avevo messo in luce aspetti in comune coi suoi prodotti più “tradizionali”, stava puntando proprio alla muscolarità del sapore e all’immediata nitidezza dell’effluvio. Cercava la nitidezza estrema e cristallizzata propria dei Premium Wines, celebrati da critici sintonizzati su quei profili e in grado di indirizzare il mercato. Constatato questo, mi resi conto che, per comprendere la qualità dei vini Allegrini, avrei dovuto cercarla sotto quelle inutili sovrastrutture visto l’eccellente potenziale viticolo a loro disposizione. Così, a un certo punto, successe che io e Franco smettemmo di parlare di vino. Temo facessimo finta di non accorgercene, mentre era chiaro che presto il nostro cammino si sarebbe diviso. Cosa sarebbe stato della nostra amicizia? Per un po’ resse grazie alla mia costante presenza in Veneto, invitato da vari soggetti a tenere corsi, lezioni e serate che mi permettevano di andarlo a trovare. Poi, l’impostazione editoriale di Porthos e la scelta di sostenere i produttori naturali ridussero quegli impegni e piano piano cambiai interlocutori. Uno dei miei tanti difetti è non dire proprio tutto quello che sento, per non dover affrontare un confronto complesso, faticoso e che potrebbe portare a un litigio e al rischio di chiudere per sempre la relazione. Rimasero alcune telefonate, soprattutto di Franco che continuava a invitarmi a vedere le novità importanti in fatto di vigneti e cantina; io invece assaggiavo e bevevo le sue bottiglie e non riuscivo più a capirle, sebbene riscuotessero un successo unanime, in Italia e all’estero.
Finalmente nel giugno del 2015 decidemmo di vederci, eravamo entrambi emozionati. Lui mi portò subito a visitare alcuni vigneti appena acquistati, poi la struttura per l’appassimento controllato. Infine andammo a casa sua, io mi ero portato alcune bottiglie da fargli sentire, ovviamente vini naturali. Fu per lui un’esperienza travolgente, non immaginava che prodotti dai primi sentori non del tutto lineari potessero evolversi “lavorati” un pochino nel bicchiere. Tra gli altri fu impressionato dagli effervescenti di Tunia. Colse come stavano in bocca, la salinità e la partecipazione, nei leggeri come nei più strutturati. Franco tirò fuori delle versioni della Poja di 20-25 anni prima, pronte a conquistarci al primo impatto, ancora travolgenti nello sviluppo del sapore, ma col limite di fermarsi dopo alcuni minuti di calice e di apparire dei giovani ibernati dal tempo e, al contatto con l’aria, non capaci di ricostruire un percorso di trasformazione. Vidi nei suoi occhi affacciarsi il dubbio, che si fermò lì.
La sera andammo in un luogo importante per la nostra storia, la Trattoria Caprini di Torbe. Non ho mai capito se la commozione fosse dovuta più ai discorsi e ai ricordi oppure alle memorabili lasagnette.
Dopo alcuni anni di silenzio, all’inizio del 2021 seppi che non stava bene, gli scrissi subito e lui pronto mi rispose che il timore era passato, si sentiva in forma, fiero dei differenti percorsi intrapresi dai figli e sottolineava il privilegio di avere accanto una persona come Marilena, sua moglie. Il tono dei messaggi era rassicurante, felice del contatto.
Franco, ora mi rivolgo a te. È doloroso vivere con la coscienza che tu non sia più qui sulla Terra. Sono convinto che, alla fine dei nostri cammini ellittici, ci saremmo ritrovati, non necessariamente per essere d’accordo, ma col sicuro desiderio di abbracciarci come l’ultima volta. Con la certezza di riprendere il filo dei nostri discorsi, non importa in quale luogo fosse finito.
Per commemorarti e mandare il mio più affettuoso pensiero a tua moglie Marilena, ai tuoi figli che ho visto crescere, all’intera tua famiglia, lascio una poesia che contiene cosa sento, meglio di altre parole.
Il vino degli straccivendoli (Le vin des chiffonniers) di Charles Baudelaire
da I fiori del male, traduzione e versione in prosa di Attilio Bertolucci
Garzanti, Milano, Prima edizione 1975
Spesso, al chiarore rossastro d’un lampione di cui il vento
sbatte la fiamma e tormenta il vetro, nel cuore d’un
vecchio sobborgo, labirinto fangoso dove l’umanità brulica
in fermenti tempestosi,
vedi uno straccivendolo procedere dondolando la testa,
incespicando e urtandosi ai muri come un poeta, e, senza
tener in alcun conto gli spioni, suoi sudditi, dare tutto
il suo cuore a gloriosi progetti.
Pronunzia giuramenti, detta leggi sublimi, umilia i malvagi,
solleva le vittime e s’inebria degli splendori della propria
virtù sotto il cielo sospeso come un baldacchino.
Sì, angustiati da pene famigliari, rotti dalla fatica e
affranti dagli anni, sderenati, piegati sotto una massa di rifiuti
che vomita confusamente l’enorme Parigi,
riemergono, odorosi di bótte, seguiti da compagni incanutiti
nelle battaglie, i baffi pendenti come vecchie bandiere.
Gli stendardi, i fiori e gli archi trionfali
sorgono dinanzi a loro per solenne magia! E nella splendente
e assordante orgia delle trombe, del sole, delle grida
e dei tamburi riportano la gloria a un popolo ebbro d’amore!
È così che, sfolgorante Pàttolo*, il vino fa fluire l’oro
in mezzo alla vana Umanità; attraverso la gola dell’uomo
canta le sue prodezze e regna per mezzo dei doni come
fanno i veri re.
A spegnere il rancore e cullare l’indolenza di tanti vecchi
che muoiono, maledetti, in silenzio, Dio, preso dal rimorso,
creò il sonno; l’Uomo ha aggiunto il Vino, figlio sacro del Sole.
*Il poeta paragona l’azione del vino a quella mitologica del fiume Pàttolo, trasportatore di pepite d’oro.