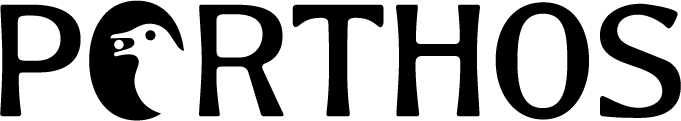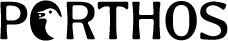22 Gen Schianti!
Schianti! è stato pubblicato su Porthos 37.

Lo so, è assurdo solo pensarlo, però io l’ho pensato. Nel caso di un terremoto devastante, pensavo che se si fosse salvata una sola persona, sarebbe stato lui. Senza tanti dubbi, ci avrei addirittura scommesso, sicuro di vincere. Così quando quella maledetta mattina del 24 agosto del 2016 continuavo a chiamarlo per avere sue notizie, malgrado lui non rispondesse, non ero preoccupato. Lo immaginavo a tirar fuori tutti gli altri dalle macerie. E poi era abituato a non rispondere per giorni al telefono, non lo ricaricava o semplicemente lo lasciava a casa o in auto. Non era certo l’oggetto più importante per la sua vita, perlomeno non quanto il coltello da boscaiolo o la roncola, dalla quale non si separava nemmeno per andare al bar, sempre appesa alla cintola sulla coscia sinistra. La marraccia la chiamava, perché questo è il suo nome tra le montagne di Arquata del Tronto. Invece, quando alle nove e mezza squillò il mio di cellulare non era lui che chiamava. La voce di un amico mi diceva che il suo corpo era stato il primo a essere tirato fuori senza vita dalle macerie della sua casa di Pescara del Tronto, il dolore muto non riusciva a far breccia nella sensazione di incredulità. Continuavo a chiedere se erano sicuri che fosse lui, se magari non si sbagliassero con un altro, se insomma non ci fosse un errore di persona, possibile in quella situazione apocalittica. Invece no, colui che per me era un highlander dei Sibillini stavolta non ce l’aveva fatta. L’uomo capace di vivere per giorni da solo nei boschi, affrontare cinghiali all’arma bianca, caricarsi sulle spalle un lupo ferito, irridere serpi velenose, che a soli cinquant’anni aveva già beffato la morte, ripreso per un pelo da due infarti micidiali.
Colombo collaborava con me e con Stefano Amerighi al progetto di recupero di una vigna di Pecorino a Trisungo, frazione di passaggio di Arquata del Tronto. Avevamo disperatamente bisogno di aiuto e alla fine dell’estate del 2013 Noè ce l’aveva presentato come un suo nipote alla lontana. Ci disse che era la persona giusta, anche se di fatto della vigna non gliene fregava niente e non ne voleva neanche sapere di imparare a potare o a legare. Col tempo scoprimmo che in compenso sapeva tutto sul mondo degli alberi, il cui legno non aveva segreti per lui, ne conosceva vibrazioni e funzioni. Con un’ascia, una motosega e la sua marraccia poteva costruire un villaggio da solo. Ma soprattutto con lui iniziò la nostra integrazione nella comunità arquatana, era il nostro angelo custode sui Sibillini, ci guidò alla scoperta di ogni angolo in cui ci fosse una vite di Pecorino superstite. Conosceva tutti e non aveva paura di nessuno. E non aveva peli sulla lingua, Colombo, e si poteva permettere di dire in faccia a un vignaiolo acclamato come Stefano: «Amerighi tu non capisci un cazzo», senza che questi riuscisse a controbattere, non so se perché ne avesse timore o perché si fosse insinuato in lui il dubbio che forse qualche ragione quell’uomo ce l’aveva.
Così la sera del 12 ottobre del 2015 alla fine della giornata di vendemmia, quando i fuochi della grandiosa festa sul fiume erano spenti e il mosto riposava nelle vasche, ci chiese di raccogliere l’uva avanzata perché «ve lo faccio vedere io come si fa il vino», restammo di sasso ma non potevamo certo rifiutare. Era stata un’annata di grazia, in realtà l’unica nei sette anni di lavoro ad Arquata, e ci eravamo permessi il lusso di scartare l’uva che ci piaceva di meno. Erano avanzate ben tre casse di uva bianca. Con il suo fedelissimo compagno Marcello, il giorno dopo andò a raccogliere tutta l’uva rossa che avevamo lasciato in pianta, la aggiunse a quella delle casse avanzate, la dirasparono con le mani dentro un carrello della spesa, la pigiarono con i piedi e la misero a fermentare in una grotta adibita a cantina, di fianco alle nostre botti. Era una vasca di vetroresina da tre quintali che era andato a scovare in una delle tante vecchie cantine di Arquata.
Nelle settimane seguenti andò quotidianamente due volte al giorno alla grotta per seguire le fermentazioni, misurare le densità di tutte le vasche e appuntarle sul suo quaderno di “vinologia”. Era quello il suo compito che portava a termine con zelo esemplare, dopo ogni misurazione mi telefonava per relazionare. Non disse mai una parola sul suo vino. Quando tutte le fermentazioni giunsero a termine ci trovammo con Stefano un sabato mattina di inizio novembre per l’assaggio. Prima di andar via, quasi per non fargli uno sgarro, assaggiammo anche la vasca di Colombo che lesse nei nostri occhi e nel nostro silenzio tutta la nostra incredulità. Era buonissimo, pulito, senza un difetto e miracolosamente equilibrato. Per dare una giustificazione storica a quel risultato stupefacente gli dissi che in origine il disciplinare del Chianti prevedeva l’uso misto di uve bianche e rosse. «Ah si? Allora abbiamo fatto lo Schianti!» Rispose con la sua risata fragorosa e strafottente. Una buona metà la consumarono già per la festa di San Martino. Il resto Colombo lo mise in bottiglie con il tappo a corona, per bersele con gli amici al bar durante le sere del lungo inverno di montagna. Quando giunse l’estate lo Schianti era finito da un pezzo e io non ebbi più l’occasione di berlo. Diversi mesi dopo il terremoto, al bar di Trisungo giurarono di aver visto una di quelle inconfondibili bottiglie sul muretto di pietra dell’argine del Tronto. Corsi giù al fiume per vedere. Non c’erano bottiglie, nemmeno vuote, ma quel posto conservava sempre un’aura di magia. Il prato verde lucente, l’aria profumata e rigenerante, la luce occidua del tramonto allungava le ombre degli alberi fin dentro l’acqua trasparente. Pensai che avrei dovuto rifare lo Schianti.