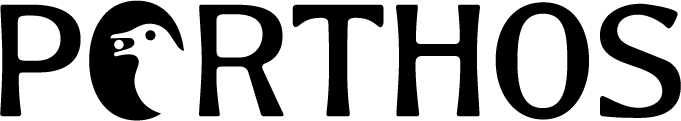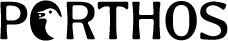11 Dic Il topo e il var
Posted at 12:46h
in Blog
ha collaborato emanuela conversano
Avete presente quando siete davanti a una partita, non importa se allo stadio, alla radio o davanti alla tv, e segna la vostra squadra del cuore? Saprete allora che, fino a poco tempo fa, potevate scatenare un’esultanza fragrante e liberatoria, mentre oggi non è più così. Sono molte le volte nelle quali l’urlo ci si blocca nella gola e finisce che ce lo rimangiamo a causa del VAR – video assistant referee – che annulla la rete appena segnata. Ecco, qualcosa del genere accade anche nel vino.

Essere innamorati dei vini naturali ha comportato sempre qualche sacrificio e a tratti è stato faticoso. Lo sforzo è stato ricompensato, sia dal lato propriamente emotivo della relazione col liquido odoroso, sia, e forse ancora di più, dalla possibilità di recuperare finalmente l’approccio unitario che va sempre riservato a una forma d’arte. Le cose, negli ultimi anni, non si sono fatte più semplici. Anzi, com’era inevitabile – e ampiamente previsto e descritto da Porthos sulla rivista e sul sito – la nascita di tante realtà del tutto nuove e la conversione ai regimi biologico e/o biodinamico di molte aziende convenzionali ha generato un’intensa crisi di crescita. I problemi sono molti, diversi di non facile soluzione, cercheremo di esporne la gran parte sull’ultimo numero della rivista. In questo pezzo vorrei riflettere brevemente e senza alcuna ambizione scientifica sulla sensazione che i francesi definiscono “souris” e a me sembra vicina alla buccia di salame andato a male. Non è tanto un odore-gusto rancido o di muffa, mi ricorda piuttosto la pasta della carne di maiale poco curata e il suo budello non pulito bene. Souris, che significa “topo”, si riferisce all’odore dell’urina dell’animale, una percezione che non sono ancora riuscito a catalogare e per ora associo a una sciatta norcineria.
I microbiologi da noi contattati non hanno una risposta precisa, alcuni sostengono che sia un aggravamento degli effetti dovuti ai lieviti brettanomyces, una specie di “libera tutti” batterico dal qual scaturisce tale mefitica espressione monocorde e irreversibile. Altri si rifanno alla proliferazione di batteri lattici di natura imprevedibile, e poco conosciuta, che prendono il sopravvento a causa dei sempre più alti pH dei mosti e dei prodotti finiti. Negli ultimi quindici anni, da una media intorno a 3,30, considerato un dato ottimale, si è passati a un pH di oltre 3,60. Nel vino è una forbice sensibile che ha generato scenari microbiologici del tutto nuovi, tanto che anche professionisti abituati a trattare liquidi complicati non riescono a orientarsi.
Il continuo confronto con vignaioli-vinificatori – donne e uomini che si dedicano a una materia prima di qualità e poi cercano di realizzare un grande vino in cantina – ci ha dato quella che pare l’unica certezza: se le uve non sono perfettamente sane aumentano i rischi di inaspettate deviazioni batteriche. Inoltre, in coincidenza con la macerazione sulle bucce – si tratta quindi di un problema che non prevede eccezioni tra bianchi, rosati, rossi, neri, frizzanti, spumanti e vini dolci o da meditazione – è più elevata la possibilità che i batteri siano particolarmente arzilli quando è ancora attiva la fermentazione alcolica. Così, se non si vuole usare l’anidride solforosa come minimo selezionatore della microflora, diventa indispensabile assicurarsi che non ci siano arresti di fermentazione, perché su quello zucchero residuo si getterebbero i suddetti batteri facendo danni quasi irreparabili. La sensazione di un salame andato a male non è una scoperta recente, io la ricordo già quarant’anni fa collegata a vini contadini malfatti. È di quel periodo la diffusione capillare di una minima competenza tecnologica atta a limitare quei difetti gravi che, talvolta, potevano essere addirittura considerati impronte del terroir.
A cavallo tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo secolo, l’odore di buccia di salame ammalata è rimasto confinato nei liquidi ancora contenuti nelle vasche – non importa se di legno, di cemento, di acciaio o di vetroresina – e presto indirizzati alle fogne comunali. Fino a qualche anno fa, era raro reperire il gusto di “souris” in prodotti imbottigliati e in vendita: a voler pensare alle lacune più ricorrenti della produzione naturale vengono in mente forti riduzioni, prevalenza obnubilante di sentori organici e acidità volatili molto pungenti. Negli ultimi due anni il numero di bottiglie “topate” è aumentato fino a raggiungere livelli preoccupanti. Protagonisti di questi incidenti sono stati all’inizio produttori e produttrici della nuova leva: incoraggiati dalla spontaneità a prescindere da tutto, hanno rinunciato all’anidride solforosa senza però la minima competenza e consapevolezza di cosa accade tra la vigna e la cantina e durante la fermentazione. Il mercato degli innamorati dei vini naturali si è riempito di bottiglie di sconosciuti interpreti francesi e spagnoli che hanno fatto della sciatteria una specie di marchio distintivo. Ciononostante – o forse proprio per questo – hanno reperito clienti un po’ ovunque, soprattutto nei Paesi dell’estremo Oriente, dove hanno inviato vini che da noi non avrebbero meritato neanche il lavandino. Per molti neofiti del vino naturale in Italia – aspiranti produttori, enotecari o semplici appassionati – il passo è stato breve: entusiasmati dagli assaggi fatti in anteprima presso le aziende sedicenti naturali, orgogliose del motto “zero solfiti aggiunti”, o nelle sempre più numerose fiere in giro per l’Europa, questi novelli degustatori hanno pensato che quel loro fugace contatto col vino bastasse per afferrarne un profilo esaustivo. Invece l’odore-gusto di salame cattivo è subdolo, non è facile acchiapparlo alla prima annusata, il liquido deve stare nel calice anche quindici minuti prima che il difetto dia le sue avvisaglie odorose, ma spesso è necessario aspettare il giorno dopo affinché il problema si manifesti completamente a livello aereo. Intanto, è stato possibile godersi un’espressività libera e vivace, per cui fino a quando non lo si mette in bocca è difficile coglierne la gravità. Bisogna che il vino passi la fase centrale dello sviluppo gustativo e, appena lo si deglutisce, nell’effluvio che attraversa la via retronasale compare inequivocabile l’odore incriminato. Da un paio d’anni cominciano a essere coinvolte anche aziende finora capaci di concepire i processi della produzione naturale con grande senso di responsabilità.
Parte della situazione ruota attorno all’uso dell’anidride solforosa. Rinunciarvi a prescindere, considerando la scelta un atto eroico e per questo da premiare comunque vada, si sta rivelando un errore paragonabile al tanto criticato uso dei lieviti selezionati senza considerare la possibilità della fermentazione spontanea. I dogmi, gli assolutismi, se talvolta e da qualche parte hanno funzionato, non è stato certo nell’ambito della viticoltura e dell’enologia. Conoscenza e capacità di far fruttare le esperienze sono la base di quel principio chiamato “osservazione dei fenomeni e delle situazioni” che prevede un’intelligenza versatile e pronta. A queste qualità va associata l’abilità della lettura sensoriale, senza la paura di essere sorpresi dal proprio vino e senza temere di notare che qualcosa non torna. Ogni produttore naturale ha sperimentato la perdita di una partita, di una vasca, rinunciando a imbottigliare, senza sottrarsi alla responsabilità verso il cliente. Oggi è percettibile la difficoltà di fare un passo indietro, con la speranza che l’imperfezione o il difetto possano trovare una soluzione nel vetro. Finora abbiamo provato che accade il contrario, una minima lacuna si amplifica e solo una volta ci è parso che il gusto di topo diminuisse con l’affinamento di alcuni mesi. In altri casi abbiamo notato differenze di entità a seconda delle giornate, spesso in coincidenza col movimento della Luna. Alcune aziende stanno da tempo sperimentando una tale riduzione dell’anidride solforosa da portarla quasi a zero, eppure le loro bottiglie non presentano difetti. Evidentemente hanno reso ancora più accurata la preparazione della vendemmia, più severa la selezione delle uve prima di avviarle alla pigiatura (o pressatura), in attesa poi che la prima fermentazione parta spontaneamente. Questo approccio non è da confondere con l’uso del “pied de cuve”, sorta di acceleratore delle trasformazioni ma, contemporaneamente, anche riduttore della varietà e dell’imprevedibilità. Tali qualità fondamentali sono originate da quel libero mutamento che nasce e si sviluppa contando solo sulle proprie forze, i lieviti della vigna e della cantina. Alcune figure coinvolte nella produzione ci hanno segnalato che talvolta è proprio il “pied de cuve” a esporre il mosto-vino a batteri eccentrici dai quali arriva il gusto di topo. Un aspetto che andrebbe compreso è l’unicità che ogni fermentazione spontanea genera per ciascuna vasca, non importa se da 200 litri o da 200 quintali. La cantina è per antonomasia un luogo contaminato – possiamo immaginare durante la vendemmia – ma ciò non impedisce a ogni unità di crearsi un’identità irripetibile.
La nostra intenzione è continuare ad approfondire il fenomeno e cercare di unire i punti che collegano la degustazione e la bevuta di determinate bottiglie, il confronto con chi le ha prodotte e il lavoro dei microbiologi. Anche perché, almeno da innamorati del vino naturale, vorremmo evitarci quella delusione che ci assale da tifosi quando il var annulla il gol per un’irregolarità nell’azione.
I microbiologi da noi contattati non hanno una risposta precisa, alcuni sostengono che sia un aggravamento degli effetti dovuti ai lieviti brettanomyces, una specie di “libera tutti” batterico dal qual scaturisce tale mefitica espressione monocorde e irreversibile. Altri si rifanno alla proliferazione di batteri lattici di natura imprevedibile, e poco conosciuta, che prendono il sopravvento a causa dei sempre più alti pH dei mosti e dei prodotti finiti. Negli ultimi quindici anni, da una media intorno a 3,30, considerato un dato ottimale, si è passati a un pH di oltre 3,60. Nel vino è una forbice sensibile che ha generato scenari microbiologici del tutto nuovi, tanto che anche professionisti abituati a trattare liquidi complicati non riescono a orientarsi.
Il continuo confronto con vignaioli-vinificatori – donne e uomini che si dedicano a una materia prima di qualità e poi cercano di realizzare un grande vino in cantina – ci ha dato quella che pare l’unica certezza: se le uve non sono perfettamente sane aumentano i rischi di inaspettate deviazioni batteriche. Inoltre, in coincidenza con la macerazione sulle bucce – si tratta quindi di un problema che non prevede eccezioni tra bianchi, rosati, rossi, neri, frizzanti, spumanti e vini dolci o da meditazione – è più elevata la possibilità che i batteri siano particolarmente arzilli quando è ancora attiva la fermentazione alcolica. Così, se non si vuole usare l’anidride solforosa come minimo selezionatore della microflora, diventa indispensabile assicurarsi che non ci siano arresti di fermentazione, perché su quello zucchero residuo si getterebbero i suddetti batteri facendo danni quasi irreparabili. La sensazione di un salame andato a male non è una scoperta recente, io la ricordo già quarant’anni fa collegata a vini contadini malfatti. È di quel periodo la diffusione capillare di una minima competenza tecnologica atta a limitare quei difetti gravi che, talvolta, potevano essere addirittura considerati impronte del terroir.
A cavallo tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo secolo, l’odore di buccia di salame ammalata è rimasto confinato nei liquidi ancora contenuti nelle vasche – non importa se di legno, di cemento, di acciaio o di vetroresina – e presto indirizzati alle fogne comunali. Fino a qualche anno fa, era raro reperire il gusto di “souris” in prodotti imbottigliati e in vendita: a voler pensare alle lacune più ricorrenti della produzione naturale vengono in mente forti riduzioni, prevalenza obnubilante di sentori organici e acidità volatili molto pungenti. Negli ultimi due anni il numero di bottiglie “topate” è aumentato fino a raggiungere livelli preoccupanti. Protagonisti di questi incidenti sono stati all’inizio produttori e produttrici della nuova leva: incoraggiati dalla spontaneità a prescindere da tutto, hanno rinunciato all’anidride solforosa senza però la minima competenza e consapevolezza di cosa accade tra la vigna e la cantina e durante la fermentazione. Il mercato degli innamorati dei vini naturali si è riempito di bottiglie di sconosciuti interpreti francesi e spagnoli che hanno fatto della sciatteria una specie di marchio distintivo. Ciononostante – o forse proprio per questo – hanno reperito clienti un po’ ovunque, soprattutto nei Paesi dell’estremo Oriente, dove hanno inviato vini che da noi non avrebbero meritato neanche il lavandino. Per molti neofiti del vino naturale in Italia – aspiranti produttori, enotecari o semplici appassionati – il passo è stato breve: entusiasmati dagli assaggi fatti in anteprima presso le aziende sedicenti naturali, orgogliose del motto “zero solfiti aggiunti”, o nelle sempre più numerose fiere in giro per l’Europa, questi novelli degustatori hanno pensato che quel loro fugace contatto col vino bastasse per afferrarne un profilo esaustivo. Invece l’odore-gusto di salame cattivo è subdolo, non è facile acchiapparlo alla prima annusata, il liquido deve stare nel calice anche quindici minuti prima che il difetto dia le sue avvisaglie odorose, ma spesso è necessario aspettare il giorno dopo affinché il problema si manifesti completamente a livello aereo. Intanto, è stato possibile godersi un’espressività libera e vivace, per cui fino a quando non lo si mette in bocca è difficile coglierne la gravità. Bisogna che il vino passi la fase centrale dello sviluppo gustativo e, appena lo si deglutisce, nell’effluvio che attraversa la via retronasale compare inequivocabile l’odore incriminato. Da un paio d’anni cominciano a essere coinvolte anche aziende finora capaci di concepire i processi della produzione naturale con grande senso di responsabilità.
Parte della situazione ruota attorno all’uso dell’anidride solforosa. Rinunciarvi a prescindere, considerando la scelta un atto eroico e per questo da premiare comunque vada, si sta rivelando un errore paragonabile al tanto criticato uso dei lieviti selezionati senza considerare la possibilità della fermentazione spontanea. I dogmi, gli assolutismi, se talvolta e da qualche parte hanno funzionato, non è stato certo nell’ambito della viticoltura e dell’enologia. Conoscenza e capacità di far fruttare le esperienze sono la base di quel principio chiamato “osservazione dei fenomeni e delle situazioni” che prevede un’intelligenza versatile e pronta. A queste qualità va associata l’abilità della lettura sensoriale, senza la paura di essere sorpresi dal proprio vino e senza temere di notare che qualcosa non torna. Ogni produttore naturale ha sperimentato la perdita di una partita, di una vasca, rinunciando a imbottigliare, senza sottrarsi alla responsabilità verso il cliente. Oggi è percettibile la difficoltà di fare un passo indietro, con la speranza che l’imperfezione o il difetto possano trovare una soluzione nel vetro. Finora abbiamo provato che accade il contrario, una minima lacuna si amplifica e solo una volta ci è parso che il gusto di topo diminuisse con l’affinamento di alcuni mesi. In altri casi abbiamo notato differenze di entità a seconda delle giornate, spesso in coincidenza col movimento della Luna. Alcune aziende stanno da tempo sperimentando una tale riduzione dell’anidride solforosa da portarla quasi a zero, eppure le loro bottiglie non presentano difetti. Evidentemente hanno reso ancora più accurata la preparazione della vendemmia, più severa la selezione delle uve prima di avviarle alla pigiatura (o pressatura), in attesa poi che la prima fermentazione parta spontaneamente. Questo approccio non è da confondere con l’uso del “pied de cuve”, sorta di acceleratore delle trasformazioni ma, contemporaneamente, anche riduttore della varietà e dell’imprevedibilità. Tali qualità fondamentali sono originate da quel libero mutamento che nasce e si sviluppa contando solo sulle proprie forze, i lieviti della vigna e della cantina. Alcune figure coinvolte nella produzione ci hanno segnalato che talvolta è proprio il “pied de cuve” a esporre il mosto-vino a batteri eccentrici dai quali arriva il gusto di topo. Un aspetto che andrebbe compreso è l’unicità che ogni fermentazione spontanea genera per ciascuna vasca, non importa se da 200 litri o da 200 quintali. La cantina è per antonomasia un luogo contaminato – possiamo immaginare durante la vendemmia – ma ciò non impedisce a ogni unità di crearsi un’identità irripetibile.
La nostra intenzione è continuare ad approfondire il fenomeno e cercare di unire i punti che collegano la degustazione e la bevuta di determinate bottiglie, il confronto con chi le ha prodotte e il lavoro dei microbiologi. Anche perché, almeno da innamorati del vino naturale, vorremmo evitarci quella delusione che ci assale da tifosi quando il var annulla il gol per un’irregolarità nell’azione.