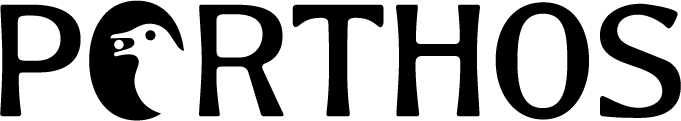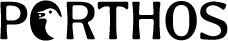30 Mar Intervista a Davide Vanni
D: L’anno successivo tornai dal pastore.
S: Quindi hai lavorato in alpeggio due volte?
D: No, tornai per fare un documentario. Mentre ero lì avevo conosciuto la storia della Valle e della diga che avevano costruito nello stesso periodo di quella del Vajont.
S: Le due dighe avevano progetti simili?
D: Ad accomunarle era la pericolosità, il territorio nel versante della valle era a rischio frane. Nella documentazione avevo ritrovato la dichiarazione di un geologo parlamentare che aveva sconsigliato di costruire una diga proprio lì.
S: Interessante.
D: Però la costruirono lo stesso e i sette villaggi che erano nel letto di quello che sarebbe stato il lago artificiale vennero allontanati. La gente comprò casa con i soldi dello Stato e ognuno se ne andò, chi in Val Pedina, chi nelle altre valli.
S: Sei andato a parlare con loro?
D: Sì, sono andato a cercare le loro storie. Quello che m’interessava era avvicinarmi per far risuonare il passato. Un modo per sentirmi più dentro la vita.
S: E anche in questo lavoro usi musiche composte da tuo padre?
D: No, registrai il coro in patois della chiesa di Valgrisenche. Chiesi espressamente di recitarmi delle frasi che scrissi e di musicarmele in coro.
S: A te piace il freddo?
D: Sì.
S: Valle d’Aosta e Basilicata sono due delle regioni più fredde d’Italia.
D: Oddio, il deserto lucano in agosto forse è uno dei posti più caldi d’Italia.
S: Però d’inverno le temperature medie della Lucania sono toste.
D: Soprattutto sono zone di vento, entrambe.
S: Alla luce di queste esperienze, quando finisce la scuola, capisci subito che non avresti potuto vivere di arte visiva e decidi di cercare lavoro?
D: No.
S: E quanto sei rimasto lì a menartela?
D: Altri tre anni. Volevo qualcosa di non troppo impegnativo, che non mi prendesse tutto il giorno.
S: Eri un bamboccione… Abitavi ancora con i tuoi?
D: No, no. Avevo trentuno anni e da più di dieci vivevo per conto mio e non chiedevo soldi a casa.
S: Te la dovevi cavare da solo: treni, autobus… Non avevi la macchina.
D: Già. Lavorai per un po’ con un fotografo che faceva matrimoni. Era un modo per tirar su due soldi, campavo con cinquecento euro il mese.
S: E dove vivevi?
D: A Torino, in appartamento con due amici.
S: Torino è stato un luogo di formazione, di lavoro?
D: È stato un luogo di attesa esistenziale.
S: Poi cosa scatta che ti porta a cercare lavoro?
D: A un certo punto arrivò la telefonata del responsabile di una televisione satellitare. Disse di aver visto dei miei video e mi chiese se ero interessato a lavorare per lui. Venni a Roma un paio di volte per qualche colloquio, poi mi fece scrivere un progetto su un format legato a dei paesaggi, villaggi e al viaggio. Alla fine non se ne fece niente perché mi dissero che non c’erano soldi.
S: Che strano…
D: Allora decisi di andare a Madrid, dove avevo un’amica che aveva fatto con me il campus in Basilicata.
S: Quindi lasci l’appartamento di Torino?
D: Lascio qualsiasi cosa.
S: Ti porti solo la macchina fotografica?
D: Quella, il microfono, il computer e una volta il mese mi arrivava un pacco con alimenti italiani [ride]. Una volta ogni tre mesi, va! Vissi un anno a Madrid e trovai un part time con un’associazione che si occupava di autismo.
S: La lingua non era un problema?
D: Imparai molto rapidamente. Poi conobbi un colombiano che aveva un’idea per un documentario su dei musicisti, suoi connazionali, e mi misi a realizzarlo. Fu un modo per entrare concretamente in una parte di Madrid. Credo che sia l’esperienza che mi ha dato di più, grazie a storie di migrazioni interne ed esterne. Il documentario parla di chi ha raggiunto Madrid dalla campagna e dai paesi vicini in epoca franchista o in momenti di crisi e povertà. E di chi ha attraversato l’oceano.
S: E poi torni?
D: Sì, per amore di una donna.
S: Italiana?
D: Sì. A Madrid lavoro non ce n’era.
S: Dove l’avevi conosciuta?
D: Durante il mio tirocinio di psicologia.
S: E siete rimasti amici?
D: Sì, lei era una donna sposata. Ci siamo risentiti quando ero a Madrid e le cose si sono un po’ incanalate. Io ero timoroso di restare lì perché non c’era niente da sviluppare. Avevo appena finito di fare il documentario, ma non c’era niente di solido e concreto.