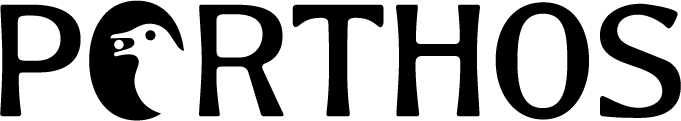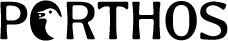01 Lug Io autoctono, tu autoctoni, egli autoctona…
Ne parlano tutti, ma proprio tutti, dalle portinerie ai bar dello sport. Qualcuno addirittura ne scrive, e allora noi…
Magicamente tutti d’accordo. Come quando gioca la Nazionale, o quando ci si mette a tavola in un ristorante di un Paese ostinatamente non spaghettivoro. Allora l’Italiano diventa Italiano. E’ come una piccola magia: il soggetto che sul suolo natìo si definisce Romano, Milanese, Rovigino, Nisseno, Brindisino, Frusinate, Senese, in queste misteriose condizioni diviene Italiano.
Seduti a questo seminario nella cornice della gloriosa Scuola Enologica di Conegliano, le diverse voci della critica, del commercio e della ricerca enologici si uniscono in coro. Il seminario, con il suo lauto corollario di aperitivi, degustazioni, cene pranzi e colazioni, è organizzato dalla Carpenè Malvolti SpA, azienda orgogliosa di aver raggiunto l’obiettivo di una fidata produzione semi-industriale a partire da un vitigno autoctono: il prosecco. Risultato: qualche milione di bottiglie di quello che è uno dei più celebri vini spumanti italiani esportati nel mondo. “Valorizzazione e confronto di una ricchezza italiana: I vitigni autoctoni”, questo è il tema. Relatori alcuni fra i più noti nomi del settore: il professor Attilio Scienza, dell’Università degli Studi di Milano; Donato Lanati, enologo; Roger Voss, di “Wine Enthusiast Magazine”; Enzo Vizzari, delle “Guide dell’Espresso”; Paolo Marchi, de “Il Giornale”; Marco Sabellico, del “Gambero Rosso”; Antonio Paolini, giornalista enogastronomico.
Tutti concordi – come il numeroso pubblico nazionale e non in platea – sulle potenzialità di quella immensa miniera d’oro che sono per il Bel Paese (o non dovremmo piuttosto chiamarlo Enotria, come già sagacemente i greci?) i vitigni autoctoni. Già, perché “l’attuale rinnovato interesse è essenzialmente di natura economica – ricorda Scienza – e nasce in contrapposizione alla crescente diffusione di pochi vitigni detti internazionali, diffusi soprattutto nelle viticolture del Nuovo Mondo e dalla necessità di creare nuove nicchie di consumo in un mercato del vino che esige una sempre maggiore segmentazione”.
Insomma: se fino ad ora si è piantato merlot nel Chianti, cabernet in Langa e chardonnay in Sicilia, adesso questi viaggiatori poco esigenti ci escono dalle orecchie, ed è ora di riscoprire il pugnitello, la freisa, il grillo. Ma si alza anche il grido d’allarme di Lanati: “I vitigni autoctoni sono stati ignorati per circa vent’anni; ora stanno tornando alla ribalta e ‘rischiano’ di diventare di moda. Generalizzare la loro coltivazione può essere un errore perché abbisognano di vinificazioni mirate e soprattutto si deve prendere coscienza che non dànno grandi prodotti al di fuori dei loro territori d’origine, dove secoli di coltivazione hanno individuato la sintonia tra ambiente e varietà”. D’accordo, ma Paolini aggiunge giustamente una cosa: “Cabernet sauvignon, merlot, chardonnay. Pensiamoci un attimo. Tutt’e tre questi globetrotter sono in realtà di fatto, e di diritto starei per dire, degli autoctoni”. Verissimo, e dimenticato: chi negherebbe la paternità bordolese e borgognotta di queste tre cultivar? Chi vuol sostenere che uno chardonnay – di qualunque parte del mondo – sia la stessa cosa di un Puligny-Montrachet? Ma allora che differenza c’è fra internazionali e autoctoni? Nobiltà? Forse è più preciso dire “sfiga”. Nel senso che gli autoctoni, per genetica, non sono mai diventati internazionali anche perché hanno minore capacità di adattamento, sono più difficili da coltivare e vinificare, e tendono a smarrire le loro peculiarità appena si allontanano da casa. Lanati ci spiega: “Il livello qualitativo di un vino dipenderà dall’equilibrio di macro e microelementi presenti nel suo insieme”. La buccia dell’acino, in questa prospettiva, è centrale: vi si trovano antociani, tannini, precursori aromatici e, come ricorda Lanati, “il 95 per cento circa delle molecole che caratterizzano il bouquet che si riscontra in un vino invecchiato è già presente nell’acino”. Se è vero che gli internazionali hanno 15/16 strati di cellule tra epidermide e ipoderma, e gli autoctoni solo 4 o 5, si deve tornare a parlare di sfiga. Non solo: fra i cinque antociani che conferiscono colore ai vini rossi, cabernet e merlot vedono prevalere la malvidina, “che fa assumere al vino un colore concentrato”. Nel caso di nebbiolo e sangiovese, invece, la cessione di sostanza e materia è più difficoltosa e delicata. Inoltre solo loro hanno vinaccioli che tendono a cedere tannini – non sempre desiderabili – anche a maturità avvenuta. Normale, normalissimo che se li filino in pochi… Se poi aggiungiamo che lontani da casa fanno bizze a tutto spiano… Ed essendo il modello commerciale quello che è: muscoli, colore, densità, potenza… “Non possiamo permetterci di sbagliare – chiosa Lanati – mentre un enologo francese può sbagliare 3 o 4 volte…”.
Ma allora perché insistere sugli autoctoni? Perché non prediligere solo quei vitigni che hanno ricevuto più graziadidìo? La risposta non è complicata, e si chiama biodiversità. “Biodiversità – fa notare Paolini – che come metafora può essere assunta anche come ‘biodiversità del giudizio’ da parte della critica, e ‘biodiversità del gusto’, da parte del consumatore”. E Scienza: “Il vitigno autoctono, più che buono o non buono, è diverso, che è una cosa più importante”. L’Italia è benedetta: ci sono attualmente circa 150 autoctoni in produzione, 250 in coltura, e altri 3/400 da recuperare. Il professor Scienza in pochi mesi di “archeologia ampelografica” in Calabria ne ha riesumati 110, sovente trovati in pochi esemplari all’interno di vigneti promiscui abbandonati. La perdita di biodiversità non è un fenomeno recente – ne parlava già Catone -, né reversibile, ma questa erosione genetica del patrimonio ampelografico può essere frenata. Il premio: la varietà. “Rispetto al passato – spiega Scienza – i progetti di recupero delle varietà antiche non prevedono solo la raccolta museale delle piante nelle collezioni ma il loro reinserimento attivo nella viticoltura dove sono state selezionate e conservate fino ad ora. I veri custodi di questa ricchezza sono i viticultori. Non esistono alternative, perché attualmente non ci sono mezzi, non c’è interesse universitario… E’ necessario realizzare una rete di viticoltori custodi affinché nei loro vigneti venga conservata una elevata variabilità intervarietale, dalla quale non si può prescindere per una successiva azione di selezione clonale”. Altolà. A noi di Porthos che ci vogliamo “giornalisti custodi”, si drizzano le orecchie e drizziamo la mano per intervenire. “Valorizzazione degli autoctoni – chiediamo al professore -. Quale e quanta parte di questa spetterà e deve spettare, a suo giudizio, alla selezione clonale”? “Il discorso della selezione genetica è molto delicato. L’autoctono è un vero e proprio ricettacolo di virosi. È difficile trovare una pianta sana, e poi provvedere al risanamento. Fra l’altro il rischio è quello di un estremo impoverimento. La soluzione è probabilmente quella di una selezione debole: si selezionano 10/15 individui che rappresentino la molteplicità del vitigno, attraverso una distribuzione delle diverse caratteristiche. Da questo gruppo si estrarranno i cloni da utilizzare per riprodurre la variabilità”. Stiamo dunque parlando di una selezione clonale “ad impatto ridotto”. Non siamo agronomi, scienziati né ampelografi, ma una cosa, di cui ci siamo interessati molto di recente, ci torna subito alla mente. Una viticultrice che ci è cara lavora esclusivamente su autoctoni, quelli che il suo territorio ha selezionato a custodito da sé. Lei fa solo selezione massale. Le sue piante non sono esenti da virosi; l’università che era venuta a prelevare dei campioni si è dichiarata disinteressata proprio per questo motivo. Il suo vino è uno dei migliori dell’ampia denominazione nella quale risiede e lavora. Nel suo vino passa tutta la forza del terroir sul quale i suoi ceppi sono piantati.
Autoctono è bello, ma la paura di una severa selezione clonale, dell’utilizzo indiscriminato dei lieviti selezionati, dei prodotti di biotecnologia in vigna e in cantina, e di tante altre diavolerie non riesce proprio ad abbandonare i nostri pensieri. Insomma: a quanto può servire cercare la diversità se poi la si schiaccia in altre cento maniere? Se diventano di moda, gli autoctoni finiranno per divenire tanti piccoli internazionali tuttofare?