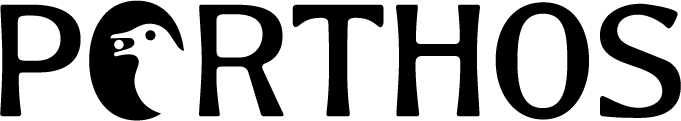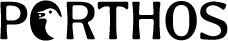30 Ott Parma, nel mio torrente pieno di pensieri
La bicicletta è il mezzo più importante e divertente con cui guardare una città; dopo i piedi naturalmente! Ma, per me, è l’oggetto del ricordo.
Rimanga dov’è, questa è una città in amore della vita.
Guido Picelli in una lettera a Gabriele D’Annunzio
La meraviglia delle biciclette mi ha sempre affascinato. Fin da piccola, quando scorrazzavo tra un cortiletto e l’altro delle case del quartiere. Pensavo alla Cina, di cui ho sempre conosciuto nome e importanza politica perché mio padre era sindacalista e i nomi come “Pechino”, “Mosca”, “Cuba” negli anni Ottanta erano sempre sulla bocca di qualcuno. Mi sentivo una piccola cinesina, e ancora oggi, mentre pedalo sulla mia scalcinata bici nero petrolio+ruggine, tra un borghetto e l’altro, penso alla Cina in una sorta di déjà-vu involontario.
La bicicletta è il mezzo più importante e divertente con cui guardare una città; dopo i piedi naturalmente! Ma, per me, è l’oggetto del ricordo.
Mio nonno aggiustava bici e grazie a lui ho imparato subito a usare le due ruote. E non mi hanno mai più abbandonato.
La bicicletta mi ha accompagnato su e giù per i borghi e i viottoli da sempre: scuole dell’obbligo, università e lavoro; fughe, dolori e svaghi; bevute e aria che scivola sulla faccia, mattine sotto un cielo terso e dipinto e notti tarde e brillanti nel loro sfinimento umido. Così, la raccolgo dai meandri della mia memoria e la rimetto sull’asfalto, per vederla, libera, di riportarmi integre le sensazioni della città in cui vivo.
Esco velocemente di casa con mille pensieri per la testa e la prima cosa che faccio è quella di infilarmi fra i borghi del Centro, all’ombra di tutto, con le case strette sulla mia testa che mi nascondono dal sole e mi ritrovo nel famigliare garbuglio di vie e viuzze, caos e silenzio.
A volte quando attraverso Via Farini penso che sto percorrendo l’antico cardo romano, penso che nel 183 a.C. qualcun’altro ha posato i piedi esattamente dove io sto posando le mie due ruote. Vorrei sdraiarmi a terra e non muovermi mai più perché ho le vertigini.
I palazzi più belli sono proprio qui, nelle strade alle spalle del Palazzo Comunale: austere ville seicentesche e settecentesche che mi sorridono impassibili. Sbircio attraverso le inferriate o, furtiva, nel cavedio interno e mi sembra di sentire gli echi del vociare concitato degli intrighi dei padroni.
Il sole sempre a picco.
Io sempre di corsa.
Mi ritrovo in Piazza Garibaldi, calpesto il Foro Romano che riposa sotto il selciato, e, prima di attraversare la strada, mi fermo.
Guardo a destra: la Via Emilia.
Guardo a sinistra: la Via Emilia.
Il caldo, un rivolo di sudore, l’abbaglio e il rumore sordo delle cose di cui non vediamo la fine con gli occhi: in un solo attimo riesco a capire cosa volevano dire i CCCP con l’Emilia Paranoica.
Rincorro subito le ombre e corro in Via Cavour cercando di non calpestare nessun passante lento e molesto che fissa i ciclisti come se fossero animali rari ma soprattutto inopportuni.
Lo scorcio finale della via apre uno degli orizzonti più affascinanti, mai sazio di sguardi: la Piazza del Duomo e del Battistero.
Ogni volta penso all’Antelami e al Parmigianino: due pazzi leoni, due menti geniali che possedevano l’alchimia figurativa come se l’invenzione di ogni cosa fosse nelle loro mani callose, come un grande caleidoscopio numerico.
Nonostante la folla sia sempre numerosa davanti al Duomo, se, per qualche secondo, ci sediamo sui gradini della cattedrale e guardiamo il sagrato davanti ai nostri occhi, il silenzio ci ricopre come un soffice lenzuolo e possiamo forse pensare, finalmente, senza essere sentiti.
La bicicletta cigola: alt.
Rallento un po’ e attraverso Via Garibaldi.
Al Teatro Regio stanno facendo le prove dell’Otello di Verdi… sono alla fine dell’ultimo atto quando il Moro di Venezia implora Desdemona, ormai spirata, un bacio un altro bacio un bacio ancora.
Mi si stringe il cuore.
Lui e lei, la vita è più crudele della morte.
Alla sinistra del Teatro ecco la Pilotta, il palazzo di servizio della corte dei Farnese o la mia meta.
È vero! Non ho ancora detto dove sto correndo!
Sotto alle grandi volte del palazzo, “mangio” i gradini della doppia scalinata due a due.
Ce la faccio.
La temibile Biblioteca Palatina. Sento da lontano il profumo delle pergamene, degli inchiostri sbiaditi dei monaci, di codex mai sfogliati e dei milioni di libri che aspettano solamente una mano amica. E i passi dello sguercio: il bibliotecario.
«Aspetti! Aspetti! Nonchiudanonchiudanonchiudaaaa!!»
«Stiamo chiudendo Signorina!»
Gli lancio il libro: «Tenga. Restituzione. Sono in tempo.» Fatto.
«La prossima volta, Signorina, venga un quarto d’ora prima della chiusura.»
«Ma sono le 17.30. Voi chiudete alle 18.00!»
Infastidito. «Appunto, Signorina.»
Sbam!
Ce l’ho fatta!
Il mio destriero fedele non cigola più.
Attraverso il Parco Ducale, fra il profumo di erba tagliata e finta salsedine del laghetto, fra i platani e le violette di Maria Luigia e il lumino evanescente che mi immagino aleggiare sopra il Tempietto d’Arcadia.
Sbuco nell’Oltretorrente Rivoluzionario, col naso all’insù, proteso e pronto ad assaporare rumori e profumi.
Il sole calante e il fresco ritorno della sera volgono uno sguardo su Via D’Azeglio: studenti, mamme, papà, anziani, africani, cinesi, arabi, sudamericani, indiani; un miscuglio di aromi e culture che adoro. Che mi insegnano che ogni cosa può essere colorata non solamente con un pennello.
Ultima tappa della giornata: l’©.
Nei primi anni del Novecento a Parma ce n’erano almeno cento: osterie di una volta con i tavolacci, le polpette, il vino a volte buono a volte balordo, osti cicciotti e rossi in viso, ostesse generose e avventori urlanti. Ne sono rimaste poche, ma la passione nelle persone brucia ancora.
Anche oggi qualche amico con cui condividere il rito di un bicchiere di vino c’è in ogni locale.
Parcheggio la mia bicicletta da qualche parte, mi siedo dal mio oste preferito e ordino una bacca rossa e ferma.
Prosit. Al calare di questo sole.