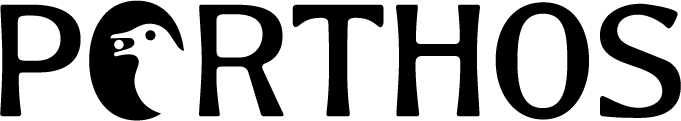29 Nov Il Chianti, tra toscanizzazione risorgimentale e supertuscanizzazione post-moderna
Sul prestigio dell’“invenzione” di Ricasoli si fonda l’estinzione di molti degli 87 vitigni toscani descritti un secolo prima da Perrin[3], Gallesio[4] e Malenotti[5]. Ma nonostante questi sforzi e le lotte degli anni ’20 per accaparrarsi il diritto al toponimo “Chianti”, la viticultura non riparte con lo slancio che aveva avuto ai tempi del Barone e la regione torna ad essere una delle più arretrate d’Italia. Poi tocca alla guerra e alla ricostruzione cui conseguono piano Marshall e boom economico, tramonto (formale) della mezzadria e spopolamento delle campagne.
Già nell’800 c’era chi aveva avvertito tutta l’arcaicità di un sistema socio-economico vecchio di quattrocento anni. Ma in pochi avevano operato per un superamento senza traumi, nell’ottica di una rinnovata produttività. Nel secondo dopoguerra, l’anacronismo della mezzadria esplode con tutte le sue contraddizioni. Innanzitutto, gli ex-mezzadri non detengono un capitale sufficiente ad acquistare dai padroni le terre su cui hanno insistito per secoli, nemmeno se in svendita: la condizione del proletariato contadino toscano novecentesco è del tutto dissimile da quello della borghesia contadina langarola ottocentesca; e il miracolo dell’acquisizione delle cascine/poderi da parte di chi le lavora, in Toscana, non si replica. In meno di quindici anni, dal 1951 al 1964, si perde un patrimonio di saperi legati all’agricoltura e alla viticoltura particolari e si crea una frattura storica insanabile, che si concretizzerà definitivamente con la seconda fase immigratoria tra il 1964 e il 1981 che è quella dei “foresti”, degli stranieri (inglesi, svizzeri, tedeschi), dei settentrionali (lombardi e veneti), dei toscani di città (Firenze, Prato).
La nobiltà terriera, infrantosi quel sistema che per secoli aveva legato il capitale cittadino all’agricoltura mezzadrile – anzi questi due elementi si erano sostenuti e rispecchiati l’uno nell’altro – da decenni non era più in grado di mantenere integro il proprio patrimonio latifondiario. Si trova così costretta, negli anni ’60, a parcellizzare ulteriormente e svendere.
Tutti inizialmente interessati a fare di questo pezzo di Toscana solo un luogo di vacanza, col tempo – e con una visione imprenditoriale molto consapevole e quindi poco chiantigiana – questi piccoli e grandi capitalisti alloctoni, spinti anche dagli incentivi derivanti dai Piani Verdi e FEOGA[6], che stimolano l’impianto di vigneti specializzati un po’ dovunque; ben presto si dedicano alla viticoltura e all’enologia. E lo fanno nelle due uniche maniere che sono allora possibili:
1) utilizzando gli unici cloni di Sangiovese omologati fino a quel momento (biotipo R10 toscano e, soprattutto, R24 romagnolo – d’altronde, è solo indicazione di questi ultimi anni quella di ricercare, attraverso selezioni massali sicure, un germoplasma autoctono di grande varietà allo scopo di aumentare la biodiversità aziendale, che nel vino non rappresenta solo una fascinazione ecologica ma, più concretamente, un volano di aromi);
2) guardando al modello francese (bordolese) e, soprattutto, californiano che, in quegli anni, sta vivendo una enorme espansione tecnologica e guadagnando quote di mercato crescenti.
Contemporaneamente, avviene la rivoluzione bolgherese, ovvero il lancio sul mercato (1968) del Sassicaia di Incisa della Rocchetta e Giacomo Tachis: Cabernet Sauvignon e Franc a fare da apripista (ai successivi Merlot e Syrah) e, soprattutto, uso delle barriques
[3] Giorgio Perrin, ricco commerciante svizzero del cantone di Vaud e possidente in Toscana, dal 1821, della fattoria di Petrolo a Montevarchi. In quegli anni inizia una lunga serie di ricerche ed esperienze di varia natura nella Valdarno Superiore e in Chianti, a seguito delle quali individuerà nella sola Val d’Ambra 23 diversi vitigni. Per la verità, Perrin incentiverà la riduzione del patrimonio ampelografico dell’areale suddetto a favore di pochi vitigni, fra cui Sangiovese e Canaiolo. Per le sue caratteristiche aromatiche, quest’ultimo viene identificato da Perrin come la “base” per il confezionamento di vini fini simili a quelli di Bordeaux o di Borgogna.
[4] Giorgio Gallesio (1772-1839), viene da molti considerato come la prima figura di enologo moderno. Tecnico preparato e accurato, interveniva su tutto il processo produttivo, dalla singola vite alla cantina, dalla vinificazione alla commercializzazione. Fu autore della memoria Sui vini e del modo di migliorare i vini toscani, presentata all’Accademia dei Georgofili nel 1839, e molto apprezzata fra i vari proprietari toscani. Partendo da una classificazione qualitativa del vino toscano, Gallesio fissava l’obiettivo dell’enologia regionale: ottenere prodotti concorrenziali con la Francia. Chiedendosi il perché della scarsa qualità dei vini toscani, Gallesio compilò un catalogo di pratiche viticole ed enologiche, cui non sfuggì anche l’estrema varietà ampelografica regionale che, assieme alla coltura promiscua, anch’egli considerava un ostacolo.
[5] Il Canonico Ignazio Malenotti, pievano di Montauto e proposto di san Gimignano, fu autore nel 1815 di un catalogo su Viti e vigne toscane, in cui identificava e descriveva 87 diverse varietà regionali di uve da tavola e da vino. Quest’ultime sono la stragrande maggioranza e per quasi tutte viene suggerito «mescolata con altre specie di uva nei vini scelti li dà eccellenti», a ribadire la vocazione da taglio della viticultura toscana. Autorevole eccezione è il Sangiovese il quale «fa un vino potente, ma in principio acerbo, che, col tempo divenuto eccellente e durevole, può mandarsi in lontani paesi».
[6] Si tratta di programmi di interventi finanziari pubblici, volti allo sviluppo dell’agricoltura nel quinquennio 1966-1970, con particolare riferimento alla viticultura. Di fatto si puntava alla costituzione di nuovi impianti di vigneto specializzato in sostituzione del promiscuo. Il Piano Verde 1 e 2 e FEOGA (Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola) costituirono una iniezione di capitale nelle aziende agricole grazie a due contributi in conto capitale pari al 50% della spesa (25% di provenienza CEE e 25% dallo Stato italiano). Gli effetti in Toscana sul lungo periodo (1975-1983) oltre all’impoverimento ampelografico e genetico dovuto alla scarsità di cloni reperibili, furono: reimpianto di 12.000 ettari a fronte di un’estirpazione di oltre 14.200 ettari; nessun reimpianto della coltura secondaria consociata venne costituito mentre vennero estirpati 25.000 con sistemi in promiscuo, il 70% dei quali in terreni collinari vocati. A livello nazionale, la superficie reimpiantata rappresentava il 6,5% e le estirpazioni oltre il 9%. Altre conseguenze furono: rimodellamento dei versanti collinari e compromissione della stabilità di superficie; utilizzo esclusivo del rittochino anche in pendenze notevoli, con aumento dei fenomeni di dilavamento; diffusione virale per l’utilizzo di un numero limitato di cloni; portinnesti omologati e non diversificati; impianti a sistema di allevamento rivolti alla meccanizzazione con conseguente compattamento dei suoli; aumento quantitativo a scapito della qualità.
.