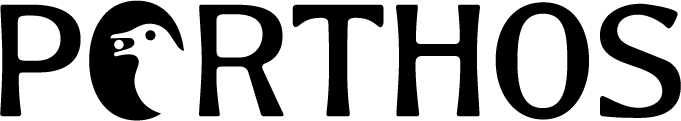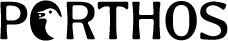18 Mag Aldo, il silenzio del Vinsanto
Sei anni dopo. Mille situazioni sono cambiate, i lavori, le amicizie, il numero di figli. Con Guido non è cambiato nulla: non condividiamo più lo stesso lavoro, ma continuiamo a bere insieme, a coltivare la comune passione per il vino, i funghi e gli asparagi. A condividere i Barbacarlo. Con tutto quello che si portano dietro.
La cosa del vino, io l’ho presa più di petto. Guido, che è pazzo, di quella pazzia sana che ti apre il mondo, ha un carattere più gioviale. Un travolgente modo di stare con le persone. Guido conosce tutti, Guido è dentro le cose, Guido è una scheggia attivata dall’entusiasmo.
Solo a volte, quando serve un’ispezione nell’ignoto, chiama il “nero”, chiama l’esorcista. Chiama me. Sarà il 6 o il 7 pomeriggio, squilla il telefono. «Marco, ascolta: ho mangiato un salame incredibile. A casa di Alvaro e Nadia, roba mai sentita. Te lo giuro». E insomma, detto a un umbro, che possa esistere ancora del maiale insaccato che ti sorprende, suona come una sveglia. Detto da Guido poi, suona forte davvero. «E poi, insomma, mi hanno fatto assaggiare, diciamo che Nadia mi ha spinto, un Vinsanto che fa Aldo, il papà. Secondo me è buonissimo. Io l’ho guardata: cercava conferme su questo vino. Come se volesse avere contezza di un’intuizione, di un presagio che conservava chissà da quanto. Te la faccio breve: le ho detto che avevo un amico che era “in mezzo al vino” e, se voleva, potevamo organizzarci per assaggiarlo e levarle questa curiosità. Che dici?». Maiale, Vinsanto, Spina, Guido, storie di famiglie nascoste. Naturalmente dico «quando?».

Novembre 2015
«Ci vediamo alle 19 e 30 al bar di Spina. Andiamo ad assaggiare il vinsanto». Arrivo, porto una bottiglia per la generosità dell’invito. Non ho chiaro a cosa servirà, non so nemmeno dove stiamo andando, perché Guido mi ha travolto con un sacco di storie sue (lavoro, famiglia, ricostruzione, politica) e alla fine non ho capito niente di quello che sta per succedere. Fatto sta che arriviamo in piazza: birretta al bar di Spina, battute di quint’ordine, prese per i fondelli di rito. Macchinette che suonano e s’illuminano, televisioni con improbabili programmi di caccia. Campari. Noccioline. Sigarette. Insomma tutto l’armamentario tipico di un bar italiano. Vero. Nel bene e nel male.
Usciamo. Si costeggia il castello, praticamente vuoto e pieno di impalcature. Un’ombra nera, che sibila di venti vuoti. Miagolii di gatti dentro l’abbandono. Il rumore indimenticabile di ogni passaggio da queste parti. Il ricordo del terremoto. E dei problemi della burocrazia. Della sospensione delle quotidianità. E della loro reinvenzione. Arriviamo nella parte “nuova” della frazione, quella che ha retto al terremoto più del vecchio castello e che, nonostante i disagi, è tornata velocemente in piedi. Alvaro, il marito di Nadia, ci accoglie dalla terrazza. Con il suo sorriso largo, generoso, caldo: è un uomo forte, è uno che trascina e solleva, alleggerendo tutto. È un uomo vulcanico. Energico. Quando apre la porta di casa ci porta subito in cucina. Ridendo. Si vede che ama stare insieme alle persone. Con le persone. Che non ha ombre nel contatto. Nadia sta asciugando qualche stoviglia. Ci presentiamo. Nadia è il cuore del sistema solare. Si capisce subito che lei detta ritmi, tempi, spazi. Per la famiglia, per il divertimento. Per suo padre, per suo marito. Per i suoi figli. Per i suoi nipoti. Nadia è il diapason di questo avamposto che scalcia contro l’effimero. Non per vezzo, naturalmente, ma per destino. In tivù suona, come un pezzo punk, la voce di qualche talk show italiano del pre-cena. Il tavolo, al centro della cucina, è apparecchiato come fossimo a un banchetto in onore del maiale: Capocollo, Prosciutto, Salame. Tutti già affettati, con le riserve pronte per continuare, se dovesse servire. Insalata in grande quantità. E una teglia di melanzane grigliate. Un paio di bottiglie di vino, mi sembra di ricordare un bianco e un rosso. Un profumo magnetico di lievito, colla e marsala che attraversa la stanza. Odori antichi, senza essere retorici. Sono ancora i nostri. Stanno lì, senza essere una pubblicità del tempo che fu. Sono semplicemente quello che siamo. Gente integra. Maledetti tutti ho pensato. Maledette voci da circo, ma non l’ho detto. Al solito.
Dietro ad un piccolo boccale di birra, riempito a metà di vino, stanno gli occhi di Aldo. Fissi. Spalancati. Infiammati. Meravigliati ma silenziosi. Come lo saranno sempre a ogni nostro nuovo incontro. Non immaginavo ci sarebbe stata una cena, né addirittura che saremmo stati invitati a mangiare insieme a tutta la famiglia schierata. Al sacro invito è vietato resistere.
Il capocollo è buonissimo. Il prosciutto è semplicemente straordinario («una scrofa da 300 kili», dirà Alvaro con il sorriso di chi sa come tirare fuori qualche buon miracolo da una vecchia fattrice allevata solo a ghiande. Ah, senza spacciarli per prodotti della divinità, naturalmente).

Al salame, però, abbiamo cambiato sport. Ricordo i primi viaggi nel Collio, il corridoio di Stanko (che la sua anima riposi in pace) e i salami meravigliosi in affinamento.
Mi sembrava, nel Collio, di aver trovato una maestria nel salame che noi, norcini ab origine e quindi stanchi, dimentichi e presuntuosi, avevamo perduto. Come se sua maestà il prosciutto completasse tutto il sapere. La solita, ignorante forma di snobismo, tutta contadina. Ma il salame di Alvaro è di gran lunga il più buono che io abbia mai mangiato. Un salame di un tempo che forse non c’è mai stato. Scuro, tosto, saporito, stagionato quello che serve, senza eccessi da stadio, rivelato come fosse una semplice quotidianità. E invece è lì, profondo, quasi fegatoso, leggermente acidulo, con quella pasta tagliata grossa, con il grasso disegnato da un orefice mentre si fa un trip con l’ossigeno. Alvaro, nel silenzio continuo di Aldo, misterioso signore di novant’anni che osserva dei pazzi mangiare come non lo avessero mai fatto, mi svela che l’arte l’ha imparata «da quel signore là, quello che non parla». Ricevendo da Aldo un semplice sospiro. Immagino fosse soddisfazione, mostrata anche con l’ausilio di un sorriso a mezza (a un centesimo della) bocca. Insomma, è tutto poco chiaro. Aldo parla pochissimo. Aldo ascolta. Scruta se i vichinghi in visita, che mangiano e bevono, mentre parlano di mangiare e di bere come fossero posseduti, facciano in qualche modo al caso suo. Se siano veramente in grado esorcizzare un pezzo della bestia. In particolar modo guarda me: Guido e Alvaro parlano fittamente, roba di partito, di conoscenze comuni. Rimango io, senza appigli dialettici, sotto l’ecografia di Aldo, sotto quel silenzio poco monacale e tutto saldato per terra. Io che cerco, con grazia inopportuna e premure non richieste, di strappare informazioni. Per fortuna è Nadia che allarga il racconto: lei, da una sillaba di Aldo, fa la frase con tutte le subordinate e le suggestioni. Quello che ho ascoltato è il racconto di Nadia. I mozziconi di Aldo sono stati briciole, anche se vibranti come esplosioni di pianeti lontani nel nostro cielo.
C’è acume nello sguardo di Aldo. L’intelligenza delle cose. C’è un modo onesto, ma secco, di dirti, io so. E non so se tu ne sai abbastanza. Ed è per questo, credo, che alla fine ho smontato il castello con una domanda idiota come «ha avuto una vita felice?». Perché novant’anni, la fatica, le crepe del dolore, l’alfabeto della sopravvivenza, tutto poneva, evidentemente, Aldo a cento chilometri sopra di me. Ho fatto ciò che non si fa, ma Aldo ha svelato un pezzo grosso della sua anima.
Quella sera a cena un lampo è uscito da una cosa dall’apparenza banale. Assaggio le melanzane, normali melanzane grigliate; Nadia, le aveva condite con semplici olio e sale… poi sopra aveva versato un aceto che sembrava un aceto tradizionale per intensità e densità degli odori. Ma il sapore! oddio il sapore… Così ricco, lungo e generoso che la mia testa stava correndo verso qualche residuo di dispensa di Vinsanto versato lì sopra, per caso. Qualcosa che non spiegavo. Una ricetta di casa? La parte acida era così delicata, così dentro alle fibre del gusto, così annodata agli aromi, che ho dovuto chiedere a Nadia cosa fosse quella meraviglia. Era da quella teglia di alluminio che usciva l’odore di frutta secca, di colla, che invadeva tutto lo spazio. Si scopre che sopra c’era l’aceto di casa. Un aceto sopraffino, non un liquido per appassionati dei fraseggi, una cosa magica, da antri di cantina, da viaggio nella storia. Questa roba al pari del salame ha semplificato tutto. Ha chiarito il perché. Ha illuminato la ricerca.
Durante la serata, Nadia, custode preziosissima del padre, dei suoi ricordi, della sua stanchezza, ripeteva che rarissime volte il Vinsanto lasciava la cantina. Aldo aveva una ritrosia inspiegabile, faticosa per gli altri, lo destinava solo per ricevere le persone speciali. O per omaggio regale, nei giorni di festa comandata. Questo significava che, quando Aldo, sarto da uomo, accoglieva alcuni dei suoi migliori clienti in casa per consegnare i vestiti o quando c’era qualche cerimonia, allora si proponeva un bicchierino, piccolo, a celebrare il non detto, ma il dovuto. E poi la bottiglia spariva. Chissà dove.
Senza il terremoto, mi racconta Nadia, senza quella rivoluzione nella loro vita, non avrebbe mai avuto l’esatta percezione di cosa potesse esserci in quella cantina.
La sera del nostro primo incontro, alla fine della poderosa abbuffata, decidiamo che è giunta l’ora di andare ad assaggiare il vin santo. Non avevo intuito fino in fondo la rilevanza di questo momento per loro, finché non li ho visti alzarsi, tutti. Era tardi, per gli umani. Prendere i preziosi bicchieri del servizio “buono” nella credenza, vestirsi, e salire al freddo della macchina per portarci alla Pieve. Lì sono entrato per la prima volta a contatto con la speranza. Con l’attesa. Con la bestia.