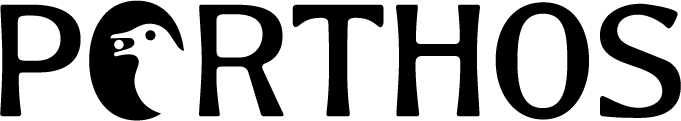15 Gen L’intervento a Castelbuono
La seconda parte del mio intervento è stata dedicata alla superiorità dei vini ottenuti da viticoltura biodinamica.
Nei due convegni su vino e biodinamica organizzati da Porthos ho cercato di addurre testimonianze ed esperienze scientifiche ma, trattando il liquido odoroso, non è stato facile. È un problema storico, perché la misurazione scientifica degli effetti dell’agricoltura biodinamica sul vino ha una tale quantità di variabili da scoraggiare ogni tentativo. Per questo molti produttori ci hanno messo un po’ a capire come cambiava il loro prodotto, dovevano cambiare il punto di ascolto sensoriale. Quando non è stato più sufficiente calcolare e misurare con i parametri che erano stati impartiti negli ultimi trenta, quarant’anni, è stato necessario recuperare una sorta di lettura alternativa, che facesse sempre appello ai nostri sensi ma che non fosse bloccata da uno schema statico. Essendo stato educato all’AIS, ho vissuto gli insegnamenti degli enologi. Avevano tutti bisogno di mettere punti fermi e dare certezze, il che, almeno nell’intenzione, era nobile. Ma qual’è stato poi il problema? Questo tentativo non era più solo un mezzo per conoscere il vino, ma divenne il cuore stesso della lettura del liquido odoroso, costringendo quest’ultimo a ruotare attorno alla descrizione. È come se avessimo trasferito l’onere della prova: non era più la descrizione a modificarsi con la trasformazione del vino, ma il vino doveva adeguarsi alla lettura. A un certo punto qualcuno ha cominciato a dire che il vino doveva essere in un dato modo, ma il vino non può, non deve conformarsi alle idee o ai desideri di chiunque. Non è un caffè: «Me lo faccia più corto, me lo corregga…». A Roma frequento un bar dove basta aspettare quindici minuti e s’imparano dodici tipi diversi di cappuccino. Il vino non è così, deve rispettare la vocazione del luogo, la storia e la stagione.
Il vino, inoltre, è sempre stato edonistico, anche quando era soltanto agricolo, contadino; ci sono testimonianze scritte, non è un semplice passaparola. Quando era soltanto alimentare, erano brutti momenti, come quel periodo in cui a Roma veniva bevuto al posto dell’acqua allora inquinata dal piombo e velenosa.
Trovo fondamentale che non si possano spacciare i difetti per genuinità, anche se era quasi inevitabile che succedesse. Me ne sono reso conto quando ho cominciato a occuparmi di vini naturali e ho conosciuto produttori che li facevano già dagli anni settanta. Si trattava quindi di persone che avevano già fatto esperienze ed errori. Mi accorsi che il livello della qualità era alto e di conseguenza anche la correttezza tecnica. È molto espressivo il concetto del non “spacciare”; tra i produttori che hanno intrapreso la coltivazione naturale, biologica, o eventualmente biodinamica, ognuno ha la sua ricetta personale. Tale interpretazione è interessante, poiché si stanno facendo molti errori e, purtroppo, c’è sempre qualcuno convinto che sia meglio un vino genuino, anche difettoso, rispetto a un vino convenzionale. No! La superiorità sensoriale dei vini naturali non passa attraverso questo, non riguarda il difetto. Se così fosse, sarebbe meglio bere acqua.
La superiorità sensoriale è riconducibile a tre punti fondamentali. La biodinamica garantisce una maggiore vitalità del luogo, una vera interazione con tutto ciò che circonda l’ambiente del vigneto. Assaggiando la frutta ottenuta in biodinamica, come le fragole, ci si accorge proprio della sua superiorità sensoriale, manifestata da un gusto ricco e profondo. Ogni vino, ottenuto da un’agricoltura seria e vinificato in maniera spontanea, ha alla base delle uve sane. Molti vini naturali sono difettosi, poiché il produttore porta in casa uva poco buona. In un mio articolo intitolato «Forma e sostanza», evidenzio i due concetti inscindibili di una bevanda come il vino. Nessun altro prodotto amplifica così tanto il potere di un luogo. È il luogo attorno al quale gira tutto quanto. Un vino buono deve essere magnetico, interessante, deve farsi ricordare, può chiamarsi Brunello di Montalcino, Prosecco di Valdobbiadene, Grillo di Marsala, per citarne alcuni. Un vino buono ha queste caratteristiche.
Il secondo elemento è la sintonia con il cibo. Il terzo è la digeribilità. La bellezza della fermentazione spontanea è che ogni particella, ogni tessera di questo mosaico ha la sua posizione; lo dimostrano le prove di cristallizzazione sensibile. È come se ci fosse un ordine. Si fa l’analisi e ci si accorge che, se le prendessimo singolarmente, le potremmo considerare un difetto, un limite, invece appartengono a un unicum. Cosa chiede un vino buono? Un po’ di tempo e che la persona che lo avvicina non si fermi di fronte a quella che potrebbe essere solo una sua iniziale reticenza.
Veronelli predicava una cosa fantastica, che il vino si concede soltanto a chi, oltre che al corpo, è disponibile a cercarne l’anima. In questa lettura poetica, non si può dimenticare che Richard Feynman, uno dei più grandi scienziati del Novecento e straordinario divulgatore, sosteneva che i poeti sono sempre in anticipo di una decina d’anni rispetto agli scienziati. È come se attraverso la poesia potessimo intuire delle decifrazioni scientifiche. Per questo la varietà espressiva dei vini ottenuti da agricoltura biodinamica non si può riassumere con parametri troppo semplici, nell’assaggio occorre fare uno sforzo personale, entrare in contatto, essere disponibili ad accogliere più che a pretendere. La bellezza del vino e degli alimenti può essere colta se si ha la capacità di recepire questa diversità controllando i propri pregiudizi – vivere valutando senza preconcetti è impossibile. Si deve ricevere pensando che in quel momento ci si nutre. Il bicchiere è il terzo luogo di nascita del vino; è dunque un momento, un luogo di grande verità. Se un vino inizia con degli odori grevi, che continuano anche dopo due o tre minuti, anzi si esasperano, non c’è niente da fare. Può essere il vino più genuino e biodinamico della Terra, fatto anche da San Francesco d’Assisi… Quei minuti iniziali vanno considerati. Parlando di macerazioni e ossidazione, sono fondamentali la ricerca scientifica e la competenza del produttore, che magari ancora non sa come dialogare con l’aria. Conosco molto bene i vini di Barraco e, avendo assaggiato tutte le prove dei primi anni 2000, posso dire che all’inizio qualcosa non funzionava, ma il suo processo di conoscenza, fatto di errori e intuizioni, gli ha permesso di migliorare e arrivare a produrre tra i vini più buoni dell’intero panorama enologico. Il cittadino consumatore che si rivolge al vino cercando emotività, coinvolgimento e la restituzione del luogo, prima avrebbe bisogno di una lezione per imparare a sentire attraverso i vini. Non è così scontato, non si tratta solo di profumi minerali. La lettura del vino va fatta istruendo e coltivando la propria soggettività. Bisogna mantenersi individui soggettivi nei confronti dell’assaggio e non pensare che quello che abbiamo imparato finora sia definitivo. È necessario essere disponibili ad ascoltare. Solo allora la varietà e la persistenza arriveranno alla nostra bocca, poiché la bocca è la prova definitiva per un vino naturale.
La lettera di Carmelo Corona, presente alla tavola rotonda a Castelbuono